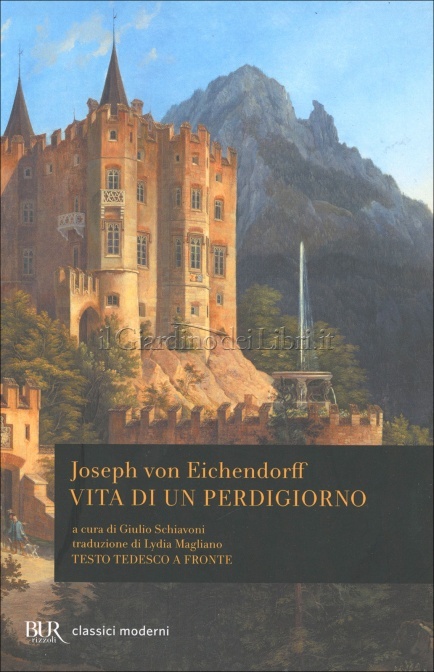 Vita di un perdigiorno
Vita di un perdigiorno
Rizzoli
1976
9788817120906

“Vagai tutto quel giorno. Il sole già splendeva obliquo fra i tronchi, allorché sbucai finalmente in una valle prativa, circondata da monti e costellata di fiori rossi e gialli, sui quali svolazzavano innumerevoli farfalle nell’oro del tramonto. Il luogo era talmente solitario da apparire migliaia di miglia lontano dal mondo. Solo i grilli stridevano; un pastore, seminascosto tra l’erba alta, traeva suoni tanto malinconici dalla zampogna da far dolorare il cuore di nostalgia. «Guarda che bella vita tocca a un distillaccio simile!» pensai. «Altro che noi poveretti, che dobbiamo andare in giro lontani da casa, sempre in pericolo!» Poiché un fiumicello limpido ci separava, gli gridai da lontano dove si trovava il villaggio più prossimo. Senza scomporsi, sollevò appena la testa sopra l’erba, m’indicò con la zampogna l’altro bosco e si rimise a zufolare”. (cap. III, p. 111)
Quel che probabilmente più affascina e diverte il lettore contemporaneo, a circa duecento anni di distanza dalla prima pubblicazione di questa “Vita di un perdigiorno”, è la sublime negligenza d’ogni impegno – civile, etico o estetico.
Il protagonista della vicenda, narratore in prima persona, è un giovinastro che sembra non attendersi altro che stupore e meraviglia dall’esistenza: e che risente, invariabilmente, di qualsiasi intoppo – non dico delle difficoltà – che incontra sul suo cammino, patendone indicibilmente; e che tuttavia ha un naturale talento per l’imbecillità e l’oblio, e dunque rimedia senza colpo ferire alle lacrime versate, semplicemente attendendo la correzione della rotta del destino. Perché è un destino che non può tradire: può distogliere il vagabondo dalla quiete e dalla scanzonata e idillica contemplazione della natura e della bellezza, illudendolo d’averlo abbandonato nella tristezza e nella malinconia dell’isolamento; ma sempre provvisoriamente.
Il barone Joseph von Eichendorff, discendente da una famiglia della piccola nobiltà terriera, decaduta e compromessa, originaria della Slesia Superiore, scrive “in una Germania ancora atomizzata (orientata sul modello dell’assolutismo prussiano) in cui le strutture feudali stanno gradualmente tramontando per far posto all’industrializzazione e al processo di razionalizzazione” (G. Schiavoni, “Eichendorff e l’«idillio» lacerato”, p. 15).
In sostanza, il barone von Eichendorff è condannato alla nostalgia d’un tempo in cui non era l’avidità e la volgarità borghese ad avere potere, ma la corruzione e la noia aristocratica a dominare; ha perduto patria e benessere, e vaga per l’Europa senza dimenticare la quiete e lo stile delle sue origini. Del clima della decaduta aristocrazia del suo tempo, e del disorientamento legato alle trasformazioni sociali e statali, si percepiscono segni – l’incapacità di solcare altra profondità che non sia la superficie, la tensione all’idolatria d’un perduto tempo, d’una compromessa armonia.
Il protagonista del suo libro si presenta stropicciandosi gli occhi assonnati, seduto sulla soglia di casa. È primavera. Il padre, stanco di mantenerlo, l’accusa d’essere un buono a nulla: ferito nell’orgoglio (oppure: finalmente estenuato dalla sua stessa indolenza), il giovinastro decide immediatamente di partire, libero, per il vasto mondo. In tasca ha qualche quattrino; con sé ha il suo violino. Quanto basta per vagabondare, con un’eterna domenica nel cuore, alla volta di Vienna e di Roma: suonando e cantando, in attesa d’essere salutato dalla generosità del destino. Così, per via d’una serie di fortunosi incontri – a partire dalle due dame che gli sorrideranno, a bordo d’una carrozza da viaggio, vinte dalla dolcezza del suo canto, fino ai sedicenti pittori italiani Guido e Leonardo – il nostro perdigiorno si troverà, tra una lirica e l’altra, a vivere in una realtà da sogno, signore servito e riverito d’un castello. In sostanza, terminerà la sua esistenza come il suo creatore l’aveva intrapresa: nella quiete e nell’ozio propizio alle arti e agli studi.
È un perdigiorno che si sposta con una facilità irreale da una nazione all’altra: semplicemente assopendosi, o – in un certo senso – desiderando d’esser altrove. Il libro tende a non rispettare nessun canone realistico: questa “Vita di un perdigiorno” è una deliziosa e grottesca fantasia d’un aristocratico malato di nostalgia e intriso di spirito romantico, amabile nelle descrizioni della natura e dei sentimenti ed encomiabile per il suo distacco dalla contemporaneità.
Riconosciamo l’irritazione e l’amarezza che devono esserne fonte: ma non ne percepiamo segno nel libro. Libro che si distende costringendo al sorriso, solare e leggero come appare, come il sorriso d’un adolescente. Forse il barone Joseph von Eichendorff era incapace d’altro risentimento che non fosse satirico, o goliardico; o forse, quel che più desiderava era questa docile ingenuità, questa capacità di meravigliarsi e di stupirsi e di soffrire – ma senza deprimersi – d’ogni cosa.
Il suo perdigiorno non agogna denari, né fortune: sembra pago d’aver denaro per una minestra e per il vino, e non può importare essere giardiniere o daziere; conta poter sbirciare la bellezza della propria bella al mattino, mentre canta al davanzale o si dedica ai suoi fiorellini; conta non sentirsi povero e beffeggiato di fronte a lei, per non precipitare in un pianto tenero e sconsolato tra i fili d’erba. Conta meditare a proposito della saggezza popolare, e dei proverbi, trattandoli quasi fossero meditazioni filosofiche; e sentirsi incredibilmente assennato e profondo, soltanto richiamando alla memoria un discreto numero d’essi.
Perfino gli accessi di malinconia rivelano un retrogusto tanto intriso di grazia e di infantilismo da apparire naturalmente grottesco: «Adesso lei sta ballando» pensai, appollaiato sull’albero «e certo ha dimenticato me e i miei fiori. In mezzo a tanta letizia non c’è un’anima che si ricordi di me. Così mi succede sempre e dappertutto. Ciascuno ha il proprio cantuccio assicurato sulla terra, un focolare acceso, una tazza di caffè, la moglie, il bicchier di vino la sera, e vive contento; perfino il portiere si trova a proprio agio nella sua pelle, lunga com’è. Io non mi trovo a mio agio in nessun posto; come se arrivassi dappertutto troppo tardi, come se la mia presenza non fosse stata calcolata in questo mondo». (cap. II, p. 89). E questa è filosofia, per il perdigiorno: acme del male di vivere, e dell’abbattimento.
Da un libro come questo ci si può attendere un sorriso, e la rivelazione della perduta grazia dei Romantici: la melodia dell’innocenza, del divertissement letterario, della sublime negligenza di chi ha decifrato il segreto dell’esistenza e vuole rivelarlo giocando. Thomas Mann asseriva che questo libro fosse “tutt’altro che ben educato”, e che non avesse “la minima consistenza, la minima ambizione psicologica, né volontà critico-sociale, né rigore intellettuale”: che non fosse che “sogno, musica, un continuo lasciarsi andare, un suono continuo di un corno da postiglione, voglia di lontananze, voglia di casa, cascate di bengala in un parco notturno, beatitudine un poco folle (…)”.
È il libro del parossismo dell’ozio, e del vagabondaggio: fiabesco e sinceramente reazionario, è ovviamente adorabile.
“Den lieben Gott lass’ ich nur walten; / Der Bächlein, Lerchen, Wald und Feld / Und Erd’ und Himmel tut erhalten, / Hat auch mein’ Sach aufs best’ bestellt!”
EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE
Barone Joseph Karl Benedikt Freiherr von Eichendorff (Lubowitz, presso Ratibor, Slesia Superiore 1788 – Neisse, Slesia 1857), romanziere, poeta e drammaturgo tedesco.
Joseph von Eichendorff, “Vita di un perdigiorno”, Bur, Milano 1997. A cura di Giulio Schiavoni. Traduzione di Lydia Magliano. Con le illustrazioni di Franz Stassen. Testo tedesco a fronte.
Prima edizione: “Aus dem Leben eines Taugenichts”, Vereinbuchhandlung, Berlin 1826. Il primo capitolo era già apparso nei “Deutsche Blätter für Poesie, Literatur, Kunst und Theater”, nn. 152-158, nel 1823.
Gianfranco Franchi, giugno 2004.
Prima pubblicazione: Lankelot.
