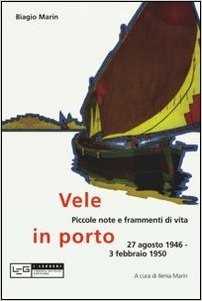 Vele in porto. Piccole note e frammenti di vita. 27 agosto 1946-3 febbraio 1950
Vele in porto. Piccole note e frammenti di vita. 27 agosto 1946-3 febbraio 1950
LEG
2012
9788861020719

Tra le massime espressioni della poesia italiana del Novecento, con Ungaretti, Campana e Montale, col triestino Saba e col livornese-monteverdino Caproni, l'artista gradese Biagio Marin, nato sotto bandiera austriaca nel 1891, morto quasi centenario nel 1985, nell'amatissima cittadina di Grado, è forse il meno celebrato tra i grandi lirici del Novecento, al di là del Veneto, del Friuli e della Giulia. È una buona ragione per consigliare la lettura di questo libro soltanto a chi già conosce e apprezza i versi di Marin: è sensato e saggio che s'accosti a pagine tanto personali soltanto chi ama la poesia di Marin, o al limite chi studia la storia giuliana – e del confine orientale, in genere – del secolo delle sette bandiere. Dico questo perché i diari di un artista contengono sempre – con qualche presuntuosa eccezione – qualcosa di particolarmente scomodo; quando per questioni estetiche, quando per questioni politiche, quando per questioni famigliari e diciamo così “tribali”, laddove per tribale intendiamo “di clan letterari”. Quando parla di questioni politiche, o quando cede alle rivalità letterarie, in queste pagine, Biagio Marin sa diventare lontanissimo dal poeta gentile, popolare e misticheggiante che abbiamo conosciuto, e di cui ci siamo nutriti. Diventa duro, livoroso, aspro; è un combattente e un patriota che non accetta nessuna sconfitta. L'esperienza estetica merita comunque, intendiamoci: scrivo questo solo per preparare a dovere il lettore.
Come forse saprete i diari di Biagio Marin sono, da qualche anno, in via di pubblicazione a cura della letterata Ilenia Marin; fresco di stampa, per la LEG, è “Vele in porto. Piccole note e frammenti di vita. 27 agosto 1946-3 febbraio 1950”; si tratta del terzo diario, il secondo a vedere la luce dopo “La pace lontana. Diari 1941-1950” [LEG, 2005; i quaderni 1942-1945 sono smarriti].
Siamo negli anni del Territorio Libero di Trieste: il periodo più complesso e doloroso della storia della Giulia. Quali sono gli assi portanti di “Vele in porto”? Le meditazioni, le angosce e le speculazioni sulla sorte della Giulia; la solidarietà nei confronti delle centinaia di migliaia di esuli istroveneti; l'antagonismo sacrosanto ma esasperato nei confronti dei comunisti, e dei marxisti in genere; la profonda spiritualità, e la dedizione a Dio; il dolore inconsolabile per la morte del figlio Falco, caduto al fronte nella Seconda Guerra Mondiale; la grande nostalgia per l'intelligenza del povero Scipio Slataper, e in generale l'amicizia per la famiglia Slataper. A puntinare le meditazioni del poeta Marin, congetture e considerazioni varie sull'estetica, una rancorosa e cattiva replica alle critiche di Giani Stuparich [si veda “Trieste nei miei ricordi”], episodica nostalgia per l'ordine e per la qualità della vita sotto impero austriaco, tanta amarezza per la pessima amministrazione italiana e l'attesa, veramente paranoica, di una terza guerra mondiale prossima ventura.
Biagio Marin si descrive così: “Quanto a me, io sono un popolano di sangue e carattere, ma spiritualmente e per sensibilità sono un aristocratico. Non sopporto l'odore del branco; odio la stupidità presuntuosa, petulante del volgo. Di fronte al singolo popolano, in quanto sia un uomo, mi trovo meglio che di fronte a un borghese che non sia un aristocratico” [29 novembre 1946, p. 31]. Qualche mese più tardi, il cinquantenne poeta parla della sua stanchezza esistenziale: “Spesso bramo la morte come riposo assoluto. Vivo una vita casta e regolare; dormo le mie ore, mangio bene, non sono turbato da grandi patemi d'animo, e mi sento mortalmente stanco. Da due anni e mezzo circa mi agito nella politica. Forse è qui la fonte del mio tedio, della mia stanchezza. Per far politica bisogna avere molta forza e grandi riserve nervose. Io non le ho e mi limo e un nonnulla mi squilibra” [7 aprile 1947, p. 61].
Questo passo è particolarmente autocosciente, come vedremo più avanti, quando vaglieremo le visioni politiche dell'indomito Marin. “Un nonnulla mi squilibra” è una frase particolarmente limpida. Il 9 dicembre 1947 Marin ribadisce: “Sono assai fragile – lo sono sempre stato – ma ora, evidentemente, l'età mi impoverisce in anticipo. In questi giorni ho pensato con simpatia alla morte. C'è troppo frastuono nella vita e io sono troppo esiguo di forza. Con nostalgia penso alla vita silenziosa delle piante solitarie in posti soli” [p. 129].
Già – semplici erano i sogni del grande poeta: “Vorrei avere una casa in provincia, con intorno alcuni campi di terra; vorrei avere nella mia casa la mia famiglia, le mie creature con i loro mariti e i loro figlioli. Vorrei poter lavorare in un ambiente umano consono alla mia anima e avere gioia della vita e bruciare per essa. Vorrei poter maturarmi alla morte per pienezza di esperienza, e amore di Dio. Vorrei vivere in armonia col mondo di Dio, e con Dio stesso, e risolvermi completamente in esso” [p. 132].
Non stupisce, insomma, che di lì a poco l'artista possa finire per trovare conforto negli scritti di Meister Eckhart: un mistico puro. 8 giugno 1948. "M'è accaduto questa mattina, di levata, di aprire un piccolo breviario di pensieri di Meister Eckhart, e di leggere, in uno stile meravigliosamente pacato e perciò suasivo: 'io dico, ed è vero: in ogni pensiero buono, in ogni buona opinione o buona opera che sia, noi, in ogni tempo, rinasciamo in Dio'. Ed è vero. Ché assurgere alla spiritualità è sempre rinascere in Dio. Solo che va notato che anche scrivere un bel verso è una buona opera, o dipingere sinceramente o musicare in genere, parole, colori, suoni che siano. [...]. Eckhart non ha preoccupazioni conformiste, esprime con coraggio la propria spirituale esperienza, e ciò me lo ha reso sempre così caro. [...] È di un abbandono, di una intimità commoventi [...]. È un religioso, non è un sistematico; è piuttosto un poeta religioso" [pp. 192-193]. Marin credeva che le più grandi rivelazioni fossero di sostanza poetica. E scriveva versi pensando che solo il “carattere poetico” potesse garantire eternità alle verità religiose.
**
Politicamente, il patriota gradese Biagio Marin era un liberale: naturalmente antagonista dei regimi totalitari, si considerava “aristocrate di cuore e di cervello”, ben distante dalla borghesia [“tutta istinto, come le masse operaie, istinto e malizia”] ma ferocemente lontano dalle masse [“Sprezzo e odio le masse: sono la negazione di ogni valore, di ogni umanità. Puzzano d'armento e mi causano orrore fisico”, p. 114]. Marin detestava la possibilità che l'umanità retrocedesse nell'inciviltà del dogma marxista: “L'ideale che muove le folle è quello della livellazione tra gli uomini, che si completa con l'esigenza di benessere. E il benessere finiranno per averlo, ma a prezzo dell'anima” [15 novembre 1946, p. 28].
E scriveva così: 17 febbraio 1947. “Ora vogliono il comunismo. È la schiavitù, ma la vogliono. Nessun bene ne verrà loro, ma non è il bene che cercano. Vogliono vendicarsi di non essere tra i fortunati, vogliono umiliare noi liberi, o quasi liberi, solo meno schiavi di loro. Tutto ciò che ha valore deve essere calpestato; la loro stupidità, la loro ignobiltà deve essere misura comune per tutti” [p. 57]. 16 settembre 1947: “Gli slavi sono fanatizzati dall'idea di dover portare la giustizia sociale nel mondo, e il marxismo come nuova forma di umanesimo. Io li sento barbari goffi, violenti e presuntuosi, e pur riconoscendo la loro vitalità biologica, non vedo che cosa, quale idea nuova universale possano propagare nel mondo. Che le nostre plebi si lascino sedurre dalla mitologia marxista mi offende, tanto è grossolana […]. Che avendo alle spalle secoli e millenni di cristianesimo, secoli di umanesimo, ci si possa buttare nel marxismo, mi sembra cosa veramente indegna, che profondamente mi offende” [p. 114].
Concetto ripreso il 2 dicembre 1948: “Credere che i tesori di 25 secoli di civiltà siano degni di essere buttati a mare, o almeno guardati con sprezzo perché prodotti da un'umanità che non conosceva la 'prassi' marxista, è veramente cosa da barbari. Il nuovo umanesimo pretende che l'essenza di una civiltà dipenda dalla modalità di produzione dei beni utili, materiali, e da quella della distribuzione degli utili” [p. 258].
Ancora, sempre 1948: “La dottrina comunista è idiota, la prassi è odiosa; ciononpertanto molti giovani si sentono attratti, proprio soltanto per bisogno di sgranchirsi le membra e fare le forze” [p. 162].
E infine, e con chiarezza ciclopica: “L'internazionalismo marxista è buono soltanto a sfaldare l'unità delle altre nazioni. La vittoria di Tito sulla monarchia, il suo prestigio fascinoso sui popoli jugoslavi, si deve innanzitutto al suo nazionalismo […]. Penso che la Russia ormai sia persuasa dell'errore politico commesso aiutando gli jugoslavi nelle loro pretese sulla Venezia Giulia. Trieste, anzi l'avventura di Trieste, alla causa comunista è costata cara. E costerà ancora. Se gli slavi avessero rispettati i nostri confini, l'Italia facilmente sarebbe entrata nella loro orbita e molte cose avrebbero potuto assumere un aspetto diverso. Per lo meno la Jugoslavia avrebbe potuto trovare in Italia aiuto di uomini e materiali, così s'è scavato un solco” [1 luglio 1948, p. 206].
Sono rilievi radicali ma molto lucidi. Da militante politico, più che da poeta mistico. Ma così triste era la tragedia della Giulia che d'un lirico il mondo aveva fatto un propagandista. Già, la Giulia...
1946. 15 ottobre. “La Giulia ci è stata tolta per darla in buona parte agli slavi e lasciare Trieste nelle mani dell'affarismo anglosassone. Noi abbiamo perduto, forse definitivamente, la Patria. La situazione umana è qui a Trieste tristissima” [p. 19]. 29 novembre. “I comunisti italiani hanno fatto di tutto e omesso di tutto perché la nazione non difendesse di fronte agli slavi l'italianità della Venezia Giulia. L'Istria è ormai perduta ed è dubbio se mai la riavremo; dico perduta non solo allo Stato italiano, ma all'italianità. E Trieste, se potrà reggere alla slavizzazione, sarà soltanto in grazia degli anglosassoni che, più male che bene, hanno impedito che Tito ci ingoiasse. Ché, se riusciva ad annetterci, si finiva tutti per crepare nei campi di concentramento e ai lavori forzati in Slovenia o in Croazia” [p. 30].
1947. “[...] La disinvoltura con la quale si tenta di disfarsi del problema della Giulia è veramente un sintomo di morte. Un quarto di secolo di nostra appartenenza allo Stato italiano non è bastato a dare agli italiani la coscienza dell'italianità di Trieste e dell'Istria, della loro appartenenza all'Italia” [p. 44].
15 gennaio 1947. "Gli italiani della Repubblica non sanno ciò che avviene nella Venezia Giulia; non sanno e non vogliono sapere, e si seccano se vengono comunque chiamati alla nostra tragedia. Si sta svolgendo in questi giorni il tragico esodo di Pola. Trentamila italiani abbandonano la loro terra, le loro case, la loro vita, per non dover soggiacere al dominio degli jugoslavi. E l'Italia non è presente, non li assiste, non provvede, se non in misura ridicola da far rivoltare. Per gli uomini politici questa è una grana; per la burocrazia romana peggio ancora. E quando questa gente sarà in Italia, non troverà certamente accoglienze fraterne, ma spesso si sentirà dire che avrebbero potuto starsene tranquilli a casa loro, felici di essere sotto il dominio di un popolo progressista. I comunisti sono particolarmente irritati che la nostra gente si senta tanto italiana. Il senso di questa tragedia sfugge al resto della nazione" [p. 46]
Marin sentiva così tanto la tragedia della Giulia – e la responsabilità di dover difendere almeno Trieste – che proprio nella vecchia città austriaca rimase a vivere, nonostante la nostalgia per Grado e per Gorizia, e per diverso tempo. Non amava Trieste, e sopportava male la vita cittadina. Ma voleva fronteggiare, come poteva, l'avanzata del comunismo: voleva combattere la propaganda comunista [10 febbraio 1947], lì sulla frontiera, e voleva dare sostegno a tutti i giuliani. Nel 1949, deprecando la “tragica presunzione” degli jugoslavi di voler possedere la Giulia intera, incluse Trieste, Gorizia, Monfalcone e Grado, ribadiva: “Sono schiavi della tirannide comunista, o forse nazionalsocialista di Tito; odi spaventosi fermentano tra loro; nondimeno, approfittando delle disgrazie nostre, continuano a strillare come forsennati che non rinunceranno mai alle 'loro' terre. […] Si scatena il più furioso e irresponsabile nazionalismo” [p. 281].
Ciò che più di tutto angosciava Marin era la sensazione che il sacrificio di oltre un milione di italiani, tra morti e mutilati, nel corso della Grande Guerra, fosse stato vano. La morte di Slataper, soprattutto, era vissuta come un dramma incalcolabile, e simbolico più di ogni altro. 4 maggio 1947: “La Giulia l'abbiamo perduta e, con lei, Trieste. Scipio dorme ancora, scolta vigile sul Calvario, ma è rimasto solo. I nostri morti che hanno fecondate le doline e le pietraie del Carso, attendono ora di essere riscattati. Giornata triste oggi a Trieste; giornata amara ad onta del sole. Le nostre bandiere che sventolano allegre dalle finestre nel borino della mattina nascondono il nostro lutto. Ai miei compagni caduti, il bacio della mia anima” [p. 79].
3 dicembre 1948: “Le rivoluzioni - tanto vantate? - mutano le strutture esterne della società, ma lasciano gli uomini allo stato di prima. Ma Scipio è morto con la fede nell'anima del prossimo avvento d'un'Italia più grande, più nobile, più seria. Quella che deve ancora essere costruita, e Dio vorrà. A Scipio un grande bacio e la promessa che in me non morirà mai” [da "Vele in porto", LEG, 2012, p. 260]. Così è stato. Così è stato. Per Scipio, come per Falco, il figlio maschio di Marin, caduto giovanissimo per un paese che nemmeno sa più cosa fosse la Giulia; dubita anzi che sia mai esistita.
EDIZIONE ESAMINATA E BREVI NOTE
Biagio Marin (Grado, Austria 1891 – Grado, Italia, 1985), poeta italiano. Laureato in Filosofia, studiò, negli anni giovanili, tra Gorizia e Pisino; frequentò corsi universitari tra Vienna e Firenze. Esordì pubblicando i versi di “Fiuri de tapo” nel 1912. Fu bibliotecario delle Assicurazioni Generali.
Biagio Marin, “Vele in porto. Piccole note e frammenti di vita. 27 agosto 1946-3 febbraio 1950”, LEG, Gorizia, 2012. A cura di Ilenia Marin. Con una nota di Gianni Cimador, e una postfazione di Elvio Guagnini. Contiene un indice dei nomi. pp. 392, euro 32. ISBN, 9788861020719.
Gianfranco Franchi, luglio 2012.
Prima pubblicazione: Lankelot.
Si tratta del terzo diario di Biagio Marin, il secondo a vedere la luce dopo “La pace lontana. Diari 1941-1950” [LEG, 2005]
