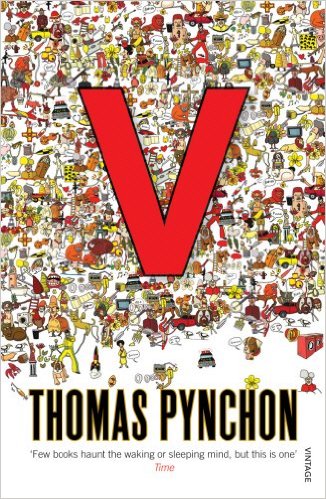 V.
V.
Rizzoli
2005
9788817006422

Dici Pynchon, e il lettore forte subito pensa al fantasma per antonomasia della Letteratura Americana: più radicale di Salinger – non a caso qualcuno ha ipotizzato fossero la stessa persona – disposto al limite, in tarda età, a prestare la voce per un paio di puntate dei Simpson. Dici Pynchon, e una legione di autori e di critici occidentali si emoziona: padre – tra i padri – della Letteratura Postmoderna, narratore imprevedibile di vicende laterali e obliate, a volte inventate a volte rimosse, genio incompreso (dalle masse, e da qualche critico conservatore). Sino a qui tutto bene. Io ho pensato fosse il caso di documentarmi per bene, prima di affrontare la sua idolatrata opera prima, “V.”. Dopo essermi spaventato per bene, aver nutrito sentimenti ibridi di soggezione e di gioia per l’esperienza estetica prossima ventura, e dopo essermi preparato psicologicamente per mesi (volevo essere bello riposato e concentrato: agosto) ho affrontato il tomo (590 pagine circa) e ne sono riemerso. Sì, ne sono riemerso, e non credevo: ne sono riemerso con un prepotente, abnorme, stentoreo sbadiglio. Uno sbadiglio che somigliava a un latrato. Perché “V.” di Pynchon è una mattonata sui coglioni lanciata, a distanza di una manciata di passi, da un discobolo con la mira infallibile. E con una certa maligna disposizione d’animo: non tira sportivamente, tira a far danni. Non può che prenderti in pieno, magari mentre sei tra le nuvole e ti immagini, tutto tranquillo, trotterellando verso casa, che tra un quarto d’ora, venti minuti sei dentro e puoi prepararti il caffè con due o tre biscotti. Eccolo il mattone, eccolo che sta atterrando e adesso ti prende, adesso ti prende (feel it closing in), e sbam. Ah. Però, che stile. Che grazia, quel discobolo. Dai, fallo ancora. Mi fa male ma la tecnica è spettacolare.
Insomma: di cosa vi nutrite, voi letterati americani postmoderni? Non è meglio restare a (limitarsi a) DeLillo, con le dovute cautele? E tu, scrittore italiano che ti nutri del genio di quel popolo, come hai potuto erigere lui a totem per struttura, stile e personalità? È stata una questione di immagine – faceva fico leggere Pynchon, tutto a un tratto – o una precisa volontà? Davvero ti dà piacere? E dimmi: cosa ti dà piacere? Io a questo punto devo nutrirmi dell’opera omnia. Voglio capire. V come vedremo, mica mi arrendo.
Restiamo a “V.”, intanto. La scrittura è buona. Ecco la fregatura. Questo artista sa scrivere, controlla con intelligenza l’aggettivazione, calibra a dovere i dialoghi, ti pizzica ogni tanto con un omaggio alla musica rock o jazz (il libro è del 1963), sa inizialmente (ho detto: inizialmente) accompagnarti nelle (molteplici! E assemblate senza sosta) trame con una certa dolcezza (poi diventa ruvido e brutale. Semplicemente, sembra un pazzo che cambia argomento, questo è l’impatto, e cambia tono di voce e modo di guardare. Tutto).
E dire che quando spunti tre strane parole nella didascalia del capitolo primo (“schlemihl”, omaggio yiddish e non letterario, a significare inetto; “yo-yo” come aggettivo compagno e il greculo “apocheir” come traguardo) ti stai ormai aspettando la lettura del libro di un pazzo che non ha digerito il Finnegans Wake: macché, Pynchon è un bravo marinaretto americano ordinato. È un citazionista compulsivo, è un erudito, ma non ha una lingua difficile. Anzi. Molto, molto classico, nella lingua, e tutt’altro che ostico. Sì, mescola le lingue, ma con disciplina – almeno in questo libro – e tendenzialmente nelle canzoni. Everything in its right place. Ricercato, sì. Lessico fiorito e ricco, ma non inaccessibile. Yiddish! Là pesca a piene mani. Ma insomma, un po’ di pazienza e di memoria e ci si raccapezza. Mica è sanscrito.
Seconda fregatura, la lingua tiene. Allora ci siamo? Cosa manca? Dov’è che scatta il cortocircuito che impedisce una lettura piacevole e razionale di “V.”? Dov’è che forgiano questo mattone infuocato che sta puntando dritto ai tuoi zebedei? Ma è ovvio: nella struttura. Il nostro straordinario Pynchon tiene i fili fondamentalmente di due storie (infine, manco a dirlo, intrecciate): ma se nella prima, quella dell’ex marinaio americano Benny Profane, le storie nella storia e i personaggi insignificanti e tuttavia presenti non superano una quantità diciamo anomala ma ragionevole, nella delirante vicenda dell’inglese Stencil e della sua ricerca della verità sulla misteriosa perduta madre V. si passa, in una giostra micidiale, da un secolo all’altro, da una nazione all’altra, da una menzogna a una rivendicazione storica, il tutto senza nessuna soluzione di continuità e nessun anello di congiunzione diverso da questo generico “V.”, che non sta per una e una sola donna o una e una sola cosa. Anzi.
Volendo essere cattivi, si potrebbe pensare che l’opera assembla molto materiale scritto per altri libri mai pubblicati, in passato; e che la critica è rimasta accecata (non tutta, no) da questa innaturale ricchezza di argomenti, da questo incredibile e increscioso disordine, da questa narrazione lineare nella scrittura e scala di Escher nella disposizione degli argomenti. Personalmente, a un tratto ho cominciato a patire, semplicemente non mi raccapezzavo più e non mi divertivo affatto: il libro aveva dei personaggi e un ambientazione riconoscibile, americana cittadina contemporanea, e poi ci si ritrovava, come per folli montagne russe, che so – al Cairo, a Firenze cent’anni prima, a sentire sbrodolare boutade su Machiavelli e i Medici (ancora?), a testimoniare la tragedia degli Herero, massacrati in Namibia nel primo Novecento, e così via. Che si finisse a Malta era plausibile, considerando la vicenda del (polimorfico) Stencil: che il giro fosse così tortuoso non era previsto. Poteva essere appassionante, intelligente, non so, se solo avesse avuto un senso. O una disposizione differente, ripeto. Il senso non c’è, e tutto questo è molto postmoderno… no, un senso non c’è. Il senso deve stabilirlo il lettore. V sta per Valletta? Veritas? Vergine? Venere? Fatti Vostri.
“La verità e la falsità, in questo caso, non sono concetti validi” (p. 139, sulle leggende urbane di un prete e della sua chiesa di topi, nelle fogne di New York, laddove una pattuglia massacrava gli alligatori): “Quando dico ‘verità’ intendo dire ciò che si può determinare con la massima accuratezza possibile. Niente metafisica. Scrivere poesie non vuol dire comunicare con gli angeli o con il ‘subconscio’. Vuol dire comunicare con i propri visceri, i genitali, i cinque portali dei sensi. Niente di più” (p. 378: e poco dopo, apologia della menzogna nella poesia del ventesimo secolo).
Non c’è problema: questo è stato il secolo delle grandi sperimentazioni. Abbiamo distrutto il romanzo classico e le sue variazioni principe: abbiamo assistito a torrenziali flussi di coscienza, a libri senza trama diversa da ricordi e memorie, al pensierino che partoriva montagne, a una lingua che fondeva tutte le lingue; che sarà mai non avere più un numero razionale di personaggi, una serie di eventi concatenati nel rispetto della ragionevolezza di un salto temporale? Niente. E qualcuno avrà pure dedicato mesi e anni di vita a mettere ordine in questo casino, e non posso che dichiarare rispetto e ammirazione per quella mente buona. Soltanto… mi domando: per chi è scritta questa narrativa? Non per i cittadini, né per i letterati tutti: è scritta, si direbbe, come un gioco tra amici. Come un codice. Come se ci si fosse detti: allora, se la verità non esiste, se il tempo è un’illusione, se l’identità è una macchinazione della burocrazia, se i ruoli cambiano col passare degli accidenti, se l’amore è una questione chimica, se lo spazio è qualcosa di momentaneamente resistente, cosa deve costituire e rappresentare l’opera letteraria?
Tutto questo gigantesco disordine. Io avrei trovato straordinario e intelligente il romanzo di Benny Profane e dei suoi amici: di questo ex marinaio che passa da una scazzottata all’altra tra bettole e localacci, amando donne più o meno riottose, sanguemisto cattolico ebreo, dalla moralità “frammentaria” e dal complesso rapporto con gli oggetti (“inanimati”, specifica. Perché le donne, che gli piovono addosso, non hanno il suo ritmo e sono solo rumore, certe volte gli ricordano gli oggetti…). Le scene di violenza e di erotismo sono ben descritte; il suo ambiente – i suoi compari – parlano una lingua credibile e si comportano esattamente come ci aspetteremmo, anche negli eccessi; forse è dalla storia della missione nelle fogne per far fuori gli alligatori che si precipita nella letterarietà assoluta, ma in ogni caso… al termine della lettura, rimangono dei flash, come se Benny Profane fosse apparso per caso in questo libro che pure inaugura. Rachel ed Ester sono due personaggi femminili interessanti e ben caratterizzati; e scivolano via. Scivolano via trascinandosi strani ossi di seppia: che so, la storia della rinoplastica secondo Pynchon, ibrida di fiction e non, mi ha ricordato il monumentale saggio di Rizzardini nell’edizione del “Naso di un notaio” di About. Al che mi sono detto: carino, sì, ma che cazzo c’entra? E questo pensiero, alla lunga, si è fatto peggiore: palloso, e che cazzo c’entra?
Un po’ come l’integrazione della vicenda di Tolomeo e degli elefanti. Ma stiamo scherzando? O l’altra vicenda del sefardita portoghese… a volte Pynchon sembra un Woody Allen in acido, come quando, in “Prendi i soldi e scappa”, si trasforma in un rabbino e comincia a predicare. Predicare cose laterali… Già, e che dire di quel passo sulla psicodonzia… (p. 178)
Chiudiamo con due passaggi accattivanti. “Dietro V., dentro di lei, c’è molto più di quanto nessuno abbia mai sospettato. Il problema non è tanto sapere ‘chi’ è, ma ‘che cosa’. Che cos’è? Dio non voglia che io sia mai chiamato a fornire questa risposta” (p. 59).
“V., chiunque lei fosse, poteva essere stata inghiottita dagli ariosi spazi rinascimentali di quella città, poteva essere stata assunta in una tela qualunque delle migliaia di Grandi Dipinti lì ospitati. (…) V. era implicata, anche se forse in modo solo marginale, in una di quelle grandi congiure, una di quelle anticipazioni dell’Armageddon che sembravano aver catturato la sensibilità di tutti i diplomatici negli anni precedenti la Grande Guerra. V. è una congiura” (pp. 180-181).
Mi dichiaro eternamente riconoscente al critico italiano che, qui nel web, pubblicherà un ampio e dettagliato saggio sull’opera: abbiamo – ho – tutti un formidabile bisogno di capire dove avete nascosto – dove si nasconde – il genio di Thomas Ruggles Pynchon. In questo libro, dico.
EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE
Thomas Ruggles Pynchon (Glen Cove, Nassau, Long Island, NY 1937), scrittore e saggista americano. Esiste solo nelle sue opere: non si concede al pubblico. Studiò Fisica e Letteratura Inglese alla Cornell University, si arruolò in Marina. “V.”, apparso nel 1963, è il suo primo romanzo; in precedenza, aveva pubblicato solo racconti. Il primo è stato "The Small Rain", apparso nel Cornell Writer nel maggio 1959.
Thomas Pynchon, “V.”, Rizzoli, Milano, 1999. Traduzione di Giuseppe Natale.
Prima edizione: “V.”, Lippincott, 1963.
Gianfranco Franchi, agosto 2008.
Prima pubblicazione: Lankelot.
