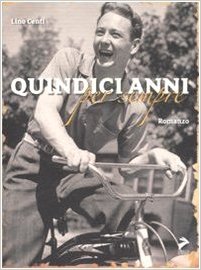 Quindici anni per sempre
Quindici anni per sempre
Coniglio
2008
9788860631381

Toscana. Tutta la poesia della perduta vita dei campi, quella che conosciamo per i quadri dei Macchiaioli e per i romanzi e i racconti di Federigo Tozzi, e tutto l’arcano segreto d’una educazione sentimentale ed erotica altra, sinceramente bisessuale; ripetuti omaggi al cinema d’epoca, e infine un documento lirico del passaggio dalla terra alla periferia urbana, per il proletariato e la piccola borghesia: questi gli assi portanti del buon romanzo dell’architetto e pittore Lino Centi, fiorentino dalla scrittura letteraria limpida e molto ricca, sino a rischiare l’artificiosità, innervata tuttavia da reminiscenze liriche e da una prevedibile, grande visività. Visività che ammanta di voyeurismo nostro, di noi lettori, descrizioni degli amori e delle terre; e attenua l’impatto barocco di certi passi: come questo…
“I momenti della mietitura e della vendemmia erano specialmente animati. In casa Bitti ci si preparava fin dalle settimane precedenti; e il padre di Luca mostrava una tolleranza vicina a zero per le mie intemperanze: quali il rincorrere – tra l’aia e la corte – un gruppo d’imponenti tacchini rei di aver esibito un’indegna bellicosità chiassosa (…). Sotto un allucinante stellone, issato in poppa alla macchina che seleziona il grano, nell’infilare un covone nella bocca della trebbia ne vengo risucchiato. Mi salverà la camaleontica prontezza di un contadino attempato e rubizzo (…)” (p. 35). Come avrete apprezzo, l’aggettivazione è piuttosto ricca e giocosa; Centi è come un letterato bambino che gioca con le parole, assaporandone il suono, i colori, e godendo della scelta d’ognuna di loro. In questo senso è pienamente in linea con gli insegnamenti della prima e ispirata Nothomb: scrivere senza godere è l’unica cosa immorale. Esatto.
E come bambino racconta la morte, interrogandosi sul suo significato e sul suo mistero; sulla responsabilità di ciascuno (episodio dei pappagallini: p. 62) e sull’impermanenza di tutto. Il principio-chiave che non dovremmo mai dimenticare; che niente dura in eterno, e può esserci strappato da un momento all’altro.
Vi racconto dove ci troviamo. Casa Paludi: sul confine, un fossato melmoso. Che il narratore affrontò bambino, primo di smarrimenti ed errori che nell’opera racconta. La sua vita è come “costruzione astratta, labirintica e isolata” (p. 151). Ha paura di perdersi. Ha paura dell’estraneità: è consapevole della diversità, spera non diventi incomunicabilità. Diversità estetica e di sensibilità: purezza, laddove altri vedono vizio. Appartenenza, laddove c’è chi legge identità. E così via.
Forse il narratore comincia a perdersi quando la famiglia trasloca in città, in periferia, perdendo l’incanto del contatto con la terra, inevitabilmente rimpianto. Il padre rimane comunque renaiolo, a dispetto dei progressivi lavori altri e cittadini. È un mangiapreti che fa fare la comunione al figlio. Una figura forte, piena di personalità. Nelle contraddizioni lacerata, ma viva.
Poco distante da Casa Paludi, la fattoria dei Bitti, frontiera rurale della città in costruzione. Il giovane figlio del fattore, Luca, efebico e dionisiaco, sarà la guida del più piccolo narratore; intervalli d’amore etero vengono minimizzati e lasciati nell’ombra, per emergere man mano. Come quello con una bambina, raccontata così, per poesia e lastra dell’anima: negli incontri con le femmine “lievita un aspetto panico – carcerario ed esclusivo. Vivrò quel ratto, che si ripeterà finché un giorno saremo scoperti e il sottoscala sprangato, come un’immersione nei lati infernali dell’anima” (p. 21). Diversa la sorte rischiata dalla maschiaccio Catia, circondata dai marmocchi di campagna improvvisamente smaniosi di spogliarla. Altrove verrà adorata con stilnovista dedizione la cittadina adolescente Pamela; meno stilnovista l’incontro bucolico con la rea Silvia (p. 76. A proposito: maxima iniuria); e così via.
Cosa ci dà nostalgia, nella pittura dei macchiaioli? Scoprire che le terre e i campi che dipingevano oggi non più esistono; che certe località sono contaminate da palazzi abnormi e spesso brutti, che quella solarità e quella dolcezza è andata ombreggiandosi, attenuandosi. Questo romanzo ha – tra i vari meriti – quello di regalarci la fantasia di vivere e popolare quei posti negli ultimi momenti della loro libertà. Della loro selvatichezza.
A Centi non si deve rimproverare niente, nemmeno la straripante aggettivazione e la non nascosta ricercatezza. Perché voleva animare un’opera personale e autentica, e si sente che non ha barato. Ha scritto un’autobiografia romanzata, probabilmente, di un’anima che ha trovato quiete nell’espressione artistica, e amore vero solo nell’omosessualità. Ha dato prova di scrittura sanguigna e di colore. Se Tozzi avesse saputo cantare la carne, e non solo il desiderio della carne o il suo impossibile possesso, avrebbe scritto pagine come quelle di Lino Centi.
ALTRE ANNOTAZIONI. A beneficio dei cinefili, segnalo questo passo, fotografia del clima culturale dell’epoca: “La cinematografia del Belpaese registra la miscela sociale di sentimenti calpestati e apocalisse plebea con film quali Il cammino della speranza, ma anche con i mélo della serie Catene, Tormento, I figli di nessuno, che fanno piangere milioni di italiani in sale strapiene tra nuvole di fumo: una pellicola di Tornatore ha interpretato con comica originalità quello psicodramma collettivo (…) tra neorealismo e melodramma” (p. 53). Naturalmente, il film di Tornatore è “Nuovo Cinema Paradiso” (1987). Altrove, viene omaggiato Resnais (“L’anno scorso a Marienbad”); e ancora, le “Miniere di Re Salomone”, “La vena d’oro”
A beneficio dei letterati, la biblioteca dell’adolescente narratore: “Pavese, Faulkner, Caldwell, Maupassant, Flaubert, Dostoevskij, Cechov, Tolstoj, Lawrence, Kafka, Camus, Mann (…), Brancati, Proust, Calvino” (p. 116). Altrove, fa capolino Scott Fitzgerald; e ancora Eliot, e Ibsen. Cosa notate? Gli italiani non sono nemmeno maggioranza relativa. Non è una novità. A quando uno studio sulla mutazione genetica dei lettori e dei letterati italiani, post editoria del dopoguerra? È da allora che la xenofilia s’è fatta non oltranzista, ma plausibile e lineare: forse inevitabile, considerando la pubblicità e la circolazione data alle opere di tutte le principali narrative occidentali eccettuata la nostra. Buona lettura.
EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE
Lino Centi (Firenze, 19**), insegna Architettura all’Università di Firenze. Pittore, poeta e scrittore italiano.
Lino Centi, “Quindici anni per sempre”, Coniglio, Roma, 2008. Prefazione di Lara Vinca Masini: incentrata sulla sua produzione pittorica e sulla comparazione con quella letteraria.
Gianfranco Franchi, settembre 2008.
Prima pubblicazione: Lankelot.
