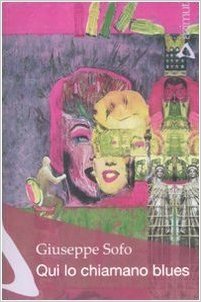 Qui lo chiamano blues
Qui lo chiamano blues
Azimut
2008
9788860030825

“Qui lo chiamano blues” è una raccolta di tre racconti, nati e cresciuti in Nord America, illustrati da Stefano Landini su foto dell'autore, Giuseppe Sofo, completi di relativo sottofondo musicale ispiratore. Scelta e ambientazione sono almeno spiazzanti, considerando che ci troviamo nel momento di maggior dissenso mondiale nei confronti degli States; nel momento di maggior stanchezza nei confronti dell'antica letteratura del sogno americano, svuotata – ma non sconfitta – dall'assurdo imperialismo yankee. Nessuno dà più credito alla Statua della Libertà. Sembra stia lì per ammonirci sullo svuotamento delle parole, sul cambio di significato dei sogni, sul senso del denaro e del potere economico. Eppure Sofo sembra aver maturato un amore autentico nei confronti d'una terra che pare essere diventata nemica di sé stessa, dei suoi valori fondanti, dell'immagine che aveva promosso nel mondo. Un narratore spiega:
“Così decisi di fare l'amore con l'America. Mi eccitava l'idea di farlo con un continente. Con uno Stato immenso, i cui confini vanno ben oltre quelli geografici. Costruiti con il lavoro duro di generazioni di sfruttati e di un pugno di puritani scappati verso la libertà, solo per poter opprimere qualcun altro. Avevo voglia di stare dentro lei, dentro l'America” (p. 55).
Potrebbe essere una spiegazione per questa difficilmente spiegabile fascinazione d'un artista italiano contemporaneo, nato negli anni Ottanta. È certamente uno dei motivi dell'adesione rock e letteraria a quell'immensa terra, e a quel caotico popolo.
Incipit sensuale, spiazzante: “Washington ti spoglia dolcemente”. Sofo suona – scrive – così: cantando una città elegante e piena di grazia con tono da vecchio songwriter rock. Sconclusionato, tutto concentrato sul suono, ellittico e disomogeneo. La trama si disintegra, man mano. “Vado di strada in strada, nel suo buio. Le passo tra le cosce e le sfioro le spalle. Ma è in fondo a quella strada che me ne innamoro, ogni volta che passo. Quando cammino dal Washington Monument al Lincoln Memorial e leggo quelle migliaia di nomi sul muro. Quando guardo le luci che si riflettono sull'acqua, seduto sul gradino con le parole I have a dream e guardo alla notte di Washington. L'unica città del mondo in cui la notte è bianca” (p. 11), con buona pace di San Pietroburgo, per intenderci. Glissare. Donne, dischi di Bob Dylan, un amore forse perfetto che non riesce nemmeno a vedere la luce del giorno. Come la vita del narratore.
“Tre volte dentro di lei” - il narratore è reduce da mesi negativi passati a New York. È in treno, vuole tornare da “lei”. Dalla sua infanzia, da cui era fuggito in cerca di nemmeno lui sapeva cosa. Della sua ex, drogata e calma, ammalata d'un male orribile. L'edipico segreto finale rivela le ragioni del malessere del cupo narratore. La tragedia d'amare la donna da cui si è nati ha rovesciato la sua lucidità.
“Qui lo chiamano lullaby” - è come il blues, “suona un po' di lacrima e un po' di sesso rubato, ma ad annusarla è l'immagine precisa d'una malinconia ingiustificata” (p. 51). Retrogusto (sempre) suicida. È notte, il narratore guida. È un musicista in tournée. Racconta la più classica America on the road:
“Le strade americane sono pozzi. Non hanno fondo, non ne vedi la fine, vedi solo un buio lontano e la sensazione che in fondo qualcosa dovrà pur esserci, ma che questa notte non ti è dato scoprirlo. Pozzi orizzontali su cui lanci le luci della tua macchina come da bambino lanciavi sassi per sentirne il rumore all'arrivo, quel rumore che a volte si perdeva nei troppi metri verso il basso”.
Donna stupenda, la musica per avvicinarla – come in un rito dionisiaco – e prevedibile epilogo d'un amore mistico e sensuale. Considerare questo libro un cieco atto d'amore nei confronti del viaggio non è del tutto sensato, perché – stando a quel che dice il narratore di Lullaby, “viaggiare ti uccide l'anima. Te la porta in viaggio, come fosse un accessorio: come una tenda da campeggio, o un album di foto. Poi te la lascia in qualche posto, a marcire di gioia per lo splendore di una città o delle sue strade, per il calore delle luci che la illuminano e della gente che incontri. Finché non capiti da qualche altra parte, in un deserto o in una piazza, nel mezzo d'un mare o nel giardino dietro casa d'un amico lontano. E allora la tua anima si sposta. Si muove, come te, e comincia a morire d'amore per questo nuovo luogo”.
È una dannazione, in altre parole, come tante altre passioni nella vita. E come ogni dannazione è consapevole. Dannazione peggiore d'un viaggio in un mondo in rovina, tra le ceneri di un sogno e della sua antica mitologia (c'è spazio anche per due battute sul Vietnam) non poteva essere scelta. Ma la musica, la gentilezza d'animo e l'innocenza di un ragazzo possono ovviare a tutto. Sempre.
Secondo libro di narrativa di questo scrittore classe 1984, pubblicato dalle romane e promettenti Azimut di Guido Farneti, “Qui lo chiamano blues” è un libro nato per delle performance. L'autore deve guadagnare il palco di oscuri pub e polverosi centri letterari, imbracciare una chitarra, ubriacarsi e leggere.
Alle sue spalle, videoinstallazioni e foto del suo viaggio. E magari una bandiera degli States, ma rovesciata. O almeno: sporca di birra, sì, e di sangue. Tanto. E di tanti popoli diversi.
EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE
Giuseppe Sofo (1984), scrittore, regista, giornalista e traduttore italiano. Ha esordito col romanzo “Dollville” (2006). Dorme a Modena.
Giuseppe Sofo, “Qui lo chiamano blues”, Azimut, Roma 2008. Collana Facies, 20. Illustrazioni di Stefano Landini su foto di Giuseppe Sofo.
Gianfranco Franchi, gennaio 2009.
Prima pubblicazione: Lankelot.
