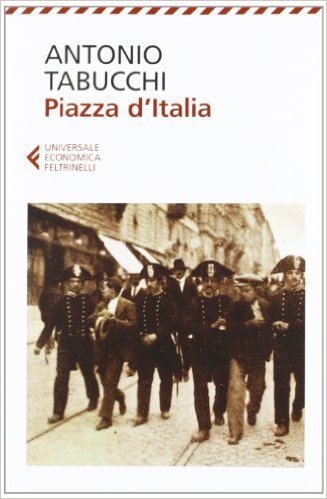 Piazza d'Italia
Piazza d'Italia
Feltrinelli
2013
9788807880506

“Favola popolare in tre tempi, un epilogo e un appendice”: così lo scrittore pisano definiva il suo esordio, scritto nel 1973 e pubblicato nel 1975. Della favola popolare ha il respiro romantico e il sentimentalismo; della favola ideologica mantiene la morale, la rabbia e l’esemplarità; dall’epica deriva il tragico senso di predestinazione, l’opposizione estenuante al nemico (in questo frangente, è più opportuno tradurre: allo “Stato” o al “padrone”); dalla grande tradizione romanzesca, la durata secolare della vicenda – incentrata attorno a una famiglia-paradigma. È una famiglia che non ha cognome, curiosamente: ne conosciamo solo i nomi di battesimo, ripetuti a oltranza nell’arco di diverse generazioni. Questo, probabilmente, a suggerire che la storia non cambia, per i figli del popolo: e che la condanna alla resistenza e all’opposizione nei confronti delle autorità (sempre prevaricatrici) e dei regimi di turno è inevitabile.
Ci troviamo in un Borgo – il Borgo, per antonomasia; nessuna alterazione nella toponomastica convincerà i cittadini che il nome sia differente – e assistiamo alle vicende di questa tormentata, sfortunata e romantica famiglia di anarchici, nell’arco di tre generazioni: famiglia orgogliosa della sua estraneità al sistema e tuttavia – o forse, proprio per questo – sempre impegnata in una battaglia; quando non ci si combatte nelle guerre del governo di turno, o contro la sua politica, si combatte per poter lavorare e poter mangiare: in altre parole, per poter vivere.
Gli uomini di questa famiglia si chiamano, tendenzialmente, Garibaldo: non mancano Quarto, Volturno, Plinio (il capostipite). Le donne sono un monumento alla nuova e finalmente illuminata concezione della donna, nella società contemporanea: sono figure coraggiose, ruvide e stoiche, capaci di cieca fedeltà al compagno e di grande resistenza al dolore, e alle difficoltà della vita. Sono determinanti, sempre incisive e insostituibili: mai deboli, mai paurose.
La storia di questi orgogliosi e affascinanti anarchici toscani, sempre sconfitti ma sempre coerenti, fino alla simbolica estinzione del ghenos, costituisce una lettura avvincente, seducente e francamente e scopertamente ideologica della storia del popolo italiano: scritta con intelligenza e umanità, schierandosi dalla parte di chi non ha davvero vinto mai; e sempre s’è trovato ad agognare una libertà che nulla e nessuno, in nessun tempo, ha mai garantito loro. È una storia senza dubbio malinconica – come poteva essere altrimenti? – ma non per questo l’autore si nega qualche punta di sarcasmo; qualche frangente del testo presenta concessioni addirittura al tragicomico – e appare l’amaro sorriso del popolo che non vuole arrendersi alle sconfitte e ai dolori, e resiste a ogni male: affrontandolo e sopravvivendo a qualsiasi avversità, mostrando una straordinaria ed esemplare grandezza d’animo.
Questo libro potrebbe e dovrebbe essere analizzato, in futuro, assieme a quella parte della produzione letteraria di Sebastiano Vassalli volta a costruire una “storia romanzata” d’Italia: le affinità non si limitano alla sensibilità, alla comprensione dei contrasti e delle contraddizioni, alla lucidità d’osservazione e alla bella lingua letteraria (e non è difficile individuare l’analogia princeps, di natura politica, ma questo importa meno); le affinità si estendono alla dolcezza e all’umanità dimostrata nella trattazione di esistenze e di problemi sociali e civili altrove trascurati o trattati con superficialità. Sto immaginando, in altre parole, che in futuro libri come “Piazza d’Italia” di Tabucchi o come “L’oro del mondo” di Vassalli serviranno, alle nuove generazioni, come testimonianza della cultura italiana che si batteva per demistificare la storia della nostra nazione, per restituire voce, spazio e dignità a quella parte della nostra comunità, costantemente umiliata o negletta per ragioni d’opportunità di vario genere, che nessuno sapeva cantare; per dimostrare che si poteva avere altra sensibilità e altra comprensione della sofferenza dei cittadini, e magari ovviare a certe battaglie politiche e ideologiche, soltanto testimoniandone l’esistenza e sensibilizzando l’opinione pubblica – termine detestabile, quest’ultimo, ma purtroppo sufficientemente chiaro a tutti: ciò di cui non si parla finisce col non più esistere, precipitando nell’oblio o – quel che forse è peggio – in un’aura di vaghezza e di leggendarietà che a nulla serve, se non alle manipolazioni e alle alterazioni della realtà.
Questo è il libro dei decidui, a questo punto si sarà inteso; ma non si può non rivendicare e ribadire che chi cade con questa dignità e questo orgoglio non sia caduto invano. Il romanzo – l’autore avrebbe preferito: la favola – s’avvia con l’epilogo della vicenda, la morte dell’ultimo Garibaldo, colpito alla fronte mentre manifesta nella piazza del Borgo. Muore con un sorriso furbesco, conscio d’aver sbagliato l’ultimo grido: “Abbasso il re!”, aveva urlato, quando ormai vigeva la repubblica; la sua compagna era andata a chiudergli gli occhi, ripensando a un oroscopo che aveva previsto – a suo modo, e cioè rimanendo indecifrabile – quell’esito.
Sin da questo tratto iniziale, abbiamo chiare le linee-guida della vicenda: appunto, la drammatica e invincibile predestinazione, l’opposizione e la ribellione nei confronti del sistema, la sconfitta del ribelle, il suo ultimo sorriso, di fronte ai rovesci della sorte. Tabucchi ha sintetizzato, in questo atipico incipit-congedo, lo spirito del testo: leggiamo un libro di cui conosciamo l’epilogo, allora, concentrandoci quindi – assolutamente – sui personaggi, e sul senso delle loro esistenze. L’artista sembra suggerire: non negherò nessun dramma, in queste storie: esse testimonieranno quel che è stato, e non dovrete attendervi nessun miracolo; se volete capirne le cause e le ragioni, leggetele e interiorizzatele. È quel che mi sembra naturale, logico e umano attendersi da un lettore.
Il resto lo può spiegare – immagino – il frammento che riporterò a breve. Nel primo capitolo del primo dei tre Tempi che scandiscono la narrazione del romanzo, un altro Garibaldo (di battesimo: Volturno), che non accetta l’idea che esista la morte, veglia il cadavere del padre. Questi si sveglia, si sfila l’orologio, s’alza dalla bara e prende a parlargli, fino all’alba: ma non della morte. La sua vita s’è compiuta: ha trasmesso al figlio ciò in cui deve credere. Questo: “Ormai Garibaldo sapeva che l’acqua che muoveva il mulino era di tutti come il grano che macinava, che le folaghe che scendevano nei paduli a novembre erano di tutti, e che le guardie regie c’erano per ammazzare chi se n’era accorto” (p. 15).
Siamo nel Borgo. I poveri vivono tagliando cannelle di padule (p. 18): quando vagano col cappello calcato sugli occhi, significa che hanno nostalgia del letto; hanno gli occhi belli della fame, “grandi d’acqua” (p. 25). Un fattore detta i prezzi, e non accetta discussioni.
Il patriarca della nostra famiglia anarchica, Plinio, è un garibaldino autentico: ha chiamato i suoi primi due gemelli Quarto e Volturno (p. 19), ha perduto un piede combattendo per Roma, commentando così l’accaduto: “Ho preso a calci Pio IX” (p. 21). Muore in un “incidente”, colpito da un guardacaccia.
I due gemelli hanno tempra e atteggiamento differenti: Quarto è vulcanico ed esuberante, Volturno pauroso e silenzioso. Ha paura di tutto: è costantemente scosso da una febbrile angoscia che non riesce a dominare. Passa il tempo disegnando figure sulla cenere. Crescendo, non perderà questa sua attitudine alla malinconia: ma subentreranno le prime stravaganze; racconta storie che “finiscono all’inizio” (p. 27), cioè principiano dalla fine, e prende a “vaticinare” eventi futuri. La maga del paese dice che, come ogni poeta, ha il mal del tempo (p. 26): passerà, forse, col matrimonio.
Intanto, starà a Quarto mantenere la famiglia – che conta su altri due più giovani gemelli: Garibaldo (vivace e incontenibile, come Quarto) e Anita (schiva, silenziosa e pallida, come Volturno: e da lui ribattezzata, con universale successo e approvazione, “Atina”).
Proprio quando Volturno ha incontrato l’amore nella bella Esperia, nuovi venti di guerra chiamano il popolo italiano a combattere in Africa. “Per i ricchi” – pensa Garibaldo: e si spara a un piede per non partire (p. 28). I due gemelli partono. Quarto scrive alla mamma Esterina, dal fronte: è malinconico e cupo. Tornerà, da eroe di guerra: ma in una “cassetta piombata” (p. 31): mentre di Volturno si saprà solo che è fuggito coi beduini. La madre, tuttavia, riconosce subito che il cadavere è quello del povero Volturno: è Quarto ad essere fuggito per sempre, nel deserto. D’accordo con i figli, non rivela la verità alla povera Esperia, che si strugge, nostalgica, per il lontano amore.
Garibaldo ha imparato, nel frattempo, a seguire le orme del padre: a differenza sua, “sente” i guardiacaccia a distanza, per via della ferita al piede. E spara prima che possano colpirlo: ne deriveranno dieci anni da emigrante, negli Stati Uniti; per tornare a mani quasi vuote, con un bell’orologio. E sposare Esperia, dopo averla violentata, per restituirla – paradossalmente – alla vita che aveva perduto attendendo un ritorno impossibile.
Atina, diventata graziosa adolescente, s’innamora del figlio del padrone, Ottorino: seminarista (p. 35), votato alla castità e al culto di Sant’Orsola, non resiste al fascino della ragazza. Ma quando rimane incinta, non sa come comportarsi: il padre intende proibirgli il matrimonio, il buon prete lo invita a prendersi serenamente le sue responsabilità: lui si suicida. Atina finirà i suoi giorni come monaca di clausura (p. 39). Il figlio della sfortunata coppia, Melchiorre, nascerà settimino e sarà malaticcio per tutta la vita: preteso dal fattore, da lui verrà allevato.
Melchiorre avrà un cugino: figlio di Garibaldo ed Esperia, Volturno (p. 43), destinato a diventare Garibaldo per tutti, dopo la morte del padre, assassinato negli scontri con le forze dell’ordine, in un assalto a un granaio suggerito dal parroco socialista, Don Milvio. Che odiava i dogmi, e leggeva ai parrocchiani “Socialismo cristiano” di Padre Curci passandolo per Vangelo (p. 65).
Abbiamo, fino a questo punto, assistito alle vicende d’Italia, dai Mille fino alla Libia: la generazione di Melchiorre e Garibaldo-Volturno sarà quella che vivrà la violenta ascesa al potere del fascismo, la Resistenza e la successiva nascita della Repubblica. Melchiorre è l’archetipo del fascista, nella visione di Tabucchi: fin da bambino, “odia il prossimo” e si sente “vigliacco”, s’iscrive al partito per un generico cameratismo, e perché si diverte a cantare quelle canzoni di guerra che gli fanno sognare d’essere quell’uomo che non sarà mai; è un debole e un disperato, che – come ogni figlio dei “padroni”? chissà cosa voleva suggerire l’autore… – non potrà che difendere la causa sbagliata, e avallare implicitamente certe violenze.
Garibaldo è un anarchico che si convertirà, in età adulta, alla tessera del “Partito”: lascia la scuola, da bambino, istintivamente ripugnando la retorica monarchica del “Cuore” di De Amicis (p. 55), s’innamora di una orgogliosa e affascinante compaesana, Asmara, che sarà – come lui – ottima e coraggiosissima partigiana; è amico del gobbo del paese, il suo coetaneo “Gavure”: futuro tipografo e intellettuale del Partito, assassinato dai fascisti. Ma morirà “diritto”: il suo fraterno amico, nel segreto, lo priverà della ingombrante sporgenza. E lo sostituirà, nella circolazione della stampa clandestina.
Il dramma di questo frangente della storia d’Italia, in questa parte del libro, non è soltanto efficacemente descritto dalla “parentela spuria” tra Melchiorre e Garibaldo, che finiscono, quasi per inerzia, o per “diritto di nascita”, a difendere cause opposte: assistiamo, infatti, all’abbandono della tonaca del prete socialista, Don Milvio, persuaso finalmente che il Papa non sia affatto infallibile (p. 116). C’è stato tempo, intanto, per un’emigrazione (Argentina) anche di questo Garibaldo, tornato poi, per fedeltà, dalla sua bella.
A questo punto, la trama del romanzo – già rapidissima, e giocata per brucianti bozzetti – s’avvicina lentamente alle questioni del dopoguerra: alle terribili delusioni derivate dalla presa di potere della Democrazia Cristiana, alle perplessità e ai contrasti in seno a quella parte del popolo che aveva combattuto nel nome non solo della patria, ma d’un partito, e immaginava altro e diverso fosse l’epilogo: l’anarchico che pure non era più anarchico, e assieme alla sua bella sognava d’aver vinto oroscopi e predestinazioni tragiche, si trova nuovamente a essere tradito dalla sorte, e cade: sbagliando, o forse non sbagliando affatto, nel pronunciare le ultime parole. Comunica, cadendo, che non è cambiato nulla: solo il nome dell’autorità. È un po’ quanto borbottava quel saggio e cinico asino, Benjamin, ne “La fattoria degli animali”: le rivoluzioni servono a cambiare padrone; ogni padrone va servito con lo stesso disincanto, perché è l’esistenza l’unico vero male. Garibaldo muore con il sorriso di chi, sconfitto, sa d’esser caduto per difendere ciò in cui credeva: la libertà più grande, quella che nessuna ideologia ha compreso, previsto e tutelato mai. Quella degli esseri umani.
Un esordio intensissimo, intelligente e simbolicamente rilevante.
EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE
Antonio Tabucchi (Pisa, 1943-Lisbona, 2012), romanziere e traduttore italiano. Laureato in Lettere Moderne con una tesi sul Surrealismo in Portogallo, ha insegnato Letteratura Portoghese nelle Università di Bologna, Genova e Siena.
Antonio Tabucchi, “Piazza d’Italia”, Feltrinelli, Milano
Prima edizione: Bompiani, Milano 1975. Questa “favola popolare”, opera prima dell’artista toscano, è stata scritta nel 1973.
Gianfranco Franchi, novembre 2004.
Prima pubblicazione: Lankelot.
