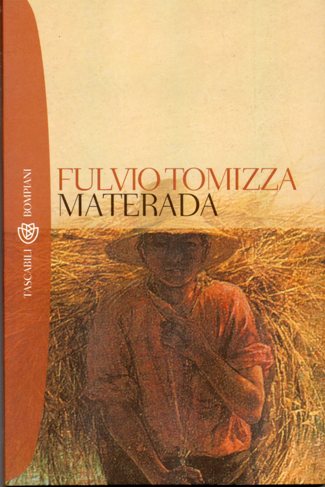 Materada
Materada
Bompiani
1960
9788845244346

“La partenza di Bortolo da Giurizzani fu per noi come quando una pecora riesce a trovare uno spiraglio tra la siepe per buttarsi nell'altro campo e allora le altre perdono la testa e lasciano lì tutto per correrle dietro. Le cittadine dell'Istria si stavano svuotando giorno per giorno, specie quelle della costa, e per noi era ormai diventata un'abitudine vedere in quei giorni i soliti camion traballanti di povere masserizie lasciare Umago e Buje e dirigersi alla volta di Trieste. Ma chi avrebbe mai pensato che alla fine si sarebbe mossa anche la campagna?” [Tomizza, “Materada”, cap XI, incipit].
**
Venticinquenne, lo scrittore istriano Fulvio Tomizza, da Giurizzani di Materada, Umago, esule a Trieste, esordiva con questo romanzo corale, lirico e contadino. Era il 1960. La delicata questione della frontiera orientale e del Territorio Libero di Trieste s'era conclusa da una manciata di anni, con la rocambolesca e sciagurata separazione della città di Svevo, Slataper e Saba dal suo naturale entroterra; era un microcosmo marinaro e contadino, quello dell'Istria ferita dal suo ultimo esodo, quello del 1954, che stava per sprofondare per sempre nell'ombra. Un microcosmo che, nelle parole di Claudio Magris, in quel periodo “era realmente straziato da rancori, torti e vendette sanguinose tra italiani e slavi”, clima che il giovane Tomizza aveva potuto osservare e testimoniare. Ma la coralità che Tomizza aveva saputo rappresentare, in “Materada”, era “una fraternità raggiunta realmente, e non solo metaforicamente, oltre il conflitto e lo scontro esasperati dall'odio”. In questo sta forse la prima, grande cifra della letteratura dello scrittore istriano: nella sua capacità d'essere ponte tra culture e popoli, nella sua tenacia nel restare profondamente istriano, e da istriano vivere e scrivere, nonostante la cancellazione e la grottesca riscrittura della storia. La cifra prima della letteratura di Tomizza sta nella sua naturale e intelligente predisposizione a non negare comunque nessuna delle sue anime: quella istroveneta e quella slava. Tomizza era come un anfibio: per sangue, lingua e cultura. E forse, per questo, Geno Pampaloni, meditando sulle qualità di “Materada”, poteva scrivere che il suo merito era stato “riuscire a far vivere con netta immediatezza il volto di un'intera collettività e di un preciso momento della sua storia”, perché Tomizza s'era abbandonato “al rinfrangersi lungo dei sentimenti, alla nostalgia”, solo quando il ritratto del suo popolo era stato compiuto. Vale a dire quando aveva avuto inizio l'esilio, e l'ingiusta diaspora.
**
Secondo Claudio Magris, “Materada” riuscì ad arricchire “di una nuova e forte pagina la poesia della frontiera, delle sue lacerazioni e della sua unità”. Perché si trattava di una “nuova e forte pagina”? Perché il protagonista di questo romanzo, Francesco Kozlovich detto Franz, era un figlio della campagna istriana; e da contadino istriano ragionava e come contadino vedeva la realtà, e di quella realtà faceva letteratura. Ma non era questa la sola novità. Francesco è infatti un personaggio così veridico e onesto che racconta, con grande semplicità, che in casa, in famiglia, si parlava con tranquillità sia in dialetto istroveneto, sia in slavo. E questo avveniva senza traumi e senza equivoci sulle proprie appartenenze, per intenderci: con naturalezza. Così: “Come sempre in caso di affari e di cose importanti, parlammo in slavo: po nasu, alla nostra, come si usa dire dalle nostre parti” [p. 22]. Non c'è nessuno scandalo.
E perché non c'erano problemi, a servirsi del veneto come del croato? Perché chi, come Francesco Kozlovich, come Fulvio Tomizza, veniva da famiglie che vivevano da secoli in Istria, nelle campagne dell'Istria, non poteva che avere il sangue e la cultura degli istroveneti autoctoni e degli sloveni o dei croati autoctoni; perché serenamente coesistevano. Da secoli. E Francesco conosceva, in ogni caso, una grande verità da raccontare ai titini – questa:
“Da quando mi ricordo, qui da noi sono venuti dapprima gli austriaci, poi gli italiani, dopo i tedeschi; infine siete venuti voialtri. Tutti se ne sono andati, ed erano più forti di voi. Io stesso ho visto cadere prima l'aquila, poi il fascio e la croce uncinata. Perché un giorno non dovrebbe cadere anche la falce e martello?” [p. 90]: già e prima ancora c'era stato il Leone di San Marco, per tanti secoli, e nonostante sembrasse eterno era caduto anch'esso.
**
Stando a quanto scriveva Gian Paolo Biasin, “la grandezza di uno scrittore si misura dalla sua capacità di far sentire al lettore la dignità degli umili personaggi, dall'efficacia con cui egli sa rappresentare la loro mancanza di coscienza storica, la loro stretta partecipazione alla vita della terra, della Madre Terra. E in 'Materada' Tomizza sembra aver raggiunto questa grandezza”.
E l'amore totale, e antico secoli, per la terra è la ragione per cui per loro è inaccettabile quel che stanno facendo i socialisti titini: che prendono e danno la loro terra a gente che magari “se l'era mangiata con il gioco per le osterie e se l'era vista pignorare e vendere all'asta per un bianco e un nero”, a gente che non aveva nessuna voglia e nessuna capacità di lavorare, minacciando i poveri cristi che avevano qualche pezzo di terra di finire come i kulaki, in Russia, massacrati come nemici del popolo. Oppure, dritti nella foiba. Già: dietro la nazionalizzazione della terra e la sua riassegnazione “al popolo” si nascondevano tutta una serie di cattiverie e di grettezze paesane, o da piccolo borgo, molto facilmente riconoscibili. Certe rappresaglie erano vendette figlie della gelosia e del rancore. E certe volte la nazionalità qualcuno finiva per sceglierla per rivalersi su chi aveva saputo comportarsi meglio, con più rispetto del lavoro, dei sacrifici e del prossimo. E questo Tomizza sa raccontarlo molto bene. Certi socialisti “erano venuti per Miro Zupan che si era mangiato l'intera sostanza giocando a carte, per i fratelli Sossa che spogliavano ogni pianta da frutto quand'era ancora in fiore ed erano neri di dentro e di fuori e sempre scalzi (e loro gli hanno dato un paio di scarpe, il moschetto e la divisa di “Difensori del popolo”); infine erano venuti per gente scarta, di nessun valore, che aveva il solo merito di non possedere niente e mangiava e dormiva Dio sa dove, nelle stalle, sui fienili o in aperta campagna” [p. 48].
E in ogni caso, all'artista istriano era chiaro “come in mezzo a tutti i guai, a tutti i lutti e alle miserie di questo triste periodo ci fosse sempre stato lo zampino della nostra stessa gente. Sempre la gente del luogo a indicare la casa dove dovevano entrare e battere e rompere, la gente del luogo e a sapere i discorsi di Nando, a vedere che quello di Radini aveva tagliato l'orzo per foraggio danneggiando così l'economia nazionale, a dire che quell'altro era stato fascista e aveva fatto correre il vino per le cantine” [p. 74].
**
Secondo Paolo Milano, “Materada” è “un racconto tradizionale al punto da confondere palati guasti da stili invece drogati. Si tratta di un cibo sano e forte. La vittoria massima dello scrittore è di aver sbozzato personaggi quasi tutti ugualmente vivi, intorno al protagonista, il quale non è altro che il più saliente, giacché vero protagonista della vicenda si deve dire il destino, che offende e sradica e muove questi miseri verso un futuro più cieco che grigio”.
Vero. E il destino dirotta Francesco e la sua famiglia non nell'agognata eredità della terra, che sembrava perduta più per l'avidità dello zio che per la cattiveria dei titini, sulle prime; ma lontano da quella terra, lontano dagli antenati, lontano dal primo amore. “E lì di nuovo maledissi quella terra per sempre. Ricordavo campo per campo, siepe per siepe, pianta per pianta, solco per solco; e li maledivo, li maledivo. Che non dessero più frutto, non più semenza, cadesse ogni anno la grandine e si seccassero, si seccassero, come la mano di un morto” [p. 96].
E il destino offende e sradica questa povera gente che non aveva nessun interesse a fare il gioco delle bandierine delle nazioni, e delle ideologie totalitarie: voleva vivere in pace e coltivare la terra, parlando la lingua che preferiva dove preferiva, lo slavo in tinello e il veneto nei campi e in piazza. E invece, si sarebbe ritrovata a sentirsi addossata la colpa della disgrazia del fascismo e dell'altra grave disgrazia del comunismo, senza saperne arginare gli eccessi, le invadenze, le violenze: più di tutto, la bieca e falsa propaganda.
“E la gente che restava, quasi si scusava di non essere già partita e, anche quelli che sarebbero rimasti sempre qui a maledire il troppo caldo d'estate e il troppo freddo d'inverno, salutavano i 'partorienti' e allargavano le braccia dicendo 'tanto, ci vediamo dall'altra parte', e correvano dietro una siepe o dentro una stalla ad asciugarsi le lacrime” [p. 117].
**
Per Carlo Bo, “Tomizza ci dà la musica di quella stagione con tutte le inflessioni di un discorso che non vuole mai essere personale e peraltro si dispone in una visione più larga, più umana, senza per questo perdere quelle che sono le prime qualità: il senso della realtà, l'aderenza geografica, la perfetta intuizione di un mondo in via di disgregamento, o meglio di un mondo in trasferimento”.
E le ultime pagine sono piene di poesia e di malinconia, cinematografiche e oniriche. È “l'addio ai nostri morti”, degli ultimi esuli istriani. Fossi regista e volessi e potessi raccontare la tragedia dell'esodo, comincerei proprio da quella scena lì. Da queste parole qui:
“Cessarono le altre campane; soltanto la nostra resistette ancora per poco. Poi mostrò di voler finire anch'essa; ormai dava soltanto qualche forte e singolo rintocco, come scrollandosi tutta prima di morire. Anche il canto cessò. Ora non si sentiva che il caldo e i passi delle donne che strisciavano tra l'erba. Guardavo le tombe, e con tutta quell'erba parevano cumuli di terra sollevatisi sotto la schiena di grosse talpe. E pensavo ai nostri morti dalle orecchie e le nari piene di basilico; pensavo a tanta altra gente che era nata e cresciuta e poi finita là con un rosario e un libro nero tra le mani, e di cui ora non restava che ossa e ossa, le une sulle altre, e libri e rosari sparsi tra la terra. Mezzo ettaro di quella terra senza pietre era bastata per tutti; poteva bastare anche per noi e i nostri figli. 'Addio ai nostri morti', disse forte una donna”. [Explicit “Materada”].
EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE
Fulvio Tomizza (Giurizzani di Materada, frazione di Umago, Istria, Italia; 1935 – Trieste, FVG, Italia, 1999), scrittore e giornalista istriano. Esordì, come narratore, pubblicando “Materada” nel 1960.
Fulvio Tomizza, “Materada”, Bompiani, Milano, 1982. Ristampa: 2000. In appendice, biobibliografia e antologia critica. ISBN: 9788845244346.
Prima edizione: Mondadori, 1960.
Approfondimento in rete: WIKI it / Istrianet / Italialibri
Gianfranco Franchi, aprile 2012.
Prima pubblicazione: Lankelot.
Venticinquenne, lo scrittore istriano Fulvio Tomizza, da Giurizzani di Materada, Umago, esule a Trieste, esordiva con questo romanzo corale, lirico e contadino. Era il 1960.

One thought on “Materada”
Comments are closed.