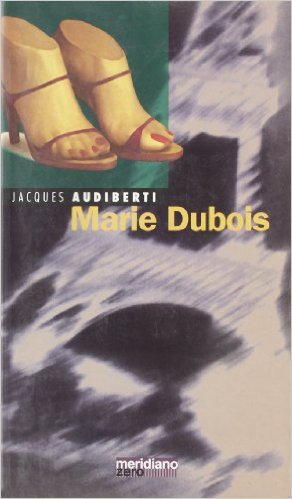 Marie Dubois
Marie Dubois
Meridiano Zero
2003
9788882370053

Truffaut apparteneva a quella élite di lettori capaci di riconoscere il genio, in un’opera narrativa, al primo impatto; e magari a dispetto della fortuna del libro, sempre naturalmente indifferente alla popolarità dell’autore. Così avvenne, ad esempio, per “Jules e Jim” del vecchio e misconosciuto Rochè. Non è stata data adeguata enfasi, invece, alla sua scelta di ribattezzare un’attrice, protagonista del suo secondo film “Tirate sul pianista” (1960) col nome dell’eroina d’un romanzo di Jacques Audiberti, “Marie Dubois”. Nessuno ricorda il nome di Claudine Huzé: nel mondo del cinema, è conosciuta soltanto come Marie Dubois. E a beneficio di chi ama le coincidenze letterarie e i cortocircuiti cinematografici, ricordo che recitava anche un ruolo nel film “Jules e Jim” (1962). Carter Horsley riporta le dichiarazioni del genio de “I quattrocento colpi”: eccome come è andata “(…) Actually I named her Marie Dubois, because her name was not good for an actress. Her name was Claudine Huzé (In French Huzé is pronounced like usée and means 'worn out.'). Since I liked that novel by Jacques Audiberti entitled Marie Dubois, which is a great portrait of a woman, I proposed that name to her and she agreed to be named Marie Dubois. And Audiberti was very happy”.
E così, la nuova, superba incarnazione letteraria dell’eterno femminino, contrastata e poliedrica e intensissima, diventava un’attrice dal nome parlante: diventava, in altre parole, potenzialmente qualunque ruolo in qualunque ambito. La marionetta vivente della donna ideale. Truffaut investiva Claudine del nome d’una donna delle donne. Il progressivo oblio italiano dell’opera di Jacques Audiberti, spezzato dalla pubblicazione di questo romanzo da Meridiano Zero nel 1999 e dal precedente “Il padrone di Milano” (Bompiani, 1950; 2007), poteva rendere indecifrabile l’ennesimo, criptato messaggio ai posteri e ai letterati di Truffaut. Così non è: se siete, allora, tra quanti non dubitano della sensibilità estetica di Truffaut, avete una ragione irrefutabile per non farvi sfuggire questo libro.
Jacques Audiberti (1899-1965) era giornalista, drammaturgo, poeta e romanziere. Già cronista del “Petit Parisien”, credeva che: «Il fatto di cronaca non è un mediocre romanticismo da portinaia. Ogni istante è imbottito di fatti di cronaca che si lanciano alla ricerca di angosce emiplegiche, di terrori infantili, di baruffe coniugali, di autobus mancati, a Parigi, nell’Universo. Il fatto di cronaca è la grande storia del quotidiano» (fonte: quarta di copertina dell’edizione MZ). Questo libro è la trasfigurazione e la sintesi artistica della sua visione della cronaca: diventa, progressivamente, altro dal genere teorico d’appartenenza (il noir) per stagliarsi come opera letteraria dalle suggestive e ipnotiche caratteristiche allegoriche. Niente di convenzionale: niente di prevedibile: niente di già letto, in un noir. “Marie Dubois” è piuttosto una postmoderna commistione di generi, tecniche di scrittura, tradizioni letterarie: sembra un noir ma vira nella lirica e nel simbolismo; ha tratti realistici, quasi da reportage o da osservazione partecipante, ma sfora nel surreale, e nell’allucinazione pura; gioca per dialoghi argot, quindi esplode nella pura letterarietà. L’antica scuola di chi amava Petronio, già.
Non solo: le descrizioni si rivelano ipertrofiche, inaspettatamente, e grondano sfumature e colori e luci; eppure certi nessi della trama sono così sottili da essere impercettibili. È come se la febbre della scrittura fosse più alta, il malato mormora (blatera o si dispera?) rapidamente qualcosa e infine, improvvisamente, ritrova lucidità e distende il pensiero, e le parole tornano a farsi luminose e forti. A questo s’aggiunga la certezza che Audiberti aveva pienamente interiorizzato la lezione stilistica di Céline, ossia l’invenzione dell’emozione del linguaggio scritto (cfr., per il concetto ma non per il pessimo libro in sé, il Céline-manifesto “Colloqui con il professor Y”), previa puntuale adozione dei puntini di sospensione nei passi-cardine del romanzo. L’atipico amalgama dà esiti inattesi e, se non unici, almeno eccezionalmente caratteristici e senza dubbio caratterizzanti. Entriamo nel libro da una delle sue ultime porte. “[…] solo che era morta. Nessuno l’aveva goduta. Nessuno l’avrebbe più goduta, tranne lui, in un’assenza reciproca in cui due anime senza ostacoli s’abbeverano l’una dall’altra all’infinito. È un inferno” (p. 180). È l’inferno del conflitto tra reale e ideale. È l’inferno di chi idolatra la bellezza e non può tollerare che sia toccata: il sacrilegio danna l’ossesso fanatico dell’ideale, lo danna al precipizio nella realtà. È la condizione dell’amore impossibile, d’un uomo che non aveva amato ancora, e non poteva forse amare altrimenti che un’idea: una bellezza morta che non poteva risorgere, e doveva quindi incarnare santità, verginità, innocenza. Una Beatrice che plasma il malessere, e rigenera e rinnova; estranea alla corruzione, estranea alla comprensione d’altri, posseduta nell’ideale e quindi immacolata. La realtà ha altri colori. È complessa, e composta di menzogne e di contrasti: ogni interazione se ne nutre, solo le idealità rimangono impossibili e pure.
L’ispettore Loup-Chair voleva studiare Medicina, ma la sentiva come indagine peggiore sull’umanità rispetto alla polizia: la cosa umana, “crepata, sanguinante, spappolata” era più vicina. Lui era uno studente senza studi. Uno di fronte al quale le facce si incattiviscono (p. 63). Già venditore fallito, “Era entrato nella polizia per guadagnarsi da vivere, si capisce, ma anche per imparare finalmente a vivere. In precedenza, aveva provato con i soliti lavori da niente, enciclopedie, assicurazioni, bisognava sempre bussare a casa della gente, davano guadagni meschini” (p. 85). Malinconico, impaurito e introverso, viveva nel costante, inappagato desiderio di una donna giovane (cfr., ad es., pp. 18-19), ma per le donne era invisibile. Vedeva tutto, ma non guardava niente (p. 97). Si sentiva come l’attore d’un mondo irreale, una comparsa che non aveva nessuna idea del copione. Così, un giorno, quasi s’emoziona di fronte all’ipotesi di attraversare i binari, in stazione; quando il danno è compiuto, si scuserà dicendo d’essere caduto senza farlo apposta. È allora che due destini, come in un film di Kieslowski o in una poesia della Szymborska, inspiegabilmente si sono intrecciati. Non vi dirò come, non qui.
L’ispettore Loup-Chair indaga sulla morte della giovane, bellissima Marie Dubois, suicida assieme al suo amante. Non appena vede il suo cadavere scatta l’innesco. È un sentimento d’amore totale, assoluto, immutabile: una chiara percezione d’appartenenza. Dovrà indagare e capire perché s’è uccisa, sognando che ritorni. Consapevole che le domande sono una tortura: “Ogni domanda è una tortura. Ogni domanda corrisponde a una crepa del mondo, una piaga buia e piena di vuoto, che non si può colmare se non con la sofferenza e la fatica di rispondere” (p. 74). E non può credere a quel che andrà scoprendo, alle multiple identità e alle altre vite di quell’angelo, intellettuale e operaio, puttana e santa. L’unica donna che davvero conosce è la morta Marie: vuole sapere tutto di lei, vuole strapparla alla morte, “sottrarla ai dedali del tempo” (p. 131). Perché “Egli sa, come se glielo avessero telefonato gli angeli, che quando saprà tutto di Marie, saprà tutto. Saprà tutto di tutto” (p. 126).
L’esito del romanzo rimane, in queste mie righe, un segreto. L’esito letterario di imprese come queste è parte del dna delle letterature occidentali: l’epifania della bellezza assoluta t’acceca; l’esteta divinizza, e idolatra. Il conflitto con la realtà è inevitabile, l’epilogo è un rifiuto drastico dell’esistenza, la sua conclusione o una sua trasformazione. Quel che è angelico t’annienta, o t’accompagna altrove, perché è un simbolo, ha cessato d’essere reale. Avvicinarlo è vano. È l’ultimo sguardo di von Aschenbach in “Morte a Venezia”, l’ultimo sogno, la fine della speranza.
Qualche nota, a margine, sulla fedeltà all’espressione del territorio: volevo evidenziare diversi aspetti. Lo sfondo è Parigi prima della guerra, sobborghi inclusi – si parla, ad esempio, del massello di Saint-Antoine, allora vi tenevano bottega numerosi ebanisti (cfr. nota a p. 110). La capitale viene raccontata anche così: “Aveva messo piede, per la prima volta, dentro la fortezza borghese della capitale, di cui finora aveva praticato soltanto i vestiboli pubblici, la metropolitana, i cinema osceni, i corridoi della Sorbona, i bagni di rue Saint-Denis, i corpi di guardia della polizia. Aveva raggiunto, era evidente, uno dei ricetti di quella grandeur francese, la sua, di cui conosceva appena la facciata storica (…)” (p. 65 per scoprire dove si trovava).
Altri elementi notevoli e peculiari: c’è qualcuno che, parlando, si definisce “tricard” (p. 139): la nota spiega che si tratta di una voce argotica riferita al detenuto colpito da divieto di soggiorno in determinati luoghi. La parola “Tricard” viene da “trique”, manganello: una minaccia costante.
Appare il fantasma – emblema una bombetta sulle ventitré – del “casseur d’assiette” (p. 105): il traduttore, Poletti, illumina: era un pittoresco imbonitore che lasciava cadere pile di piatti pur di non scendere al di sotto d’un prezzo imbattibile. Altrove viene nominato Poubelle, l’altrimenti dimenticato, civile inventore della pattumiera (p. 195). Non manca, a beneficio di chi vuole indagare il giornalismo d’antan, una descrizione suggestiva del rapporto tra reporter e polizia francese: cfr., ad esempio, p. 159, sulla raccolta delle notizie e sulla “monotona e tragica” sostanza dei fogli della sera e della mattina. “La quale sostanza, una volta diteggiata sui linotipi, calandrata nelle rotative, presenta un aspetto smorto, piatto e grigiastro, ben diverso dai burrascosi fattacci di sesso e coltello che pretende di raccontare, ma intrappolata, in fondo, non meno di quelli, nella crudele banalità delle cose”.
… che a ben guardare, se non fosse stato per la potente carica simbolica e per la letterarietà, sarebbe stata anche quella della vicenda della giovane suicida Marie Dubois. Questa la differenza tra cronaca e letteratura: la prima può ispirare, eccone la prova, la “grande storia del quotidiano”. Con stile, e originalità.
EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE
Jacques Audiberti (Antibes, 1899 – Neuilly-Sur-Seine, Francia, 1965), giornalista, drammaturgo, sceneggiatore, poeta e scrittore francese. Fino al 1940 fu attivo come redattore di cronaca al “Petit Parisien”, esperienza-madre del romanzo “Marie Dubois”.
Jacques Audiberti, “Marie Dubois”, Meridiano Zero, Padova 1999. Traduzione di Renato Poletti. Collana “Questa non è una pipa”, 2
Prima edizione: “Marie Dubois”, Gallimard, Paris 1952.
Gianfranco Franchi, agosto 2007.
Prima pubblicazione: Lankelot.
