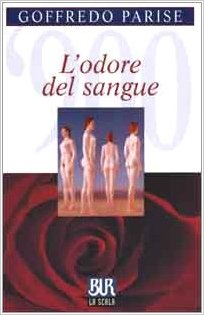 L'odore del sangue
L'odore del sangue
Rizzoli
2004
9788817001311

L'ultimo Parise, apparso undici anni dopo la morte dell'artista, nel 1997, è un romanziere esistenzialista ossessionato dal sesso: sembra più un Moravia, lascivo e crudo, che l'artista padre del “Ragazzo morto e le comete”. Del Parise delle origini è rimasta la lugubre fascinazione per la morte; spogliata, tuttavia, da ogni fantasia di vita altra, di vita-in-morte: niente affatto venata di surrealtà, niente affatto onirica. Scrive un narratore maturo che sente vicina la fine del suo mondo, dopo i problemi cardiaci, e scrive un uomo che ha dimenticato cosa significasse amare, appartenere, vivere simbiotici. Scrive un uomo che ha paura: ha paura di perdere la sua donna, ha paura di perdere il senso della loro relazione, ha paura di diventare adulto. Scrive un uomo che preferisce rifugiarsi in una relazione clandestina con una ragazza di venticinque anni, piuttosto che accompagnare sé stesso e sua moglie nel mistero dell'amore dei cinquantenni. Scrive un orfano di padre che padre non è diventato mai, patrigno soltanto: patrigno d'una generazione di letterati che hanno imparato a prendere le distanze da tutte le ideologie, hanno imparato a raccontare (interpretare) le guerre dimenticandosi di tutte le propagande, hanno imparato a parlare di letteratura col rispetto che sempre si deve agli artisti – alle loro manie, alle loro debolezze, alle loro fragilità, alla loro generosità (“Quando la fantasia ballava il boogie”).
Nella (superba) introduzione, il critico Cesare Garboli contestualizza a dovere l'opera, raccontandone genesi e conservazione negli anni: in sintesi, stando a quando scrive il primo gran curatore dell'opera di Parise, “L'odore del sangue” venne scritto – come spesso accadeva a Parise – senza revisioni, tutto di getto, come in estasi; quindi, venne chiuso in busta, con tanto di sigillo di ceralacca, e infilato in un cassetto. L'autore non voleva che fosse pubblicato mentre lui era in vita. Le ragioni sono abbastanza prevedibili: c'è qualcosa di incresciosamente personale in queste pagine, di tremendamente vero e partecipato, e Goffredo voleva forse difendere sé stesso da questa verità, diciamo così, e dimenticarsi d'averla pronunciata.
Parise racconta la storia d'una coppia che s'è sfaldata. Siamo a Roma, una Roma “noiosa, crudelmente realistica, cinica, papalina”. Loro due si chiamano Filippo e Silvia. Lui, come Parise, è figlio unico, orfano di padre, cresciuto da un buon patrigno. E proprio come l'artista vicentino ha preso e se ne è andato di casa a diciotto anni (“I movimenti remoti”), e ha vissuto la sua vita con dignità e compostezza, imparando ad annoiarsi soltanto in coincidenza con i primi capelli grigi.
Filippo soffre di noia, perché sente d'aver già dato tutto, d'aver tutto già vissuto; l'amore coniugale, dopo più di vent'anni, è diventato una sorta d'amicizia profonda, morbosa, asessuata. Stando a quanto ci racconta il narratore, il loro è stato un amore platonico, quasi sempre, un amore platonico “nutrito dalle assenze”; la carnalità sembrava un equivoco, sembrava qualcosa di futile. Non erano mancati tradimenti, più da parte di Filippo che da parte di Silvia; e nel caso di lei, sempre per senso d'abbandono, diciamo per ripicca.
Poi è successo qualcosa. Leggiamo l'incipit. “Ho guardato, anzi visto Silvia per la prima volta quando ho avuto la sensazione che mi tradisse. È questa una reazione diffusa, anzi banale, un po' meno banale quando ciò accade a un uomo di cinquantacinque anni come me per una donna di cinquanta come Silvia. È vero che Silvia è ancora quello che si dice una bella donna, 'ben tenuta', e anche piena di fascino, è anche vero che si può essere gelosi a tutte le età (…) ma nel mio caso non si trattò di gelosia, cioè di una passione antica come il mondo, bensì di curiosità, anch'essa una passione terribile ma di pochi e molto moderna” (p. 9).
E così lui, solitario e sfuggente, ha perso la testa: ha perso la testa quando Silvia ha cominciato a comportarsi come lui, convinta che “non ci fossero esclusive”, che potesse avere una sua vita sentimentale altra, piena e completa contemporaneamente a quella matrimoniale.
L'altro – quello che sta cancellando Silvia dal mondo – è connotato con aggettivi neri sin dal principio: “pericoloso”, “buio”, “tragico” (p. 11); altrove, “scorbutico”, “antipatico”, “disadattato”, confusionario”, “violento”. La descrizione del rivale è quella d'un giovane di destra che sembra uscito dritto dritto dal vecchio e scorretto “Il fascistibile” di Giulio Castelli (1973): ha venticinque anni, viene da una famiglia borghese romana, generona e papalina, è un bamboccione col culto della virilità e della violenza, appartiene a Ordine Nuovo (altrove, senza fronzoli, MSI), frequenta ragazzi ignoranti e aggressivi, fissati con “guerra”, “sangue”, “catarsi della guerra”, “solitudine virile”, specie di banda di “picchiatori borghesi e missini” col culto della palestra (p. 137). Questo giovanotto è certamente “nevrotico come mille altri”, borgatari, sottoproletari, borghesi, “frutto di quel mutamento, di quella omologazione antropologica di cui parlava Pasolini” (p. 230).
Cos'ha di diverso da Parise? Se vogliamo parlare col linguaggio dello scrittore vicentino, in questo romanzo, dovremmo dire che a parte la politica (cfr. “Verba volant” per i suoi giudizi sui missini) è una questione di fascino. Cioè, di cazzo:
“Fascinum era la parola che designava in latino il cazzo, e, appunto, il cazzo, cioè la forza tanto propulsiva quanto irruente del cazzo, è il significato della vita stessa. Se non ci fosse il cazzo non ci sarebbe vita. Questo a vent'anni non si sente e non si sa. Si usa il sesso come una fonte di piacere, come bere, mangiare, dormire, insomma nutrirsi. In età più avanzata, per l'esperienza e la riflessione, questo uso diventa tanto più indiretto quanto più è mentale. E si è automaticamente attratti verso i giovani che usano il cazzo in modo incosciente, senza pensieri, come una macchina sempre perfettamente funzionante a proprio piacere. Perfino, si crede, a propria volontà” (p. 112).
Il narratore sembra ossessionato dal sesso del suo rivale. Si fa descrivere, man mano, tutto quanto da sua moglie: vuole sapere com'è fatto, che cosa fanno assieme, quante volte lei viene, e come viene, e quante volte s'inginocchia per una fellatio. E se le piace, e via dicendo. Il nemico del narratore è un giovane descritto col massimo disprezzo – l'epilogo orgiastico e funebre della vicenda peggiora le cose – non tanto per questioni ideali o politiche, che man mano sfumano, s'attenuano e si dissolvono, quanto per questioni sessuali. È la giovinezza che spaventa chi l'ha perduta, perché se ne sente sovrastato. Filippo vive in una “passività narcotica”, come se fosse uscito da poco da un intervento chirurgico: non riesce a decidere più le sorti del suo matrimonio, non riesce a strappare via Silvia dalle mani – dal cazzo – del ragazzino fascista.
La disperazione coincide con la consapevolezza che Silvia è destinata all'autodistruzione. “La disperazione mi spinse a fare tre cose e da queste tre cose si può capire fino a che punto proprio la disperazione fosse la spia della mia impotenza e ancora una volta del terrore puro e semplice. Per prima cosa andai a trovare mia madre, poi un mio collega psicoanalista, infine un prete. Come si vede, le tre tappe non sono casuali e rispondono per così dire a una casistica: andavo a trovare mia madre spinto dal terrore esattamente come fa un bambino quando ha bisogno immediato di essere protetto. Lo psicoanalista perché, una volta tranquillizzato dalla presenza e forse dall'amore di mia madre per me, avrei cercato di esporre le mie idee e presentimenti a un medico che conoscevo bene e dunque in certo modo alla scienza; infine il prete perché, non avendo mai creduto in Dio, speravo però, a questo punto, di riuscire a crederci” (p. 124).
**
E intanto lui sente, come una bestia – una bestia vecchia, e non ancora sconfitta – l'odore del sangue. “Dolce, un po' nauseabondo e un po' esilarante, ma soprattutto dolce, e dolcemente funebre”; un odore che conosce bene ed è, a pensarci, “l'odore dell'origine della gioventù, della passione, della vita”. L'odore di tutto quel che poteva essere e non è più stato, l'odore di quel che è stato, l'odore della fine di tutto – per prima, della donna amata per quasi trent'anni; forse perché non puoi averla più, e forse non l'hai mai avuta. Completamente, veramente, non l'hai mai scopata come quel ragazzino. E se è successo, l'hai dimenticato. E quindi è come se non fosse successo mai.
Un congedo terribile, brusco, doloroso. Mostruosamente leggibile – come tutto quel che Parise ha scritto – e chiaro sino all'eccesso. “L'odore del sangue” è la storia d'un chirurgo che opera un'anima morente e la scarnifica e la disossa per curarla: invano. Si vede che questo chirurgo non aveva capito un cazzo.
EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE
Goffredo Parise (Vicenza, 1929 – Treviso, 1986), scrittore, sceneggiatore e giornalista italiano.
Goffredo Parise, “L'odore del sangue”, Rizzoli, Milano 1997. A cura di Cesare Garboli e Cesare Magrini.
Prima edizione: inedito, fu scritto nel 1979.
Approfondimento in rete: WIKI it / Casa di Cultura Goffredo Parise
Gianfranco Franchi, Marzo 2010.
Prima pubblicazione: Lankelot.
L’ultimo Parise, apparso undici anni dopo la morte dell’artista, nel 1997, è un romanziere esistenzialista ossessionato dal sesso: sembra più un Moravia, lascivo e crudo, che l’artista padre del “Ragazzo morto e le comete”…
