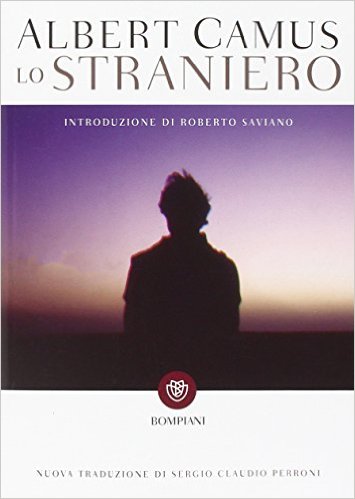 Lo straniero
Lo straniero
Bompiani
2015
9788845277634

“Cosa mi importavano la morte degli altri, l’amore di una madre, cosa mi importavano il suo Dio, le vite che ognuno si sceglie, i destini che un uomo si elegge, quando un solo destino doveva eleggere me e con me miliardi di privilegiati che, come lui, si dicevano miei fratelli? Tutti sono privilegiati. Non ci sono che privilegiati” (“Lo straniero”, parte seconda, capitolo XI).
Un telegramma, in apertura, annuncia al protagonista del romanzo, Meursault, modesto impiegato di Algeri, la morte della madre. Era ricoverata già da tempo in una casa di riposo, a sessanta chilometri da Algeri, a Marengo. Meursault sembra non tradire nessuna emozione. Non piange, non si dispera, non si abbandona al ricordo. Si prepara, e parte. Si congeda dalla madre. Restando freddo. All’opposto, registra con maggior interesse la variopinta umanità dell’ospizio. Dialoga con il portinaio d’origine parigina, studia con attenzione le reazioni commosse degli altri degenti, tenta senza convinzione di giustificarsi con il responsabile della casa di cura per la sua distanza dalla madre negli ultimi anni. Partecipa al funerale, abulico. Sogna soltanto di dormire. Di ritirarsi da quella scena e da quelle persone. Svanire.
Meursault riparte il giorno dopo per Algeri. Torna a frequentare una ragazza conosciuta tempo prima, Marie Cardona. Lei domanda come mai indossi una cravatta nera. Mia madre è morta da poco, risponde. Da quanto, insiste la ragazza. Da un giorno, risponde. Poi vanno al cinema. Distacco, fuga dal dolore. Indifferenza, e trionfo laconico dell’assurdo? Sartre avrebbe giurato fosse l’assurdo. A noi sembra totale estraneità all’esistenza, e abiura dell’umanità. Nata dal dolore, forse. Meursault torna alla consueta quotidianità. Lavoro, poi passare del tempo con Marie.
Un giorno, invitato da un vicino di casa, Raymond, lascia Algeri. Mentre cammina sulla spiaggia con l’amico, incappa in due arabi, sulle tracce di Raymond per vendicare una donna. Discutono. Raymond viene ferito. Non finisce così. Casualmente, poco più tardi Meursault ritrova i due aggressori. Uno di loro estrae un coltello. Lui, in tasca, ha una rivoltella. Spara. E spara altre tre volte sul corpo inerte dell’arabo assassinato. Senza che ce ne fosse ragione. Non è sensibile di fronte alla morte. Così termina la prima parte del romanzo.
“Standing on a beach / With a gun in my hand / Staring at the sea / Staring at the sand / Staring down the barrel / At the arab on the ground / See his open mouth / But hear no sound / I'm alive / I'm dead / I'm the stranger / Killing an arab”. (Robert Smith, The Cure. “Killing an arab”).
Nella seconda, Meursault è stato arrestato: si trova in carcere da tempo, e sembra osservare gli avvenimenti con lo stesso distacco di sempre. Non importano gli interrogatori, le istruttorie, le testimonianze dei suoi amici: Meursault contempla quel che accade senza intervenire, senza lamentarsi, senza controbattere.
Non ha rimorsi, non ha rimpianti. Rifiuta d’esser qualsiasi cosa. È estraneo a qualunque umanità. Straniero in terra di stranieri.
Non vuole giustificarsi. Non crede di doversi giustificare di nulla. Gelido più ancora dell’immoralista di Gide. L’immoralista è frivolo e tutto dedito ai suoi estatici abbandoni, venati d’intellettualismo e torbido erotismo. Lo straniero non partecipa a nulla, non sente niente, osserva. C’è un fondo di meraviglia nelle sue osservazioni, questo sì. Nello studio minuzioso delle reazioni e degli atteggiamenti dell’ultimo amante della madre, o della dialettica degli avvocati nei giorni del processo, c’è una larvale attenzione all’alterità. Tutto, d’un tratto, si spegne: lo straniero s’annoia a sentir parlare di sé.
“Whichever I choose, it amounts to the same. Absolutely nothing”. Proprio come cantava Robert Smith, nel suo ispirato omaggio al romanzo, “Killing an Arab”. Qualunque cosa scelga, in fondo non cambia nulla. C’è solo un momento in cui lo straniero sembra cedere al suo disprezzo per quel che sta avvenendo e al dolore, rinunciando alla sua inviolabile serenità: quando, dopo tre tentativi andati a vuoto, un religioso riesce a presentarsi per confortarlo, a poche ore dalla condanna a morte. Perduto ogni freno, lo straniero grida e sbraita e denuncia la sua morte in vita, e la casualità; e l’assurdità di tutto quel che capita. Poteva non uccidere l’arabo sulla spiaggia. Poteva piangere di fronte alla salma della madre. Poteva sposare Marie, poteva giurare la sua innocenza. Poteva. Avrebbe potuto. Il sacerdote si allontana con le lacrime agli occhi.
Pubblicato nel 1942, “Lo straniero” è strutturato in due parti, composte rispettivamente da sei e da cinque capitoli, nessuno dei quali provvisto di titolo. Nel febbraio del 1943, nel saggio “Explication de L’Étranger”, raccolto poi nel primo volume di “Situations”, Sartre scrisse: “Non si tratta, per Camus, di fare collezione di massime pessimiste… dal momento che il carattere essenziale dell’uomo è ‘essere nel mondo’, l’assurdo si identifica con la stessa condizione umana”. Si va a scomodare il segreto del Sileno, in altre parole.
Ancora, più avanti: “Non è un libro che spiega; l’uomo assurdo non spiega, descrive”. Quest’ultima affermazione mi sembra condivisibile. Non c’è spiegazione – almeno, non fino alle ultime battute del libro – in questo romanzo. C’è desolazione, e pieno e fitto descrittivismo. Qualcuno ha sostenuto che ci fosse una sorta di resa iper-realistica della narrazione in più di una pagina del romanzo; personalmente, bandirei qualunque spettrale interpretazione analoga in un’opera del genere. “Lo straniero”, al limite, è un romanzo a metà strada tra il simbolismo e il proto-esistenzialismo. Un ibrido che brandisce sprazzi di realismo come armi per incidere più a fondo il proprio messaggio nello spirito del lettore.
Il messaggio è che nulla davvero ha senso, e che tutto capita. Perfino la vita, perfino la morte. Non c’è niente di sacro. È un istante e una coincidenza. Tutto.
Non sembra aver più senso neppure ribellarsi. Testimoniare. Questo è già molto. Mantenersi lucidi nelle tempeste emozionali di tanti, di tutti. Difendere la propria umanità straniera dalla soverchiante e prevaricatrice, ormai estranea, umanità.
La lingua di Camus è sobria, scarna e asciutta. Periodi mai ridondanti, aggettivazione misurata. L’impianto formale riflette la solidità dell’impianto strutturale. Si indaga la natura dell’essere umano. È necessario scarnificarsi e dimenticarsi di se stessi. È necessario perdersi in uno dei propri spettri. E accettare d’affrontare in un processo il giudizio dei cittadini. Dei simili, divenuti “similari”. Non rispettano neppure la morte. Sciacalli.
“Quando un giorno il guardiano mi ha detto che ero lì da cinque mesi, gli ho creduto, ma non l’ho capito. Per me era sempre lo stesso giorno che scorreva nella mia cella, e io percorrevo sempre la stessa via.(…) Finiva il giorno ed era l’ora di cui non voglio parlare, l’ora senza nome, quando i rumori della sera salivano da tutti i piani della prigione in un corteo di silenzio” (“Lo straniero”, parte seconda, capitolo II).
Il tempo non scorre più. Sospeso.
EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE.
Albert Camus (Mondovi, Algeria, 1913- Villeneuve-la-Guyard, Francia, 1960), dottore in Filosofia, tragediografo, romanziere, saggista e giornalista francese d’Algeria. Premio Nobel per la Letteratura, 1957.
Albert Camus, “Lo straniero”, Bompiani, Milano, 1973. Traduzione di Alberto Zevi. Collana: i piccoli delfini, 16.
Prima edizione: Albert Camus, “L’étranger”, Gallimard, Paris, 1942.
Gianfranco Franchi, 19 aprile del 2003.
Prima pubblicazione: Lankelot.
“Quando un giorno il guardiano mi ha detto che ero lì da cinque mesi, gli ho creduto, ma non l’ho capito. Per me era sempre lo stesso giorno che scorreva nella mia cella, e io percorrevo sempre la stessa via”
