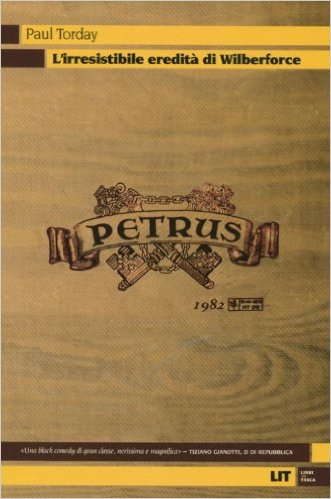 L'irresistibile eredità di Wilberforce
L'irresistibile eredità di Wilberforce
Elliot Edizioni
2009
9788861920811

“Catherine gli porge il vino, poi si avvicina a me con l'altro bicchiere. 'E tu, Wilberforce?”. E io? La domanda apre tante possibilità. Accetto il vino, e in quel momento le sue dita, raffreddate dal vetro, sfiorano appena le mie. Non ritira subito la mano, e invece mi guarda, per un attimo i nostri occhi si incontrano. Nella sua espressione vedo un'aria curiosa, disorientata. Poi mi lascia il bicchiere in mano. Non apro bocca, nemmeno per ringraziarla. Non riesco a parlare. Lei non sorride né dice nulla, aspetta un momento solo prima di voltarsi e tornare in casa a passo lento. Chi sei tu? Chiede il suo sguardo. Cosa sei tu? Conosco la risposta. Non sono nessuno. Sono chiunque. Posso scegliere di essere chi mi pare. Mi volto con il bicchiere in mano a guardare il cielo dorato” (Torday, “L'irresistibile eredità di Wilberforce”, p. 312).
“L'irresistibile eredità di Wilberforce” (omaggio a “La fiera delle vanità” di Thackeray) è una tetra discesa negli inferi dell'alcolismo; nelle prime battute, paradossalmente, sembra un magnifico romanzo edonista e solare, inno ai piaceri della vita, all'arte di degustare il vino – e il pensiero vola a quella notevole commedia americana di Pickett, “Sideways”, tradotta in un fortunato film. Quindi, poco a poco, si precipita nella morte – nel male; tra coma etilico e sciagurato incidente alla moglie del narratore, in poche battute è svanita, s'è dissolta davvero, ogni minima fascinazione per il vino. Difficile non accostare quei frangenti a un must della letteratura inglese contemporanea come “Il suono della mia voce” di Butlin – stessa percezione di inevitabilità, di maledizione, di intelligenza dominata dall'alcol, con una scrittura diversamente equilibrata e matura, senza quell'impressionante escamotage costituito dalla narrazione in seconda persona singolare dell'artista scozzese.
Secondo romanzo dello scrittore inglese Paul Torday, “L'irresistibile eredità di Wilberforce” è raccontato in analessi: si parte dal 2006, si scende – man mano – nel 2004, nel 2003, nel 2002. Torday ha preferito concentrarsi sulle dinamiche e sulle vicende esistenziali che hanno trascinato il suo personaggio nell'autodistruzione e nella distruzione della vita della sua compagna; si sprofonda nel suo passato, poco a poco sempre più solare, scoprendo che si trattava di un programmatore informatico di genio, uno che campava di rendita, che viveva tuttavia senza pienezza e senza entusiasmo; senza amore, e con la sensazione di essere inadeguato, sgradito, non desiderato: sin dall'infanzia. Tutto sarebbe cambiato per via di un incontro. Un incontro con una sorta di alter ego più anziano, umanissimo e diabolico al contempo, ossesso dal culto del vino e dal consumo – inevitabile, quotidiano, abnorme – del vino di qualità. Francis Black, eccelso conoscitore di vini, trasmetterà la sua passione a chi nemmeno sapeva cosa fosse l'alcol; la sua passione e la sua straordinaria cantina, assieme al gusto di vivere la vita con pienezza, intensità, entusiasmo. Amore.
Il vino però ti può trascinare via; non serviva leggere Butlin o Torday per saperlo, forse, ma è necessario interiorizzarli per non lasciarsi sfuggire mai questa consapevolezza. È un alleato per la socialità e per il piacere che non può e non deve trasformarsi in un terrificante e invincibile tiranno, un dominatore dei tempi e dei colori delle tue giornate. Torday scava e illustra la vita di un personaggio che sembra vincitore e si rivela incredibilmente, totalmente sconfitto: su tutta la linea. Diventa – e lo scopriamo subito, come vi accennavo, per la particolare struttura dell'opera – un edonista, alcolista e collezionista che si sbronza bevendo solo bottiglie di altissima qualità, come il Petrus 1982 che campeggia in copertina. Annate rarissime e costosissime, accompagnate da piatti meravigliosi. E da crolli verticali del fegato, del fisico, del cervello. Quando qualcuno, come Wilberforce, scrive o dice che “il vino non è alcol” (p. 31), che anzi definire il vino alcol è “un gesto insensibile e gretto”, si direbbe proprio avviato alla fine. “Berrò ciò che posso per tutta la vita che mi resta” (p. 40), annuncia, ben sapendo che sarà poca. Wilberforce finisce per sfondarsi con cinque bottiglie al giorno, cinque. Gli alcolisti anonimi non possono nemmeno fronteggiare un disastro del genere; s'è stabilito un rapporto simbiotico, inevitabilmente amnesico, e dolorosamente totalizzante. Qualcuno parla di psicosi di Korsakoff (p. 63), ma non so quanto senso abbia approfondirla o nominarla.
Si legge questo romanzo desiderando che possa essere soltanto letteratura, nera ed esistenzialista, e che episodi come questo e vite come questa non siano mai state vissute. È un clamoroso sbaglio. Ho visto scaffali popolati di superalcolici, in case spoglie di complementi d'arredo; e cantine osservate con uno sguardo adorante da qualcuno che non era un sommelier. Mi sono accorto che tutto quell'alcol andava a sublimare qualcosa. Amore, in generale, certo: ma anche personalità. Potente sedativo, a certe piccole dosi, esplosivo innesco di fragilità nervose o stati di stress, d'ansia e d'angoscia, in dosi elevate. E sempre l'alcolista che ti dice di non esserlo. Di trovare normale la presenza del vino – sempre il vino, mai la birra: non so perché – nella sua vita. Di trovare logica la spesa di decine di euro, quando rimane a un livello medio e non si concede al fanatismo, per una sola bottiglia di vino. Ho sentito questa gente discutere delle differenze tra i tappi. E prendere come scusa le degustazioni per potersi rintronare a oltranza, mangiando (poco) e bevendo (poche bottiglie: tanti bicchieri). Sembrava sempre che il vino fosse il migliore amico, l'amante sognata. Il vino era sempre complice e presente. Sei malinconico, bevi. Sei allegro, bevi. Sei da solo, bevi. Sei in compagnia, che fai? Bevi. Alcol.
È come in quel racconto del gran russo Kržižanovkskij: parlo del gotico “Il calice fumé”. È “improsciugabile”, quel “monopode”: e Kržižanovkskij inventa la storia d’un personaggio che ne aveva rilevato uno contenente vino invecchiato di mille anni, da un misterioso antiquario (il lettore italiano contemporaneo pensa, senza faticare, al vecchio Mister Hamlin della Safarà di Dylan Dog): sul fondo, aveva delle lettere incise. La prima, senza dubbio, era una “alfa”. Le rimanenti undici restavano indecifrabili. Perché la ragione e l’origine del male non si possono pronunciare, né comprendere: lasciarle indefinite – peggio, considerarle impronunciabili – giustifica l’insistenza nell’errore (la dipendenza: non più vizio, né divertimento; adesione incrollabile).
Torday ha esordito molto tardi, in Letteratura, dopo anni dedicati ad altre attività (commerciali). Questo suo secondo libro è bello e fa male, è triste e a volte fa sorridere, in generale fa disperare. E quando, grazie alla disposizione della materia, ci accorgiamo che sì, c'è stato un inizio; e, sì, le cose forse potevano essere molto diverse, allora credo che serva ringraziare l'artista, essergli riconoscenti, in assoluto, perché... perché forse sta evitando morte, sofferenza e squallore a qualcuno di noi. Dominiamoci: dominiamo il piacere. Quando il piacere ti domina, il piacere ti distrugge.
Potente, nero, cupo, necessario. Ecco una nuova cognizione del male.
EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE
Paul Torday (UK, 1946-2013), scrittore inglese. Ha studiato Letteratura Inglese a Oxford. Questo è il suo secondo romanzo. Ha esordito pubblicando “Pesca al salmone nello Yemen”; nella vita precedente è stato un businessman del Northurmberland.
Paul Torday, “L'irresistibile eredità di Wilberforce. Un romanzo in quattro vendemmie”, Elliot, Roma 2009. Collana “Scatti”. Traduzione di Luca Fasari.
Prima edizione: “The irresistible inheritance of Wilberforce. A novel in four vintages”, 2008.
Gianfranco Franchi, aprile 2009.
Prima pubblicazione: Lankelot.
