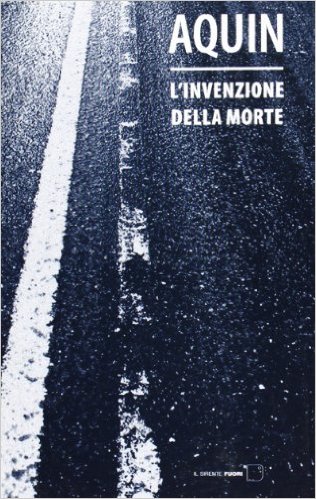 L'invenzione della morte
L'invenzione della morte
Il Sirente
2010
9788887847246

“È una buona cosa ritrovarsi soli in una camera d'albergo ben chiusa, camminare nudi sul tappeto in fibra, guardarsi a lungo allo specchio e decifrare sul proprio viso i segni che si è abituati ad analizzare sulle linee della mano. Attendendo che la vasca da bagno si riempia fino all'orlo, mi guardo nudo nel riflesso dello specchio, come un ricordo stereotipato. Il pallore, è il sovraffaticamento degli ultimi mesi al giornale. Le occhiaie violacee, e il peso invisibile che tira le labbra verso il basso, è Madeleine. Negli d'occhi d'un blu spento, che mi trafiggono freddamente, riconosco la mia disperazione, o forse la follia. Ho il volto dell'autunno che finisce” (Aquin, “L'invenzione della morte”, p. 5).
Primo libro scritto da Hubert Aquin, scrittore e intellettuale francocanadese morto suicida nel 1977, nemmeno cinquantenne, “L'invenzione della morte” è apparso postumo nel 1991. Siamo dalle parti della scrittura scarnificata, idealmente curativa: siamo dalle parti di quel disperato tentativo di guarigione dalle ferite dell'anima che a volte riesce nel miracolo, altre volte semplicemente annuncia il sentiero dell'autodistruzione. In questo frangente, si direbbe che l'esorcismo sia riuscito. La morte chiamata e invocata come una liberazione dal presente e dal niente l'artista è riuscito a scacciarla per un bel pezzo. Ma non ha saputo resistere dalla tentazione di essere padrone di darsela, qualche anno più tardi.
“L'invenzione della morte” è la storia di René Lallemant, giornalista di un buon quotidiano del Quebec in crisi esistenziale, e del suo grande e clandestino amore per Madeleine. Lui è uno che sembra massacrato da un male di vivere che non conosce fine, né origine. “Della mia vita – scrive – io non conosco che i tempi morti. […]. La morte è divenuta un'abitudine, la vita un piacere rubato al caso” (p. 24). Le sue medicine – le soluzioni al male – sono il corpo di Madeleine, e il whisky. Niente altro. L'amore con lei sa essere quello “dei due amanti novelli, appena scaturiti dal fango della terra” (p. 41). La sofferenza di René è l'incontro col nulla: la coscienza di nulla sentire. E che nulla esiste.
Così: “Non provo più nulla, sprofondo lentamente nell'inesistenza. Il mio corpo è un ricordo, il mio viso lo stampo impaziente d'una maschera mortuaria. Il piacere, che cos'è in fin dei conti? Io ho disimparato l'estasi e il suo arrivo abbagliante attraverso i canali segreti del sesso. Io non so più nulla […] Ciò che ora temo di più è il sonno” (p. 57).
René crede che il linguaggio sia un'abitudine. Che serva una “lenta fermentazione del sentimento” e una sorta di “consenso ante litteram” per correggere il destino di due lessici che non comunicano. E intanto avanza, sul sentiero del niente – preparandosi al male. “Io non ho più paura di nulla” - scrive. “L'angoscia mi ha abbandonato strada facendo; l'angoscia, in fondo, non è che un derivato della speranza, e io sono senza avvenire” (p. 125).
Si sente solo. È solo. È stanco di nascere e morire due volte a settimana, tra le braccia di Madeleine. Vuole suicidarsi per questo, vuole fuggire da tutto il resto. La sua disperazione va facendosi calma, man mano. È come se René avesse fame di finirla: è come se pretendesse la sua sconfitta, il suo annientamento. Tutto è finito, proprio come ha scritto al principio del viaggio. “Tutto è finito”: una frase “che non vuol dire niente, non contiene niente, e comunque sembra la brutta copia di un melodramma. Nessuna espressione può coprire adeguatamente la morte del reale e la distruzione di ogni significato” (p. 153). Vero? Davvero è così? Il Novecento è stato il secolo d'un nuovo genere narrativo: chiamiamolo “narrativa suicida”. E l'impresa di questa narrativa suicida, e di questi narratori (di lì a poco) suicidi, è stata proprio rappresentare “la morte del reale e la distruzione di ogni significato”. Qualche esempio: naturalmente penso al “Fuoco fatuo” [1931] di Drieu La Rochelle che Aquin non poteva non avere letto. Penso a tutto quel che scrisse il povero Jacques Rigaut. Penso al nostro Guido Morselli, col magnifico “Dissipatio H.G.” [1973]. Penso ai “Taccuini” del povero Otto Weininger [1903]. Potrei andare avanti a oltranza, mi fermo qui. Che c'è che non va? C'è che dopo tanti anni di lettura di narrativa suicida comincio a sentirmi stanco di scrivere sempre lo stesso articolo. E ho già letto “Il Dio selvaggio” di Al Alvarez [1971], per dire. E ne ho scritto. Aquin sembra un discreto narratore, espressione d'una letteratura sin qui chiaramente derivativa ma non sempre minore come quella canadese in lingua francese. La sua letteratura non rappresenta niente di nuovo, e così la sua smania autodistruttiva, tutt'altro che infrequente tra gli artisti. Diciamo questo, ho scoperto Aquin pensando “un altro ancora”. E l'ho letto senza stupirmi più di niente. Perché ben conosco questo “niente”. Avanti il prossimo.
EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE
Hubert Aquin (Montréal, Canada 1929 – Montréal, Canada 1977), scrittore, sceneggiatore, regista e giornalista del Québec. È stato direttore della rivista “Liberté” dal 1961 al 1971 e direttore editoriale delle Editions La Presse negli anni Settanta.
Hubert Aquin, “L'invenzione della morte”, Il Sirente, Fagnano Alto 2010. Traduzione dal francese di Maria Antonietta Fontana.
Prima edizione: “L'invention de la mort”, 1991.
Gianfranco Franchi, novembre 2010.
Prima pubblicazione: Lankelot.
