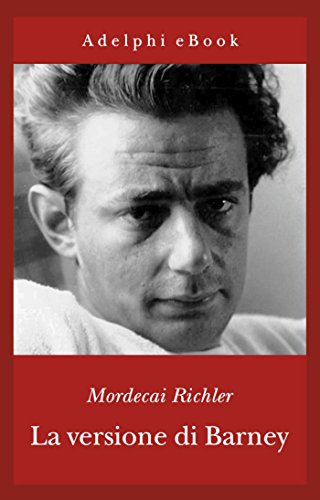 La versione di Barney
La versione di Barney
Adelphi
2005
9788845919824

Esiste, probabilmente, un momento nella vita di ogni uomo deputato ad una contemplazione finalmente più serena del cammino della propria esistenza. Quanto più affascina e rapisce, in questo ultimo romanzo di Richler, è la possibilità che questo momento contemplativo possa essere tutt’altro che pacifico e spoglio di inquietudini. Si tende a ritenere che il trascorrere del tempo attutisca i sentimenti, suturi le ferite, assopisca le passioni. Si spera, forse, che sia così, desiderando sin dalle prime avvisaglie d’una stanchezza non più fisica, ma spirituale, che sia possibile, un giorno, liberarsi dal peso delle responsabilità originate da un’intera esistenza. Tornano in mente, tuttavia, le parole di un monologo di “Magnolia” del geniale regista Paul Thomas Anderson: sul letto di morte, Earl lentamente ci ammonisce, ricordandoci una lezione che credo si ripeta in queste pagine. Sia lecito questo bizzarro paragone tra opere differenti: vedremo in seguito di approfondirne la ragione. Non si tratta, ovviamente, solo di affinità linguistica, stilistica e concettuale.
“Questo è il rimpianto che ho dentro, e che mi porterò dietro. Questo è il rimpianto che ho dentro, e che mi porterò dietro, e che…bla bla bla bla, parole, parole, parole. Non devi fare errori…come questo. A volte capita…di farne alcuni, va bene, sì, ma non va bene se continui a farne altri. Già. Sai che potresti essere migliore. Io amavo Lily, però l’ho tradita. È stata mia moglie per ventitre anni…[…]. L’amavo così tanto, e lei sapeva tutto, ha sempre saputo le maledette stupidaggini che ho fatto. Ma il nostro amore era più forte di qualunque altra cosa… ma questi maledetti rimpianti. Questi maledetti rimpianti. E io morirò, adesso morirò, e ti dico una cosa: il più grande rimpianto della mia vita… è quello di aver lasciato andare via il mio amore. Ho sessantacinque anni, e provo vergogna. Anche milioni di anni fa i maledetti rimpianti per la colpa, erano…non permettere a nessuno di dirti che non devi rimpiangere niente…non permetterglielo, non farlo…tu rimpiangi tutto quello che vuoi…usalo, usa il rimpianto per qualunque cosa e come pare a te…oddio…questa è l’unica maniera per andare avanti senza subire contraccolpi…una piccola storiella moralistica, la definirei…già…amore, amore, amore…questa vita del cazzo…oh…è così difficile, così lunga…la vita non è corta, è lunga, è lunga, porca puttana… che cosa ho fatto, che cosa ho fatto, che cosa ho fatto…aiutami, che cosa ho fatto”.
“La versione di Barney” è uno studio autobiografico del cammino d’una intera esistenza: la scoperta, o la conferma, se preferite, che risentimento, nostalgia, odio, livore e passioni possono rimanere miracolosamente intatti. E la rivelazione che il sarcasmo, il cinismo e il disincanto altro non sono che uno degli epiloghi del sentiero esistenziale di un idealista. Perché il protagonista del romanzo, giunto al termine della sua notte, si volta indietro e ricostruisce gli eventi della sua esistenza attraverso i tre matrimoni e i tre figli, attraverso il ricordo, sempre più confuso, degli anni giovanili di vita parigina, giovane canadese di origine e cultura ebraica partito alla ricerca di chi riteneva potesse esser puro e potesse mutare le sorti del mondo: gli artisti. Barney racconta l’intera parabola della sua vita, combattendo con i sempre più frequenti vuoti della sua memoria, insistendo sulla perfezione sublime di quello che sarebbe stato, in fondo, l’unico vero amore della sua vita: Miriam, l’ultima moglie e la madre dei suoi figli, compagna che aveva adorato sin dal primo istante in cui l’aveva incontrata. E tratteggia uno spaccato e della comunità degli artisti, della bohème, per intenderci, a metà strada tra il Quebec, Parigi e Londra, e della ricerca d’un uomo, ricerca che è amore e ispirazione, e della società contemporanea: concentrandosi principalmente sulla sua realtà culturale, quella canadese francofona, e sul legame che unisce gli ebrei della diaspora.
Opera dunque, questa, che parrebbe inizialmente una revisione aspra e piena d’ironia d’un’intera vita. Una sorta di lentissima proiezione cinematografica d’un film impossibile da montare. Ed ecco, come il lettore si attende, iperboli, confusioni e dimenticanze, improvvise digressioni sull’arte e sugli artisti contemporanei e sconquassanti alternanze di ossessioni sportive e ossessioni amorose. Libro strutturato in tre parti, si diceva, ognuna dedicata ad una delle tre consorti del Barney Panofsky: e concluso da un breve poscritto del figlio maggiore del protagonista, nella finzione letteraria curatore delle sue progettate memorie. Il volume è ornato da un piccolo glossario yiddish.
Ho meditato a lungo, prima di inserire quel frammento di monologo estratto da “Magnolia”. Mi è sembrato, analizzando a suo tempo le recensioni apparse sui quotidiani e sulle riviste, che dell’alter ego del Richler si sia osannato il sarcasmo, la cruda e intelligente ironia, la disinibita facilità nel raccontarsi e nel divertire il lettore con la narrazione dei propri eccessi etilici e verbali: per non tacere poi del macabro e nauseante tentativo delle nostre coalizioni politiche di appropriarsi dello spirito dell’opera per tinteggiarla del colore preferito. A questo proposito, rinvio ai due brevi saggi indicati nella bibliografia, curati da Matteo Codignola, traduttore dell’opera, e Concita De Gregorio: interessanti testimonianze del risentimento, spesso non proprio risentimento divertito, alla Barney per intenderci, di chi ha assistito ad una speculazione politica di bassissima lega. Io aggiungerei che una delle peggiori disgrazie di questo volume sia nella sua potenziale ghettizzazione, temo prossima ad avvenire, nel genere letterario della satira. Il lettore tende ad appiattirsi ed identificarsi in un personaggio che ha molto per esaltare certe vocazioni – più narcisistiche ed edonistiche che esistenziali, a dire il vero – ad esibizionismi etilici e dialettici. Mi sembra tuttavia criminoso ridurre un personaggio di questo spessore ad una grossolana macchietta dalla splendida verve letteraria e dalla confusionaria esistenza: stereotipata nei suoi eccessi sino a poter essere emulata, che dico – scimmiottata, dal primo scribacchino alcolizzato e frustrato. Il caso letterario si deve nutrire di simili spot: e allora, osanna per una lingua letteraria fitta di contaminazioni gergali, o del parlato, o di strani slang anglo-yiddish, e ancora osanna per chi s’avventura in descrizioni erotiche prossime alla pornografia, senza difficoltà, quasi questo solo bastasse a riconoscere i crismi dell’opera d’arte. Io mi limiterei a circoscrivere certo sarcasmo e certo sperimentalismo e certa disinibizione nel recinto di una vecchiaia amara e disillusa: fascinosa, senza ombra di dubbio, nel suo livore, nei suoi rimpianti, nei suoi sogni e nei suoi spettri, ma pur sempre vecchiaia di uno scrittore che, nel corso della sua vita, aveva visto delusi e frustrati ideali e progetti, e perduti amori e amicizie. Proprio per questa ragione avevo deciso di iniziare la trattazione delle opere del talentuoso scrittore canadese da un’opera giovanile come “Out”: per valutarne eventuali asimmetrie stilistiche, evoluzioni e involuzioni, e via dicendo. Posso tranquillamente affermare che Barney è Mortimer Griffin ferito e irrimediabilmente invecchiato: più caustico, più disperato, forse, più estremo. Paradosso affascinante. Il libro, se esaminato trascurando la superficie – ribadisco, superficie perfino divertente, nella sua sfrontatezza e nella sua amarissima irriverenza, e nella sua fredda capacità di descrivere vezzi, difetti e tic dei borghesi e degli artisti – tradisce molto spesso l’origine reale dell’avventura letteraria non solo del personaggio, ma dell’autore. Analizziamo nel dettaglio qualche passo emblematico per confermare la mia tesi. Dopo un primo appuntamento delirante e grottesco, Barney si ritrova ad osservare l’amata Miriam al suo fianco. “Al risveglio, un paio d’ore dopo, la vidi lì in poltrona, le lunghe gambe accavallate, che leggeva Corri, Coniglio. Era talmente assorta che rimasi in silenzio, approfittandone per contemplare la sua infinita bellezza. Il cuore era come impazzito. Pensai che se in quel preciso istante il tempo si fosse fermato lo avrei trovato giusto”.
Lirismo asciutto, devo dire: e tuttavia, il contrasto con le precedenti trecentocinquanta pagine, tra flatulenze alcoliche, conati di vomito, turpiloqui vari e via dicendo è piuttosto acuto. La sensazione allora è che l’autore abbia voluto velare la sua sfera intima con un apparato imponente di specchietti per lettori-allodole: è un romanzo che in fin dei conti non risparmia tragedie, da suicidi a separazioni, fino a demistificare corruzioni e clientelismi. Eppure, la vena dissacrante e distaccata dell’autore pare trarre in inganno il pubblico. Questa apparente apologia del disordine - perché senza dubbio è una accettazione del disordine – è poderosamente sostenuta da un linguaggio crudo e irrispettoso di qualsiasi autorità e qualsiasi dio. Eppure, tra le righe non è difficile scorgere, ma a voi il piacere di individuare dove, almeno tre straordinarie utopie tartassate dall’esperienza biografica del protagonista: l’amore e la fiducia per l’arte e per gli artisti, il senso di eterna appartenenza ad una ed una sola donna, la convinzione dell’infrangibilità dei legami amicali.
Barney, e Richler, raccontano il loro capolinea: e c’è qualcosa di nobile e di virile nel mascherare il dolore e la sofferenza con questo studiato distacco sardonico, si ha la sensazione di avere davvero di fronte uno splendido esemplare di autentico vecchio artista cinico. Dura poco, purtroppo: tanto è eccezionale l’umanità del protagonista, e, sia permessa quest’intrusione del critico nell’analisi dello spirito dell’autore, tanto doveva essere eccezionale l’umanità di Mordecai Richler. Ancora una volta, rinvio al saggio di Codignola pubblicato nel volume primo dell’Adelphiana, indicato nella bibliografia: con sobrietà e lucidità si parla di un artista gentile e misurato, del tutto stupito dall’accoglienza ricevuta dall’opera in Italia, e meravigliato dalla fama pseudo maudit che nel nostro paesotto s’era creato. In conclusione, la “Versione” è un’opera da affrontare con lo stesso rispetto con cui si ascoltano le confidenze di qualcuno prossimo a completare il suo tempo: è un’opera stravagante e splendidamente viva, capace di sprofondare in abissi atroci di tristezza e di risollevarsi dalla malinconia con il sorriso ferito e amaro e riottoso di chi non si lamenta, o non vuole arrendersi. Può essere letta, e non è paradossale ribadirlo, come un inno all’anticonformismo, all’etilismo, alla spregiudicatezza e all’irriverenza: probabilmente, come sempre, è questione dipendente dallo spirito e dalla preparazione del singolo lettore, e dal contesto ambientale in cui si trova. Regala più di un sorriso, e questo è un dono straordinario. Possiamo esultare per un’altra ragione: finalmente abbiamo a disposizione il romanzo di un autore canadese. L’occidente ha sempre meno segreti.
Romanzo di una vita memorabile: in ogni senso.
EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE.
Mordecai Richler nacque a Montreal, nel Quebec, nel 1931. Abbandonò gli studi poco prima di ottenere la laurea, nell’università Sir George Williams di Montreal, viaggiando dapprima alla volta di Parigi e quindi trasferendosi in Inghilterra. Tra il 1959 ed il 1972 si impiegò come giornalista, a Londra, scrivendo testi per trasmissioni radiofoniche e televisive e, talvolta, avventurandosi nella stesura di sceneggiature cinematografiche. La sua esistenza fu equamente ripartita tra Canada ed Inghilterra, sino alla fine dei suoi giorni, nel 2001. I suoi romanzi sono stati tradotti in francese, tedesco, italiano, giapponese ed ebraico. L’opera prima, “The Acrobats”, risale al 1954.
Mordecai Richler, “La versione di Barney”, Adelphi, Milano, 2000. Traduzione di Matteo Codignola.
Per approfondire: “Adelphiana – pubblicazione permanente”, volume primo, Adelphi, Milano, 2002. Sezione di riferimento: “Tributo a Mordecai Richler”, pp. 207-245. Testi contenuti: Mordecai Richler, “Un mondo di cospiratori” (1975); Concita De Gregorio, “La favola di Barney” (2001); Matteo Codignola, “Il caso Mordecai”(2001).
Gianfranco Franchi, luglio 2002.
Prima pubblicazione: ciao.com; a ruota, lankelot.
