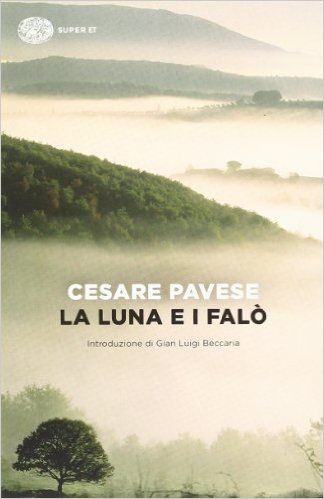 La luna e i falò
La luna e i falò
Einaudi
1950
9788806174194

“Allora gli dissi che nel mondo ne avevo sentite di storie, ma le più grosse erano queste. Era inutile che trovasse tanto da dire sul governo e sui discorsi dei preti se poi credeva a queste superstizioni come i vecchi di sua nonna. E fu allora che Nuto calmo calmo mi disse che superstizione è soltanto quella che fa del male, e se uno adoperasse la luna e i falò per derubare i contadini e tenerli all’oscuro, allora sarebbe lui l’ignorante e bisognerebbe fucilarlo in piazza. Ma prima di parlare dovevo ridiventare campagnolo (…)”. (C. Pavese, “La luna e i falò”, capitolo IX).
Il narratore sta vivendo un ritorno: dove sia nato non l’ha mai scoperto, ma dove sia vissuto e quali siano le sue radici questo sì – questo non è mai stato in dubbio. Trovatello abbandonato sugli scalini del duomo di Alba, allevato da “due miserabili”, dopo aver a lungo viaggiato e conosciuto il mondo sente l’irresistibile richiamo del paese. Il “suo”. L’origine mitica s’è impadronita dell’origine reale: che non ha più importanza, e non è necessariamente il mistero più rilevante per il bastardo. Infatti: “Questo paese, dove non sono nato, ho creduto per molto tempo che fosse tutto il mondo. Adesso che il mondo l’ho visto davvero e so che è fatto di tanti piccoli paesi, non so se da ragazzo mi sbagliavo poi di molto (…) Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. Ma non è facile starci tranquillo” (capitolo I, p. 9).
Sospendo momentaneamente la trascrizione del paragrafo per soffermarmi su due elementi che mi sembrano interessanti: la necessità dell’esistenza del paese – e cioè di una “radice” e di un’origine, pure scientemente fittizia o artefatta, per la formazione dell’identità dell’individuo. È un termine insostituibile: in negativo – “per il gusto di andarsene via” – e in positivo – “c’è qualcosa di tuo”. E poi, l’aspetto chiave della disperazione del trovatello: la solitudine. Il paese “vuol dire non essere soli”: riconoscere ogni singolo ruolo e rispettarlo, e sentire familiari i codici di comunicazione e le varie forme di cultura, e via dicendo. Il narratore potrà essere, come diversi altri personaggi di Pavese, un estraneo alla vita: ma ha bisogno del termine di paragone, dell’origine: da adottare, rifiutare, avallare, rivendicare, di volta in volta. Ha bisogno di alterità per darsi definizione – si teme: per darsi un senso, per assicurarsi di avere un senso. “Ma non è facile starci tranquillo. Da un anno che lo tengo d’occhio e quando posso ci scappo da Genova, mi sfugge di mano. Queste cose si capiscono col tempo e l’esperienza. Possibile che a quarant’anni, e con tutto il mondo che ho visto, non sappia ancora che cos’è il mio paese?”
E allora l’esperienza del ritorno non mancherà di stupire il narratore per un aspetto fondamentale: tutto è cambiato eppure eguale (cfr. capitolo VI p. 27), la natura è mutata e le persone sono cambiate o sparite, le radici franate, ma l’odore, il gusto, le voci e il colore sono inalterati. Quando dovrebbe ammettere di non aver ritrovato quel che cercava, trasfigura la sua memoria e si regala il sostegno dolce e inquieto della poesia: del resto, era bambino che “vedeva solo le cose che voleva” (cap VI p. 29) – come il piccolo Cinto, ragazzino poverissimo e denutrito e sciancato, con il quale, sin dapprincipio, il narratore stabilisce un rapporto di identificazione e confronto, guardando, per così dire, attraverso i suoi occhi il suo passato e legittimando e riconoscendo la sua vita nel paese.
Vita rabbiosa e disperata di chi sente la povertà e la miseria come forme di dannazione e la nascita bastarda come stigma: e allora troverà conforto proprio in quell’America che gli sembra terra di figli illegittimi, tutti senza padri e senza madri, radunati in comunità (pure pseudo) etniche che vanno a costituire – ancora una volta – il termine necessario: l’origine, la radice, la sorgente. Che quando s’ammantano di mito, son più libero oggetto d’alterazione e invenzione.
I compaesani gli presentano le figlie e lo chiamano “l’americano”: è un forestiero che soltanto poco a poco viene riconosciuto come lontano volto d’un passato, come il vecchio “anguilla” che giocava coi ragazzi e poi è andato a cercar e trovar fortuna per il mondo. E ora ritorna, nelle terre in cui si crede alla luna e ancora l’innocenza sprigiona da ogni parola pronunciata, e da ogni segreta tradizione: Anguilla non ha dimenticato la miseria e vuole non soltanto riscattare, ma accettare e avallare il suo passato. L’amico Nuto, falegname e clarinettista, è l’amico più grande (che tanta importanza riveste nelle opere di Pavese si pensi a “Il compagno”, per individuare un paradigma) che potrà rivelare la verità perduta – in poche battute, ma limpide e catartiche. “Tuo padre sei tu”. Non cercare altrove, non illuderti più.
Si parla dei delitti di guerra. Qualcuno incolpa i partigiani. Il clima è teso: il sangue versato pretende senso, non potendo sempre, o non più, avere giustizia. C’è chi tira alle spalle dei liberatori comunisti, mirando a macchiare le loro passate azioni. Allora, “dissi che non ero d’accordo. Mi chiesero come. In quell’anno, dissi, ero ancora in America. (Silenzio). E in America facevo l’internato (Silenzio). In America che è in America, dissi, i giornali hanno stampato un proclama del re e di Badoglio che ordinava agli Italiani di darsi alla macchia, di fare la guerriglia, di aggredire i tedeschi e i fascisti alle spalle. (Sorrisetti) Più nessuno se lo ricordava. Ricominciarono a discutere” (cap. XII, p. 50).
Romanzo di splendida adesione e di lirica descrizione d’un mondo che la nostra società sta contribuendo a far dimenticare, pregiudicandone forse irrimediabilmente l’esistenza, è libro che solca l’humus dell’immaginario pavesiano e schiude il varco per accedere a un perduto incanto – e riviverlo.
Condividendo sofferenza e dolore, semplicità e innocenza, calunnia e morte: vivendo in empatia con una dimensione che di volta in volta è rischiarata dall’accecante chiaro di luna, e dal baluginare velenoso d’un falò.
“La luna e i falò”, pubblicato per la prima volta nell’aprile 1950 nella collana “I Coralli” di Einaudi, fu composto tra il 18 settembre e il 9 novembre del 1949.
EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE
Cesare Pavese (Santo Stefano Belbo, 1908 – Torino, 1950) scrittore italiano. Laureato in Lettere con una tesi “Sulla interpretazione della poesia di Walt Whitman”, all’attività di romanziere e poeta affiancò quella di saggista e traduttore e fu tra i fondatori della casa editrice Einaudi.
Cesare Pavese, “La luna e i falò”, Einaudi, Torino 1968.
Prima edizione: “La luna e i falò”, Einaudi, Torino 1950.
Gianfranco Franchi, febbraio 2004.
Prima pubblicazione: Lankelot.
