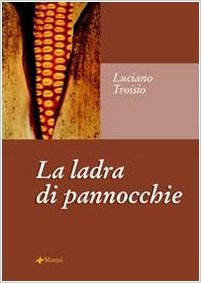 La ladra di pannocchie
La ladra di pannocchie
Manni
2003
9788881764549

In principio era Meneghello: “Libera nos a Malo” il libro della memoria d’un Veneto che s’andava smarrendo, confuso e trasformato da un benessere economico che sradicava tradizioni e convenzioni, rinnegando la propria storia e dimenticando le proprie origini. “Pomo Pero”, l’ondivago epigono del diamante grezzo del piccolo maestro, non aveva la stessa freschezza e la stessa capacità d’incidere nella sensibilità del lettore. La difesa e la rivendicazione delle radici culturali dei popoli del nordest è poi scivolata nelle pagine dei friulani: Sgorlon e Fignon si sono assunti la responsabilità d’essere cantori della storia d’un popolo che va pericolosamente incontro ai lapilli del freddo magma dell’omologazione italiota, anestetizzato e assopito dal ritrovato benessere economico.
Dopo aver rivendicato e difeso le proprie radici, è opportuno e necessario dedicarsi alla loro interpretazione – in altre parole, alla loro nuova codificazione, alla “decifrazione letteraria”. Lo scrittore veneto Luciano Troisio scrive La ladra di pannocchie, “biografia allegorica dell’Eden povero, evolutosi in Nordest”, avanzando lungo il sentiero solcato da Meneghello, approfondendo e raffinando lo spirito della sua ricerca.
Se nella puntuale ricostruzione del Veneto che fu, non si nascondono – anzi si affermano naturalmente – contrasti, contraddizioni, primitivismi e arcaismi d’una cultura, nella rappresentazione del Veneto presente si va assumendo l’esemplare esistenza della protagonista del libro, Nerina, come specchio, spettro e allegoria. Ma assimilare quest’opera esclusivamente alla fresca tradizione novecentesca della “letteratura etnica” del nordest significa semplificare la sua natura e corromperne l’identità: “La ladra di pannocchie” è infatti, al contempo, anche narrativa di viaggio e libro-denuncia.
La suddivisione del libro in tre parti ne è una chiara conferma. La prima, “Ladra di frutta”, è dedicata alla narrazione delle vicende di Nerina: a partire dalla sua infanzia in una famiglia poverissima, fino alla sua affermazione come coraggiosa e rivoluzionaria studiosa di botanica, moglie d’un giovane rampollo della nuova imprenditoria locale; madre d’una ragazza difficile, Dora; troppo presto vedova. In questa parte, come vedremo più avanti, è più trasparente la volontà di documentare fedelmente, di “fotografare” un momento della storia del Veneto, attraverso un personaggio esemplare.
La seconda, “Il karma di Dora”, è legata al viaggio di Nerina alla ricerca della figlia, teen-ager tormentata da una tragica pulsione autodistruttiva e dannata da un irresolubile male di vivere. Viaggio in India, a demistificare, dal punto di vista letterario, la fittizia opera di Gozzano e a eternare lo spirito dei passati scritti dei Barzini, Manganelli, Pasolini, dello stesso Troisio. Viaggio in India raccontato attraverso il dolce incontro, lo splendido e triste amore di Antonio Vergani, giornalista e scrittore, e l’affascinante Nerina, legati in un abbraccio tra “naufraghi su uno scoglio assai tagliente”.
La terza, “OGM: il Dio del mais” è riservata alla narrazione della vita di Nerina dopo la morte della figlia: la studiosa, rasserenata dalla presenza del suo nuovo compagno, vivrà una fase di dedizione totale alla politica cerealicola comunitaria, proponendo d’alterare il DNA delle specie, inserendo cromosomi transgenici, per permettere ai popoli più poveri di triplicare o quadruplicare la produzione per ettaro e risolvere il dramma della fame nel mondo, attutendo insieme l’eccessiva dipendenza economica dall’Occidente.
Rapita e segregata da una banda, liberata dopo mesi, Nerina tornerà al Parlamento Europeo di Strasburgo a illustrare le sue idee rivoluzionarie: proposta alla presidenza della FAO dalle nazioni povere, candidata al Nobel per la Pace, vivrà l’ultima fase della sua esistenza con “onesta intransigenza” e consapevolezza di non essere trascorsa invano – le sue ricerche e le sue idee saranno patrimonio delle nuove generazioni.
*
Al principio del libro il lettore è investito dalla luce, primo elemento simbolico rilevante dell’opera. C’è una luce “aguzza” nello sguardo d’una bambina e una luce “insostenibile” negli occhi socchiusi, “come abbagliati”, della madre nella prima scena: stanno rubando pannocchie in un campo, e chi le osserva e le fotografa è uno scrittore, ospite d’un giovane del posto. Cinque anni dopo, “stesso fotogramma”: ha inizio la narrazione. Non è forse un caso se l’anima del libro, Nerina, ogni notte fa uno strano gioco con gli occhi, premendo i bulbi fino a vedere le luci.
La storia s’ambienta ai bordi della laguna morta, ai confini delle province di Venezia, Padova e Rovigo, nella Frazione di Conche, dove si parla un dialetto diverso da quello del centro del comune: un tempo era la Frazione il centro ricco legato alla laguna bizantina. Poche centinaia di anime – “tempi di fame nera”, in cui non si buttava via nulla e i paesani più indigenti rubavano nei campi perché non avevano altra via per nutrirsi: ma “tutti avevano lo spontaneo rispettoso atteggiamento “ecologico” di antichissime regole: non prendevano mai più del necessario, riducevano al minimo i danni, non spezzavano rami, non pestavano il seminato e il foraggio, rispettavano i nidi, ributtavano in acqua i pesci troppo piccoli” – e il mangiare si divideva. Sono come “personaggi immersi nel male eppure assolutamente esenti dal negativo” (p. 7). Innocenti: e quell’innocenza si rispecchia in certe superstizioni e in certe credenze. Terra e culla di spiriti e favole.
La confessione ha il sapore di un “atto magico” (p. 12), non mancano ovviamente gli esorcismi ed è dura da estirpare la fede nell’esistenza delle “streghe falciatrici” (p. 21). L’incesto è una tragedia fin troppo quotidiana (p. 14). In questo contesto, culturalmente arretrato e costretto a lottare quotidianamente per la sopravvivenza, emerge la figura della seducente protagonista, la fascinosa Nerina, figlia di povera gente, prosperosa come il nuovo tempo che il Veneto s’appresta a vivere. Abita in una casa di legno e muratura, dal tetto di paglia – uno degli antichi “casoni”. Ha talento e intelligenza, ma il suo destino è “andare a servizio” presso una famiglia benestante perché i suoi non possono permetterle di studiare. E così, nonostante la perplessità dei professori, che vedevano in lei un promettente talento filologico, Nerina, appena iniziata al sesso da un suo compagno (in un memorabile scenario agreste, con ritualità quasi druidica) si trova a vivere e lavorare nella casa dei Maironi, titolari di un biscottificio.
Là vivono Anna, (bionda, elegante e fragile, sua amica da sempre), suo fratello Michele, anima semplice dai pensieri lenti, e i genitori. La madre prende a benvolere Nerina, sarà sua santola alla cresima. Dopo quattro anni, Nerina abiterà con loro, nell’ultimo piano della villa, disabitato e usato in precedenza come granaio. Ha l’idea di una nuova produzione di biscotti, i ciambellotti, che assicurano la fortuna dell’azienda; poco a poco diventa oggetto delle attenzioni del sempre meno dormiente primogenito Michele. Si innamorano e si sposano. Si diploma da privatista e va affiancando il marito negli studi di Agraria, all’Università. Unica macchia in questo momento felice è la nuova carcerazione del padre di Nerina: il passato, così, si consegna alla memoria. Nerina conosce un’autentica metamorfosi borghese: nell’estetica e nello stile. Non nell’animo. Il ricordo delle sofferenze patite l’ha segnata troppo in profondità. Nasce sua figlia: Dora. Quattro anni dopo Nerina si laurea e diventa assistente universitaria. Tutti prevedono un suo brillante futuro come botanica. L’ex ladra di pannocchie è innamorata del mais. E il suo primitivo e mai dimenticato talento per le etimologie la porterà lontano.
Michele, all’improvviso, muore in un incidente stradale. Dora cresce male, senza padre, assimilando dalla madre “irrequietezza, apatia, nervosismi ingiustificati”. È una ragazza difficile. Inizia a rubare, nei negozi, dappertutto, perché “per rubare bisogna valere”. Vive amorazzi che fatalmente si dissolvono. Comincia a essere ossessionata dall’India. È là che fuggirà appena maggiorenne. Non ha identità. Ha benessere. Il benessere non basta. È incline alla ribellione a qualunque autorità. Non ha più padre. Precipita nella droga. Dalla droga non ci si libera facilmente – perché non ci si libera facilmente dal niente che si nutre di se stessi. È perduta: ma Nerina non lo accetta.
Ritroviamo Nerina sulle tracce di Dora, tra Calangute, Goa, Anjuna. Al suo fianco ha una singolare figura di avventuriero: incontriamo Antonio Vergani, giornalista, viaggiatore e autore di reportage di gusto chatwiniano. Antonio ha uno spirito deliziosamente fanciullesco: “pareva inconsapevolmente tenere per il mondo intero un atteggiamento di ammirato stupore, quasi gli desse sicurezza e felicità; meditava molto intorno a ciò, perché fino a quando uno mantiene la capacità di stupirsi vuol dire che le cose funzionano” (p. 81) – il pensiero istintivamente torna a quanto affermava l’autore nel suo volume “Tirtagangga e varie sorgenti” (Marsilio, 1999), dove a p. 23 del racconto “Cianografia di Shanghai” si legge: “è forse l’ingenuità una delle poche chiavi per entrare davvero”, per vivere empaticamente il contatto con l’alterità.
Laureato con una tesi sulle strutture della fiaba, Antonio ha talmente interiorizzato la sua ricerca che sembra poter restituire luminosità e trasformare in favola la vita della triste e splendida signora: conosce il segreto d’ogni anima, l’adesione al sogno. Sa estenderlo: coinvolge e travolge. Conquista. Non ama: adora. Adora Nerina, le riconosce eccelsa faiblesse, “Giorgione per il volto, anche Botticelli. Tiziano amor profano per il resto? No, seno troppo gonfio per il Rinascimento, ci voleva Modigliani, anche per il pube da puledra, oppure il Tono di certe esuberanti Brunalbe” (pag 95), e si veda ancora la superlativa serie di aggettivi dedicati al suo corpo nella parte seconda, II,2, a pagina 125. Nerina è la donna capace di esprimere il “segnale stupendo che annulla ogni equivoco”. Poesia. Questa è una delle espressioni letterarie più pure per rappresentare il gesto d’una amata. Divina. L’amore è il segnale stupendo che annulla ogni equivoco. Antonio e Nerina s’inventeranno favole. Per riconoscersi.
Lui la sostituirà, a un tratto, nella sfortunata ricerca di Dora a Poona, sede di vari Ashram: ma la ragazza sembra dissolversi appena le si avvicinano, s’allontana irrimediabilmente – e quel che di lei scoprono viene solo raccontato da altri. Compreso il primo tentativo di suicidio.
È solo l’annuncio d’una tragedia che avverrà. Perché – ecco un’altra delle parole chiave del libro – Nerina sente il peso dell’ananke. Da sempre.
Vediamo: la prima epifania risale alla morte del marito. “Nerina era impietrita, pallida come non mai. Nell’arco di poche ore rovinava un magnifico castello. Ananke, la dea necessità, imperiosa prendeva possesso trionfante, capovolgeva i buoni sforzi, sperperava i frutti” (pag. 68); altrove e più avanti, rimarrà sconvolta da una tela, “Il mondo e il chiostro”, dove riconosce nel volto di una donna, “grassoccio, giovane e non brutto, gli occhi fissi, nella triste disperazione dell’Ananke, l’orribile dea Necessità, contro la quale non si può essere che soli” (pp. 105-106).
Infine, durante la prigionia, ricorderà che “Il Principio di Necessità” le vieta di sognare (p. 184).
La fondamentale opposizione simbolica del libro è dunque tra Luce e Ananke. La morte di Dora, pure invano e fortunosamente restituita alla famiglia, è desolante e raggela. Perché con lei si spegne definitivamente la metà oscura di Nerina, e in lei s’estingue un ghenos. Non la speranza.
La speranza non si spegne: perché nell’ultima fase della sua esistenza Nerina avrà al suo fianco Antonio, testimone e sostegno della sua ricerca, compagno e faro: e nulla potrà chi la imprigiona e la condanna a una morte in differita, ché già le sue parole han raggiunto il cuore del mondo.
Il Veneto, dunque, incarnato in Nerina: la sua esistenza adottata come rappresentazione della trasformazione d’una terra e d’una cultura, senza pretendere d’associare a tale idea una connotazione necessariamente positiva o inderogabilmente negativa. Un Veneto che, pur assumendo abiti e gergo borghese, non rinuncia alla sua radice, che è l’amore e l’adesione alla terra. Veneto che non smarrisce grazia, fertilità e sensualità; e sogna uno sviluppo che sappia essere armonioso e umano. L’epilogo è comunque tragico: il primo frutto della “neo-terra”, Dora, è acerbo e avvelenato. La parabola della terra della “Ladra di Pannocchie” si conclude egualmente con la morte: si può solo seminare; adesso il tempo del raccolto s’è concluso e non si ruba più per sopravvivere, né per valere, ma per prevaricare e dissipare. S’è seminato cantando: canto di Musa o di Profetessa, questo ancora non sappiamo.
Nell’intervista pubblicata su Lankelot nell’aprile del 2003, così Troisio annunciava la nascita del nuovo romanzo. “Sto studiando la storia della mia amata regione, il Veneto, che nella seconda metà del secolo scorso ha vissuto una colossale mutazione, passando dall’emigrazione all’opulenza, a volte un po’ miope, del Nordest. Vorrei trarne un romanzo che ne fosse narrazione, ma anche metafora. Credo di essere a buon punto”.
GF: “Narrazione, registrazione e interpretazione d’una metamorfosi: fotografia fedele d’un passato che scompare – e martirio, inteso in accezione etimologica e in senso corrente, di quel passato. Il Veneto – Nerina – mutando si snatura irrimediabilmente?”
LT: “Nerina non direi. Nella sostanza rimane quella che è sempre stata. Questo è un merito riconosciuto ai Veneti. Nella sua lucidità essa non ‘si rende conto’ del capovolgimento cui la sua esistenza viene sottoposta: trova tutto naturale. Ma la sua massima, non da sottovalutare, rimane: ‘riesco a ottenere facilmente tutto ciò che NON mi interessa affatto’, una dichiarazione di sconfitta e, in parallelo, spia per interpretazioni in chiave psicologica. D’altronde la sua grande intelligenza la aiuta a schierarsi dalla parte giusta, fedele e buona. Nella metafora invece si teme che nei tempi lunghi per il Veneto non sia così (e che inaspettatamente “finisca” dove non si vorrebbe affatto). A ciò, e al fatto che mutando si snatura, nel senso che vengono uccisi i suoi esponenti migliori, allude anche il finale del romanzo”.
GF: “L’irresistibile sensualità di Nerina sta a rappresentare la primigenia e selvatica bellezza d’una terra, o è nuova incarnazione dell’eterno femminino?”
LT: “Nerina è un’eccezione contraddittoria, una parole espressa dal popolo. Potrebbe essere una giovane modella di Carpaccio, Giorgione, Tiziano; sensuale e delicata Venere popolana di singolare avvenenza. In questa accezione non è per nulla letteraria e resta una forza della natura per quanto filtrata attraverso la meraviglia dell’arte veneta (ecco che la provincia si scopre tuttora uno dei ‘centri’, dei laboratori ‘alti’). La sua bellezza tiene conto del fatto che poche regioni del mondo (oltre al Veneto credo solo la Toscana e le Fiandre) hanno prodotto per secoli un tale vertice di magnificenza. Riaffiorano nella memoria le stupende pagine - fra saggio di storia dell’arte e invenzione - che Neri Pozza ha dedicato ai grandi pittori veneti del Quattro-Cinquecento, ai loro ambienti e vicende, alle putine, ai paesaggi, anche quelli che si intravedono in secondo piano, vedute di care città riconoscibili, e sopra: quelle turchine montagne lontane, quel cielo azzurro ammiccante e indimenticabile, specie per chi ritorna in patria in auto e dopo infinite monocrome foschie se lo vede apparire improvviso, inaspettato - quello sì un tantino letterario o pittorico - al valico…”.
GF: “Nella seconda parte, nuova e felice attestazione della sua predisposizione alla narrativa di viaggio, s’incontrano, tra le righe, stilettate a Gozzano e luminosi richiami a Barzini. È la rivendicazione d’un’eredità o la conferma d’una affinità elettiva?”
LT: “Non oso pretendere nessuna delle due. I miei sono soltanto minimi rinvii ironici. Ma quei libri sono capolavori, anche se per il momento un tantino caduti nell’oblio. La scrittura di Gozzano è certamente più alta, sicura, elegante. Ammalia e coinvolge il lettore in una misteriosa sottile modernissima ambiguità. Ma Guido finge (in senso etimologico: plasma) a tavolino, una volta tornato, le sue ‘Lettere dall’India’. Preleva a piene mani da Loti, da De Gubernatis e altri. Durante il viaggio non ha mai trovato l’energia per un minimo appunto (la tisi lo stava consumando). Invece la pagina di Barzini è scritta in un linguaggio più semplice, per quanto estremamente efficace. Non a caso la figura retorica da lui preferita è la ticoscopia (lett.: rappresentazione sul muro). Barzini riesce a trascinarci in capo al mondo, in pace e in guerra, descrive in diretta orribili massacri ma ci risparmia le raccapriccianti e ghiotte decapitazioni pubbliche cui peraltro assiste (ce ne riferisce genialmente attraverso i dialoghi degli altri spettatori), rischia l’osso del collo dove non c’è traccia di strade, correndo addirittura dentro i binari della transiberiana, con qualsiasi tempo, ci impolvera e ci tiene giorni interi sotto piogge battenti. Gozzano viaggia su costose navi, azzimato rispetta l’etichetta a pranzo e a cena, spesso fa la sua entrée nella dining room in ritardo come le dive piumate, amabilmente rampognato dal capitano, è quasi assediato da eleganti signore liberty che gli allestiscono visite e picnic esotici; inoltre nei soffici suoi spostamenti (in luogo del cellulare) ha quasi sempre un medico al seguito. Barzini al contrario è un infaticabile sano lavoratore che il più delle volte mangia alla buona seduto nel fango, non salta un giorno e riesce a telegrafare lunghi articoli al “Corriere” anche dal deserto di Gobi. Il suo italiano ruspante, e non di rado persino scorretto (non dimentichiamo che stiamo parlando di uno scrittore toscano!), è di un’efficacia senza pari. Per concludere: stimo di più Gozzano, sceglierei come compagno di viaggio Barzini, non oso rivendicare nulla”.
GF: “Ancora una volta, come in Tirtagangga e varie sorgenti, s’assiste nel viaggio a uno spaccato di innocenza, contaminazione e corruzione: possiamo affermare che si tratta dei tre sentimenti fondamentali nella sua narrativa o dovremmo limitarci a confermare la loro presenza?”
LT: “Sinceramente non saprei rispondere alla sua pertinente domanda. Per me innocenza e contaminazione sono due categorie quasi naturali. È la seconda che si soffre più spesso viaggiando (nelle metropoli asiatiche ci sono notissime strade e piazze frequentate da una tale fauna di globetrotters, che in una sola volta, anche solo a respirarne l’aria, ci si può beccare il più completo cocktail di virus del mondo). La contaminazione deve essere però considerata una specie di vaccino mitridatizzante, simbolico. La corruzione è purtroppo onnipresente, più o meno autoctona ovunque; bisogna faticare molto per non restarne invischiati, rinunciare alla tentazione dei suoi facili vantaggi, specie da giovani. Sono sempre più tentato di scrivere su questo argomento così ripugnante”.
GF: “Nel corso dell’ultima intervista pubblicata su Lankelot, lei ha affermato che ‘Il viaggiatore può restare innocente, ma se vuole sopravvivere non può evitare l’involontariato del cinismo’. Crede che questa affermazione rifletta o corrisponda allo spirito di Antonio Vergani, co-protagonista del suo nuovo romanzo?
LT: “Certamente chi viaggia al di fuori dei pochi paesi ricchi occidentali, deve assumere per legittima difesa una maschera di cinismo, essere indifferente alle mostruosità in cui s’imbatte di continuo. La parola ‘mondo’ in molte lingue significa: pulito, bello, santo, luminoso, armonioso. Il turista sveglio desidera conoscere (tautologicamente) le ‘bellezze del mondo’; in realtà anche chi viaggia con dispendio di mezzi in lussuosi alberghi osserva soprattutto situazioni e sincronie orrende che dovrebbero farlo piangere ininterrottamente. Non sono passati molti anni da quando il famoso albergo Taj Mahal di Bombay era ancora assediato da un’enorme folla di lebbrosi mendicanti e mutilati - un terribile percorso di guerra che bisognava solcare uscendo, anche in tassì - in seguito dissuasi con brutte maniere dalla polizia e convinti a sloggiare. Anche Antonio, almeno per questi aspetti è coinvolto dalla ‘bruttezza del mondo’ e dal cinismo. Ciò non significa che la sua ‘innocenza’ si sgretoli. Al contrario egli rimane integerrimo, perché prima di tutto vengono i ‘valori’, come dimostrano ampiamente le pagine del romanzo.
GF: “La terza parte del romanzo ha elementi di denuncia: quanto si riconosce nelle posizioni di Nerina a proposito degli OGM? E quanta fiducia ripone in una rivoluzionaria adozione delle nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche?”
LT: “Naturalmente gli OGM (qui riferiti al granoturco, quindi a un importante simbolo del Veneto) devono interpretarsi in senso metaforico. Il progresso si fonda sulla ricerca, e la ricerca ‘è per l’uomo’, si deve tradurre in beneficio (in ricchezza) per tutti gli uomini, soprattutto per quei quattro quinti di umanità dei paesi poveri, sempre più indebitati ad arte con l’Occidente. C’è un riferimento polemico nei confronti del ‘Nord’ ricco, ma anche della ‘ricchezza’ velocemente accumulata soprattutto dalla minoranza dei cosiddetti ‘piccoli imprenditori’ improvvisati (con lo sfruttamento intensivo, al nero, senza il minimo investimento in ricerca, quindi con la certezza di non essere competitivi che per un breve periodo, e poi una volta sistemati, ritirarsi dal mercato, sparire con i soldi), mentre la ‘collettività’ si deve sobbarcare in eterno tutti gli aspetti negativi, le spese, i disagi sociali, le polveri fini, la malasanità. Ma sostenendo gli OGM Nerina, da brava insegnante, testimonia un impegno didattico rivolto a tutti, vuole soprattutto chiarire la sua posizione controcorrente, alludere al fatto che la ricerca si è sempre scontrata con le regole dell’etica, anche in passato, ma che in sostanza dette regole hanno poco intralciato il trasgressivo cammino della scienza (che innova i codici di comportamento, quindi anche la morale). In poche parole, pur restando pessimista su molti aspetti del mondo futuro, sono invece molto ottimista (sebbene non incauto) per quanto riguarda il progresso tecnologico e le nuove sbalorditive conoscenze scientifiche, che avranno certo ricadute altamente vantaggiose per l’uomo”.
GF: “Si riconosce nel solco tracciato dal suo conterraneo Meneghello? È un solco tracciato per tutelare memoria, rivendicare coscienza e cultura, scrivere il grande libro di un popolo. Apparentemente, la letteratura si sovrappone alla storiografia. Può sostituirla, almeno in questo frangente?”
LT: “Riconosco che lei ha talento e sintesi storiografica nel toccare subito questo delicato tasto, e la ringrazio per il fatto che mi riconosce un certo ruolo; sarebbe un onore essere paragonati a Libera nos a Malo, però nonostante la sua domanda sia assai suggestiva, debbo chiarire che non mi riconosco affatto nel solco tracciato, sebbene abbia molto amato Meneghello. E in fin dei conti la nostra area linguistica è proprio la stessa: infatti la cittadina a nord di Padova dove ho trascorso la mia infanzia (sebbene sia giuliano di nascita, e ci tengo) si trova a ridosso della provincia di Vicenza. Non a caso Napoleone, nella sua risistemazione amministrativa, aveva aggregato quelle plaghe al ‘dipartimento del Bacchiglione’, cioè alla provincia di Vicenza. E infatti la mia variante dialettale altopadovana (che ho imparato a cinque anni, perché io sono uno dei rari settentrionali di vera madrelingua italiana) è molto affine a quella del vicentino Meneghello, come a suo tempo ho potuto gioiosamente verificare nelle sue pagine. Libro di un popolo, libro in dialetto: questo argomento è tutt’altro che semplice, di grandissimo interesse per molti, e ne ho avuto anche di recente le prove, perfino in luoghi lontanissimi, come le Americhe e l’Australia, dove esistono interi paesi di veneti che ci tengono a parlare tra loro in dialetto stretto, e che si sono assai meravigliati del fatto che io ne conoscessi le espressioni più arcaiche, con cui specie i giovani (parlanti inglese, portoghese o spagnolo, ma non italiano) si rivolgono tuttora ai loro nonni, nati soprattutto nelle zone del Veneto di montagna, e quindi in aree conservative già in patria. Il discorso è assai emozionante però non centrale nel mio romanzo, e ci porterebbe lontano anche in altre direzioni. Penso ad es.: a Rigoni Stern e alle tematiche storiche/umane della guerra, per la prosa. Ancora più coinvolgente l’ambito della poesia dialettale veneta (e in versi dialettali ho voluto cimentarmi, dichiarare, dopo molti anni di esilio, una mia identità con passione, tanto da essere stato anche tradotto in inglese). Quindi non posso non citare le illustri operazioni di grandi poeti come Noventa, Zanotto, Caniato, Zanzotto, Ruffato con il suo recente epocale Scribendi licentia. Ma per loro il dialetto significa soprattutto recupero della ‘madre’, metonimica e non, quindi del giardino ineffabile della primissima infanzia, di una Lingua matris che nel mio caso invece è stata quella, altrettanto dolce, italiana. Questo aspetto è l’unico che mi differenzi dall’Area cultissima veneta (e forse spiega la mia recalcitrante estraneità di fondo per il succitato ‘solco’), con cui però mi identifico per tutto il resto. Per risponderle almeno in parte, credo di considerare più affini i ‘solchi’ di Piovene, viaggiatore in Italia e America, e ancor più di Comisso, grande viaggiatore in oriente ma soprattutto in Italia, che definiva la sua ‘favorita’.
GF: “Veniamo adesso a domandarle qualche anticipazione a proposito delle sue prossime opere: sta vagliando nuove idee, o intende tornare a lavorare su un progetto abbandonato in passato? Cosa possiamo attenderci dal nuovo libro di Luciano Troisio?”
LT: “I progetti sono molti, troppi per le mie fragili forze, e temo che molti resteranno tali. Come anticipato, sto scrivendo sugli ambienti di lavoro, dove la corruzione compie come tutti sappiamo, incredibili eventi taumaturgici specie nelle carriere ambosessi, anche prescindendo dai pur notevoli meriti coxo-sacrali. Mi affascina sempre più l’idea di affondare nel marcio, nel sesso mercenario e nella depravazione del ‘vuoto di scambio’. Uno dei racconti, o capitoli, potrebbe riguardare la storia di un giovane: una difficile ‘iniziazione’ alla vita, all’amore; un passaggio dallo spensierato (a spese di mamma e papà) mondo goliardico al mondo del lavoro, in un’area di solo apparente ‘piena occupazione’. Ma per il momento darò la precedenza assoluta a un altro lavoro. Infatti ho avuto l’onore di essere invitato dal direttore Cesare Ruffato a pubblicare una silloge poetica nella sua collana Elleffe, edita da Marsilio. È stato un notevole incentivo, per certi versi ormai inaspettato, di cui non mi vedo quasi degno, quindi a tale pubblicazione dedicherò nei prossimi mesi tutte le energie disponibili”.
GF: “Concluda con un saluto ai suoi lettori e al pubblico lankelottiano. Rimpianti, promesse, certezze, minacce, auspici: giuramenti o apostasie. Carta bianca”.
LT: “Il mio volume di racconti 'Tirtagangga e varie sorgenti' è praticamente esaurito, e per questo ringrazio i miei amati lettori e recensori. Mi auguro che anche 'La ladra di pannocchie' venga altrettanto letta. I primi giudizi che ho ricevuto da lettori molto qualificati, sono assai confortanti: è una storia coinvolgente, affronta alcune tematiche attuali in modo nuovo, anche se non novissimo, e spero che i lankelottiani non perdano l’opportunità di conoscerla. So che Lankelot è visitato da un gran numero di navigatori, molti di più di quelli di una rivista letteraria (ammesso che questo paragone, viste tirature e vendite, risulti un complimento). Mi congratulo sinceramente con lei che ne è anima appassionata a tempo pieno, e anche perché certamente si tratta di lettori sceltissimi; li ringrazio e li saluto cordialmente. È probabile che saranno loro i soggetti che faranno evolvere il pubblico colto; che saranno i siti giovani di grande intelligenza e di inesauribile capacità di lavoro come Lankelot gli strumenti da tenere in conto, per far davvero lievitare il millennio con qualche idea. Rimpianti? Via non siamo ipocriti, molti; ma come sappiamo, la macchina del tempo per il momento non è ancora disponibile. Certezze? Prossime allo zero. Speranze? Si spera nonostante tutto di continuare a mitizzare il futuro, il che fa sentir giovani”.
EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE
Luciano Troisio (Monfalcone, 1938-Padova, 2018), giornalista, critico letterario, poeta e narratore italiano. Ricercatore nel Dipartimento di Italianistica dell’Università di Padova, ha insegnato Letteratura Italiana Contemporanea. È stato docente nelle Università di Pechino, Shanghai, Bratislava e Lubiana.
Luciano Troisio, “La ladra di pannocchie”, Manni, Lecce, 2004, pp. 198, euro 15. Il romanzo è strutturato in tre parti, titolate “Ladra di frutta”, “Il karma di Dora” e “OGM: il Dio del mais”, suddivise rispettivamente in 7+3+3 capitoli, a loro volta ripartiti in brevi paragrafi.
Gianfranco Franchi, gennaio 2004.
Prima pubblicazione: Lankelot.
