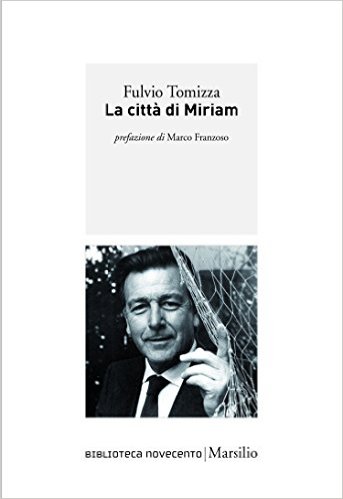 La città di Miriam
La città di Miriam
Mondadori
1972
9788831706674

“L'amore forse è un'entità assoluta. O esiste pieno e spontaneo e va accolto interamente come avveniva da parte di lei, oppure deve essere conquistato con fatica, depurato, costruito ex novo tessera per tessera, inserendovi anche la gelosia che non ha motivo di sussistere, la precarietà che non c'è. Era toccato a me soffrire perché io avevo avuto altre donne, lei nessun uomo [...]” [Tomizza, “La città di Miriam”, p. 138].
1972. Trentasettenne, Fulvio Tomizza pubblica il suo settimo libro di narrativa, sempre per Mondadori. “La città di Miriam” è il terzo dei quattro libri il cui protagonista è l'alter ego dell'artista istriano, Stefano Marcovich: in questo senso, viene dopo “La quinta stagione” [1965] e “L'albero dei sogni” [1969]. Tre sono le grandi novità, rispetto all'intera produzione autoriale, sin qua; la prima è l'ambientazione integralmente triestina, con poche e irrilevanti sortite al di là del Lisert, tendenzialmente per questioni lavorative o per dongiovannesche imprese; la seconda è la guadagnata, discreta lateralità, nell'economia del testo, della tormentata identità istriana di Tomizza; la terza è l'inattesa centralità dell'aspetto passionale e sentimentale della vicenda narrata. “La città di Miriam” è in sostanza un romanzo sentimentale, diciamo una sorta di romanzo di formazione di una coppia, prima, durante e dopo il matrimonio; meglio ancora, è la complicata e progressiva accettazione della stabilità della vita di coppia raccontata dallo sguardo di Stefano Markovich – uno a cui piaceva divertirsi, uno che amava l'amore.
Il romanzo racconta la relazione dell'esule istriano e della borghese triestina, ebrea; racconta il fascino e la dolcezza di Miriam e l'inquietudine e l'irrequietezza di Stefano. E restituisce qualcosa delle famiglie di tutti e due; s'allude alla nonna di Stefano rimasta in Istria, al fratello che ha rischiato di diventare prete per quanto credeva in Dio, alla madre che si rabbuiava pensando a quel che era accaduto nelle sue terre e nel suo paese; e si approfondisce molto, invece, il suocero, il dottor Cohen, notevole esemplare della borghesia ebraica triestina – quella, per capirci, di Umberto Saba, di Edoardo Weiss, quella da cui derivava e discendeva Aron Ettore Schmitz.
Il dottor Cohen è uno che, “incoraggiato da Freud, aveva voluto farla finita col proprio clan, di cui 'il sangue era saturo', sposando la bella zagabrese cattolica e, a giustificazione dell'impietosa battuta, ancora ricorreva al grande medico di Vienna, stabilendo che uno sfogo verbale fosse ogni tanto necessario all'igiene morale” [p. 20]. Sua figlia Miriam, insomma, è sanguemista, e a ragion veduta. Cohen è un uomo “di vasto sapere”, per il quale la lettura era stata “sola seria occupazione della vita”: forse per questo sa vivere tanto bene e sa rasserenare e confortare con tanta semplicità. Racconta Tomizza che si metteva “pazientemente in prima fila davanti al televisore quando i programmi serali non erano ancora iniziati e non mollava prima della sigla di chiusura. Solo allora si andava a cena, da gente abituata al teatro”. Per campare ha un misterioso ufficio, dalle parti di Ponterosso, nei magazzini; quella piccola ditta di pesce affumicato è la sua “bottega”. Unico dipendente un istriano, Degrassi.
L'amore che Stefano Markovich sente per Miriam è composto anche dell'amore che sente per suo padre, un uomo gentile e generoso, colto e umano: un piccolo maestro di vita, e di civiltà cittadina, soprattutto per un ragazzo che viene dalle campagne istriane.
Già: sentite qua com'erano stati i primi tempi a Trieste, vissuti dopo la disgraziata cessione dell'ultima parte dell'Istria, la cosiddetta “zona b”, alla Jugoslavia: “Da tre anni a Trieste, girovagavo squattrinato lungo il Corso, gli occhi contadini a stabilire l'inizio di una stagione dalle dimensioni di un germoglio, dalla sfumatura delle foglie. Avevo soprattutto colto che quasi in sostituzione degli alberi ogni anno (e per me soltanto quell'anno) le fanciulle toccano a turno la loro primavera [...]” [p. 151]. E la primavera che seduce Stefano è quella della piccola Miriam, che sulle prime percepisce ragazzina: “Negli occhi tanto bianchi quanto neri, nel vitino che potevo cingere con le quattro dita, mia Anna Frank che in quella stessa città avevo da giovane vanamente inseguito dopo un'apparizione pomeridiana e che ora avevo finalmente raggiunto, nella sua casa. Me la sollevavo all'altezza del viso e la stringevo” [p. 21].
Cosa conquista Stefano? Miriam appartiene “all'altro Paese fin poco prima ostile”, eppure incarna il suo sogno erotico: “l'immagine di ragazza che proprio là avevo cercato spingendomi quanto più al sud, fino in Macedonia, sempre alla ricerca di una pelle scura e di labbra carnose come le sue e d'un paio d'occhi altrettanto neri” [p. 58]. Il corpo di lei ha qualcosa di perfetto: sembra “l'immagine di una statua, di quelle che ornano la Borsa e gli altri palazzi austriaci della nostra città: divinità di una religione laica di cui ignoravo i culti particolari, gli speciali riti” [p. 60]. Lei è innocente e dolce – sino a sembrare docile. È seducente e tenera. È Trieste che vuole accogliere il ragazzo istriano, dargli una casa, dargli da lavorare.
Il primo lavoro di Stefano lo rimedia papà Cohen: nel quotidiano “Il Piccolo”, grazie a un direttore “suo ex condiscepolo e correligionario”. Tutto parte dalla terza pagina, e da lì s'avvia la carriera giornalistica del ragazzo, e la sua sicurezza economica minima. E la vera casa di Stefano è casa Cohen ben prima del matrimonio; si può dire che il matrimonio con Miriam cominci in quel periodo. Ma non c'è nessun opportunismo e nessun calcolo. C'è, piuttosto, predestinazione. E qualcosa di fiabesco.
Tomizza racconta e romanza il matrimonio, la perdita del suocero e il fallimento della sua azienda; una quasi gravidanza e tutta una serie di tradimenti, sempre meno infantili e sempre più iniziatici [“Se tutto fosse filato come ai giorni jugoslavi, nei riposi e pentimenti notturni sarei stato probabilmente pungolato questa volta dalle tacite apparizioni di una specie di Madonna, sia pure ebrea. Ma le nostre Madonne erano bianche, paffute e rosee: Miriam con la sua pelle bruciata restava dall'altra parte” - p. 118]. Intendiamoci: è un'iniziazione cialtrona e decisamente forzata, a dir poco tirata per i capelli. Ma infine riesce. Stefano sembra accettare d'essere sposato – e di poter evitare di corteggiare e sedurre le altre. Perché a lei sola appartiene. Perché lei sola è sua.
Trieste, la meravigliosa città di piazza Unità e piazza della Borsa, è la città del grande amore di Stefano, e della sua vita da adulto. Nelle descrizioni di Tomizza, s'intravede qualcosa di diverso da quel che ci si potrebbe attendere; non si parla del grande porto dell'impero austriaco, né del glorioso passato della città, quarta dopo Vienna, Budapest e Praga, in quel perduto mondo; né si parla dei rovinosi interventi italiani nell'architettura cittadina; si parla, invece, di via Rossetti, del Giardino Pubblico, e ogni tanto di Ponterosso, in quel periodo più che altro meta dei pellegrinaggi commerciali degli jugoslavi, mancati compatrioti del narratore. Trieste, in questi anni a cavallo tra il 1954 e il 1991, è pur sempre l'emporio “della più vicina città d'Occidente” [p. 55]. E la prima jeanseria.
Entriamo in città col treno: “S'intrometteva tra le pietraie grigie del Carso, giustamente dormienti, rasentava Barcola leggera sul mare e il retorico Faro della Vittoria dall'altro lato, slittava sul cavalcavia e irrompeva in uno sproporzionato intrico di binari ruggini sotto i magazzini ciechi del Porto Vecchio, per finire la lunga corsa nella città di Miriam e dormirvi, forse per starci” [p. 129].
… e finiamo per scoprire che per Tomizza-Markovich amare Miriam significa, anche, capire che esistono due Trieste. “Perché esistono due Trieste, lo avevo intuito dalla finestra della mia inutile fuga: una che aggredisce, l'altra che incassa. La prima degli alti biondi spesso arricchitisi da poco e aggrappati al loro Carso che in fondo idolatrano per eluderlo, riconoscendovisi in buona e scomoda misura; la seconda degli eterni fuggiaschi d'Oriente, insicuri anche nell'ombra delle loro chiese greche, serbo-ortodosse, e delle loro sinagoghe. Guardai quasi con disperazione Miriam per la cui parte avevo optato, esule a mia volta [...]” [p. 87]. E tenendo presenti queste prime due anime scoperte (o riconosciute?) nella città, quella dei figli del Carso e dei figli d'Oriente, andremo incontro agli altri suoi libri, man mano sempre più legati alla città di Scipio Slataper e di Giani Stuparich – la città di Miriam, sua moglie e musa.
EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE
Fulvio Tomizza (Giurizzani di Materada, frazione di Umago, Istria, Italia; 1935 – Trieste, FV-Giulia, Italia, 1999), scrittore e giornalista istriano. Esordì, come narratore, pubblicando “Materada” nel 1960.
Fulvio Tomizza, “La città di Miriam”, Mondadori, Milano 1972.
Prima edizione: Mondadori, 1972. Poi Mondadori, 1976. Quindi: Rizzoli, 1983. Oggi in Marsilio, 2010, prefazione di Marco Franzoso. ISBN: 9788831706674.
Approfondimento in rete: WIKI it
Gianfranco Franchi, aprile 2012.
Prima pubblicazione: Lankelot.
Un romanzo sentimentale, diciamo una sorta di romanzo di formazione di una coppia, prima, durante e dopo il matrimonio
