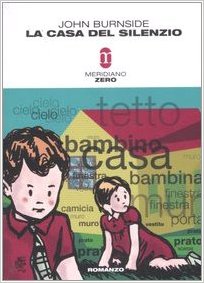 La casa del silenzio
La casa del silenzio
Meridiano Zero
2007
9788882371456

La ricerca dell’essenza: il locus dell’anima. L’indagine sulla coincidenza tra linguaggio e anima: la reminiscenza delle letterarie segregazioni per osservare la rivelazione spontanea del linguaggio divino. La disperazione del silenzio, l’ossessione del senso. Tutto questo sembra essere estraneo al noir: non quando il noir è l’opera prima, in narrativa, d’un poeta, d’un poeta laureato, John Burnside. Questo libro trasfigura e sintetizza la ricerca d’ogni poeta consapevole: quella della natura del linguaggio, quella della coincidenza tra linguaggio e realtà, quella dell’epifania del suono primo. L’intelligenza letteraria di Burnside è stata capace di stabilire tutta una serie di convergenze con stilemi e dettami d’un genere, il noir, pronto a interiorizzare le psicosi e le manie d’un individuo deragliato e dissociato; stupisce e meraviglia, in ogni caso, la stratificazione del palinsesto di questa scrittura. Destinata a soddisfare sia chi vuole inabissarsi nell’anima d’un assassino, sia chi vuole attraversare l’anima d’un poeta: Luke, il protagonista del romanzo, è inevitabilmente (e non credo involontariamente) tutto questo. È un filosofo assassino, è un omicida di creature di carta e di carne: è l’artista d’un fallimento inevitabile, quello della ricerca della verità, e non ha più equilibrio. Uccide figli e compagne come se cancellasse versi d’un poema sbagliato, come fossero nient’altro che congetture o sperimentazioni. Sono omicidi realistici come la collazione di due manoscritti. Il manoscritto più antico è illeggibile proprio nei momenti fondamentali. L’altro si direbbe un apocrifo. Il filologo non sa risolversi: crux desperationis. Questa ricerca è un cimitero, croci su croci interrotte da un canto che non è forse umano, ma non è nemmeno divino: è forse animalesco.
La risposta l’ha cercata invano Psammetico, nelle Storie di Erodoto: nel libro secondo (e qui a p. 34 e ss.), leggiamo di come avesse affidato due bambini neonati a un pastore, perché crescessero all’ombra d’ogni parola umana, nascosti in un gregge. Desiderava sapere quale linguaggio avrebbero adottato. Due anni dopo, pronunciavano una prima parola in frigio: “becos”, pane. Ma è una leggenda, s’affretta a dire il narratore. Come quella di Giacomo IV e del bambino che parlava ebraico. Niente vale la semplice bellezza della storia di Akbar, l’imperatore analfabeta che collezionava manoscritti. Quella era la storia che gli raccontava sua madre, la storia della casa del silenzio. Un palazzo popolato da servitori muti, destinati ad accudire quei neonati che avrebbero testimoniato, imparando (per così dire) dal silenzio, quale fosse la lingua divina, quella che vive in tutte le anime. “Nessuno sa per quanto tempo quella casa sia poi rimasta in piedi, o cosa ne sia stato dei bambini che vi erano imprigionati con i loro muti custodi” – ché anche questa storia è poco più che un aneddoto. Akbar non credeva che il linguaggio fosse equivalente all’anima, diversamente dai suoi saggi. Quella casa restò muta: “Gang Mahal”, la Casa del Silenzio. Una favola nera e diabolica.
Luke vuole andare oltre la leggenda e oltre l’aneddoto. Sta indagando, come Akbar e come Psammetico, il segreto del silenzio: convinto nasconda l’essenza, riveli l’arcano dell’origine della specie. “Che poi era quello che mi aveva sempre detto la mamma: una creatura senza linguaggio è una creatura senz’anima. Per conoscere l’anima, quindi, dovevo conoscere il linguaggio. Sembrava così ovvio che ero sorpreso di non averci pensato prima. Ora sapevo qual era la mia vera vocazione. Se volevo dissezionare l’anima, dovevo adottare sistemi nuovi, acquistare nuove abilità” (p. 83). Cercando il momento esatto della morte, aveva dissezionato animali – seguendo e perfezionando un antico insegnamento di quel suo materno idolo che voleva spiegargli la morte mostrandogli le carcasse degli animali, nel bosco.
Il linguaggio ha un potere infinito, Luke non riesce a pensare ad altro. Vuole dominare questo potere, scoprendone l’innesco. “Viviamo in un mondo di parole, le cose esistono grazie al linguaggio, e il linguaggio può cambiare le cose o mantenerle fisse dove sono” (p. 47): è un poeta, questo assassino, ha la malattia del poeta; la ricerca del senso, della verità, della parola prima. Magnifico. E totalmente letterario. Restiamo, quindi, solo in parte interdetti di fronte al suo complesso e maniacale rapporto con la madre, cantastorie e idolo del narratore. Certe esasperazioni – nudità esibita in punto di morte, sciagurato pomeriggio d’adolescenza passato per profumi e balocchi materni, freddezza nei confronti della figura paterna, distaccata (“invisibile”) e fragile, accenno a violenza sessuale in tenera età – scivolano via quasi fossero pleonastiche. L’essenza è quella ricerca, il resto sembra essere una forma di rispetto nei confronti d’un pattern. Altrimenti: il freddo furore omicida nasce – se vogliamo stabilirne un’origine – quando il ricercatore s’accorge che il linguaggio può fallire: che quindi l’ordine non esiste e che il caos è una destinazione plausibile.
Impossibile che niente abbia senso e che l’origine non esista: impossibile che questo mio linguaggio non discenda dalla mia anima, e che la mia anima non discenda da un dio, grida il poeta. Senza che nessuno risponda: niente risposta, risposta sola il silenzio. Quel silenzio ammazza.
Il nostro ossesso rifiuta distinzioni tra libero arbitrio e destino, sentiti come “falsi opposti” e “illusioni consolatorie”: “Si sceglie quello che si sceglie e non può essere altrimenti: la scelta è destino (…). Parlare di libertà o di destino è insensato perché sottintende che, oltre a voi, qualcos’altro governi la vostra vita e ne sia l’essenza: identità, manufatto dell’anima” (p. 27). E anima: manufatto di? Silenzio.
Nel romanzo incontrerete – al di là del racconto dell’infanzia e dell’adolescenza del narratore, caratterizzate da tenace idolatria materna, si sarà inteso – due donne, vittime della sua pazzia. La prima, Karen, è madre di un piccolo che rifiuta di comunicare a parole; ne deriverà una relazione morbosa tra lei e Luke, con inevitabili violenze al piccolo, muto ma non insensibile nei confronti del disastro incombente per l’avvento dell’ossesso nella sua vita.
La seconda, Lillian, muta e già oggetto delle violenze di un compagno brutale, si ritroverà nelle grinfie di Luke – splendido nuovo esemplare per le sue ricerche – e gli donerà due gemelli, che scopriamo assassinati già nelle primissime battute del libro. I due, simbolicamente battezzati come manoscritti, A e B, cresciuti secondo la lezione di Akbar, svilupperanno una sorta di canto che sgomenterà il narratore; l’epilogo di questo suo esperimento è prevedibile, il crescendo della follia meno.
Al termine, si rimane discretamente angosciati: come di fronte a una pagina di Wittgenstein sul linguaggio, o come di fronte ai versi d’un mistico sull’origine del suo canto. S’avanza nella ricerca senza fine, ma non senza un fine. La meta, infine, ti benedice o t’oltraggia col suo silenzio.
EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE
John Burnside (Dunfermline, Fife, Scozia, 1955), poeta e narratore scozzese. Insegna presso la St Andrews. Questo è il suo primo romanzo.
John Burnside, “La casa del silenzio”, Meridiano Zero, Padova 2007. Traduzione di Francesco Francis.
Prima edizione: “The Dumb House”, 1997.
Gianfranco Franchi, novembre 2007.
Prima pubblicazione: Lankelot.
La ricerca dell’essenza: il locus dell’anima. L’indagine sulla coincidenza tra linguaggio e anima…
