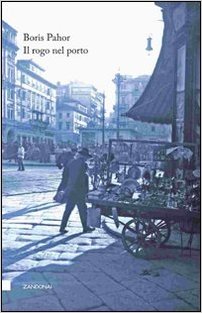 Il rogo nel porto
Il rogo nel porto
Zandonai
2008
9788895538112

Scriveva il poeta Carolus Cergoly: “Hohò Trieste / Del sì del da del ja / Tre spade de tormenti / Tre strade tutte incontri / O Trieste / Piazze contrade androne / Piere del Carso / Acqua de marina / Tutte t’ingrazia / Mettile in vetrina / E mi insempià / Col naso contro vetro / Vardo e me godo / Le bellezze tue (…) O Trieste / Caro viso / Adorabile volto / Inferno e paradiso / Mio albero cressù / Dentro de mi” (“Trieste”, tratto da “Latitudine Nord”, Mondadori, Milano, 1980, p. 147).
… scopriamo allora l’altrimenti misteriosa Trieste “del da”, a partire da un triestino doc, il letterato sloveno Boris Pahor, classe 1913. Questa sua raccolta di racconti, edita da Nicolodi nel 2001, è la prima a venire pubblicata in traduzione italiana. Le ragioni del disinteresse sono complesse da capire, a fronte di una serie di importanti riconoscimenti internazionali. E non è un disinteresse isolato, scopriamo: “Se gli studenti italiani della nostra città potessero conoscere Preŝeren, Gradnik e Kosovel, allora la vita da noi diverrebbe un vero paradiso. Sì, Kosovel per esempio, se Seghers l’ha pubblicato nella collana dei 'Poètes d’aujourd’hui', perché non potrebbe varcare la soglia dei licei italiani?” (p. 266), si domanda l’autore nell’importante racconto “Una sosta sul Ponte Vecchio”.
Vedo allora di fare un po’ di storia: meglio ancora, di raccontarla con le parole dell’autore, perché (anche) da lui la sto imparando, altrove difficilmente si legge con tanta chiarezza. Chiedo perdono per queste ampie campionature, la mia analisi verrà in seguito, promesso. “(…) tutto ebbe inizio nel ’48 del secolo scorso, quando i popoli cominciarono a prendere coscienza della loro identità. Allora anche noi smettemmo di considerarci una plebe senza storia, un popolo di soli contadini, di scaricatori di porto, di serve e di balie. E fu allora, nel momento in cui cominciò ad emergere la borghesia triestina slovena, che iniziò la vostra lotta contro di noi, il vostro odio, eh sì, il vostro odio. Vi rifiutavate di ammettere che noi si stava prendendo coscienza di noi stessi, perché siamo sempre stati qui, buon Dio, noi venivamo a galla, come disse Slataper. E siccome voi eravate cocciuti e non volevate concederci una scuola slovena a Trieste, ce ne costruimmo una per conto nostro, una privata. E un edificio per le manifestazioni culturali, un palazzo grande e bello disegnato dal Fabiani. E così ci siamo imposti economicamente e socialmente. Altro che”. (pp. 266-267).
Un bel respiro. Interiorizzata la storia breve della minoranza slovena di Trieste, sin qua? Molto bene. Un po’ di pazienza e scopriamo il resto.
“Ma poi venne il ’18. Allora tutto cambiò. Quando diventammo cittadini italiani, le cose per noi si misero male, con la dittatura nera poi tutto crollò. Già nel ’20, infatti, venne dato alle fiamme il palazzo del Fabiani, poi seguirono le case di cultura nei sobborghi. Poi vennero cambiati i nomi e i cognomi. E così – perché ci ribellammo – ci ritrovammo dietro le sbarre e davanti ai plotoni d’esecuzione (…) roghi di villaggi, campi di concentramento, quello di Rab-Arbe in primo luogo” (p. 267).
Seguono riflessioni amarissime sulle foibe, solidarietà e dichiarazione di estraneità riguardo all’esodo degli italiani (istriani) dall’Istria. Quindi, la morale della favola: importante e, direi, molto onesta. “Ecco, la storia ci ha messi tutti alla prova, voi, la comunità maggioritaria, e noi, la minoritaria; il compito nostro, ora, è di fare in maniera che ci si possa riunire in un saggio convivio. Lévy-Strauss afferma che non esistono popoli-bambini, quindi noi potremmo, qui da noi, vivere da pari a pari” (p. 267)
Bene. Sin qua possiamo trarre delle prime conclusioni interessanti; pure se, paradossalmente, stiamo trattando l’ultima delle tredici novelle – posta pur sempre in positio princeps, intendiamoci. Primo: Pahor ricorda e rivendica la presenza secolare (medievale) d’una minoranza slovena a Trieste. Secondo: non intende nemmeno confutare propagandistici assiomi vincolati al giovane nazionalismo e alla giovane storia d’un popolo, che semplicemente ha assunto coscienza di sé e indipendenza nel tempo, con qualche ritardo rispetto all’Italia. Terzo: non chiama Trieste slovena, parla del sogno d’una coesistenza tra etnie: maggioritaria italiana e minoritaria (aggiungerei: minoritarie, pensando ad altre ancora: da quella ebraica in avanti). Assieme, spiega cosa accadde a Trieste nel momento del violento passaggio dall’Austria all’Italia: la negazione della libertà prima e dell’esistenza poi d’una etnia emergente diversa dalla maggioritaria. Questo mi sembra estremamente limpido.
Restiamo alla storia, prima di tornare alla Letteratura. Quando ebbe materialmente inizio tutta questa violenza? Nel web, ho trovato risposta in un’intervista apparsa sul sito “Eco Mancina”. Riporto le battute di Boris Pahor: “Già nel 1920. In quell’anno vennero dati alle fiamme tre centri di cultura sloveni, uno a Trieste città, uno a Barcola e uno a San Giovanni, assieme a molti studi di nostri avvocati, a tipografie, teatri. Ma l’incendio dei centri culturali è stato un atto molto forte, perché noi sloveni siamo sempre stati legati ai nostri centri di cultura. In ogni borgo, per quanto piccolo, sorge anche oggi una kulturni dom. È questa consapevolezza della nostra identità che ci ha aiutato a sopravvivere nei secoli. Nel ‘30, a dieci anni dall’incendio, Francesco Giunta, uno dei fondatori delle squadre d’azione triestine, celebrò in un libro l’evento come la prova che la rivoluzione fascista era nata proprio a Trieste”
Da questo punto in avanti, non prima di aver consigliato la lettura del saggio di Jan Morris su Trieste, del fondamentale studio di Ara e Magris, dell’antologia 1945-1953 di Karlsen e Spadaro, per assimilare adeguate ed equilibrate informazioni sulla storia della città, do per scontato che chi legge abbia compreso almeno la sintesi della vicenda della comunità slovena a Trieste: raccontata dagli sloveni triestini. Le spiegazioni di Pahor mi sembrano d’una linearità esemplare, e non credo possano essere fraintese o arbitrariamente disarticolate. La tentazione di scrivere che questo libro possa appartenere alla Letteratura Italiana, per via di due riscritture del professor Pahor, l’ho avuta: mentirei se affermassi il contrario. Tuttavia si tratta, in tutti gli altri casi, di traduzioni: è semmai quindi, e senza forzare la mano, Letteratura Triestina, pura espressione del territorio, anche questa. Come quella del tedesco Veit Heinichen, pure mascherata da noir; con la differenza non elementare che Pahor è nato a Trieste nel 1913, quando si chiamava Triest e le istituzioni sventolavano la bandiera dell’urbs fidelissima. Questa scrittura è parte del dna della città, testimonianza ineludibile della vita e della cultura d’una delle sue comunità. È il primo libro di Letteratura Slovena che incontro in trent’anni; quel che ne sapevo era merito dell’articolo di Karlsen sul libro di Miran Košuta, a proposito dei suoi peripli letterari italo-sloveni. Ammetto quindi la mia inadeguatezza: non potrò comparare Pahor a nessuno dei suoi predecessori, né dei suoi contemporanei sloveni. Mi sto concentrando quindi su tre aspetti: territoriale, storico-politico e stilistico dell’opera.
Questo è un libro di novelle. L’edizione non riporta indicazioni della prima pubblicazione in lingua originale; congetturo quindi che si tratti d’un’antologia di racconti dell’autore pubblicati a distanza di tempo, e soltanto qui in unica soluzione. Protagoniste assolute della narrazione: Trieste e la comunità slovena. A partire dai giorni dei bombardamenti delle navi austriache, attraverso il tragico episodio dell’incendio della Narodni Dom, per ispirati spaccati e affreschi delle condizioni dei cittadini nella loro difficile quotidianità; quindi, delle condizioni economiche, sociali, politiche in generale, con particolare sensibilità nei confronti del periodo del regime fascista, sino all’epilogo pressoché contemporaneo, racconto d’una gita d’una scolaresca slovena e triestina a Firenze. Da quel racconto ho tratto i frammenti iniziali. La prima Trieste che racconta Pahor è quella filtrata dal protagonista sloveno, il piccolo Lojzek. Segue un gruppetto di italiani nella loro disperata impresa bellica; rubare del carbone dai vagoni d’un treno, quando s’arresta. Non è parte del gruppo semplicemente perché è troppo piccolo. Non emergono guasti dovuti all’intolleranza. La vicenda rivela le difficili condizioni dei cittadini durante la Prima Guerra Mondiale, l’umanità del gendarme che si limita a rampognare il bambino per aver assistito al furto, senza arrestare nessuno, la tragedia di questi piccoli che possono incappare in tragici incidenti per non far sentire troppo freddo alle mamme, a casa. Lo stile è neorealista, la sensibilità socialista, l’allegoria delle fauci del leone tutta da scoprire, per i neofiti.
Ecco quindi il giorno del racconto eponimo della raccolta: Trieste non più austriaca, navi da guerra affondate nel golfo, e l’italianità al governo intanto implica camicie nere col fez che inchiodano le porte, mentre la gente salta dalle finestre; i soldati stanno a guardare. Cocci, vetri rotti, mura bruciate, armadi sventrati. E contrasti tra sloveni, tra chi al censimento s’era dichiarato sloveno e chi aveva preferito fingere d’essere altro; diversi fuggono in Francia, per evitare il fascismo.
E così avanti, per memoria delle antiche battaglie tra sloveni e turchi, per memoria di quel quotidiano, “Edinost”, soppresso nel 1929; per spaccati d’una povertà che non abbandona tuttavia la dignità, e nemmeno l’orgoglio. Avanti per il racconto dell’abolizione delle scuole slovene (come ne “Il naufragio”), per i paradossi d’un’educazione poliglotta coatta (sgridate in sloveno dai genitori, se non si impara l’italiano; errori di traduzione), violenze nelle scuole italiane (come ne “La farfalla sull’attaccapanni”), laddove farfalla è allegoria per signorina, una Julka che per il maestro italiano era soltanto Giulia, che parlava nella sua lingua a un compagno, che per questo andava umiliata di fronte a tutti. Più avanti, la fine del fascismo (“Nuove fibre”). Avanti con le storie di quelle tombe che non si potevano avvicinare (“Fiori per un lebbroso”, estremamente toccante; cfr. ampia descrizione finale, p. 130).
Pahor è necessario non soltanto perché scrive con classe e intelligenza; è necessario perché tutela e rappresenta una cultura ancora molto poco nota, piuttosto fraintesa e spesso ingiustamente accantonata. Eppure gli italiani non dovrebbero dimenticare che si tratta della cultura d’uno dei (pochi) Paesi confinanti; che assieme il futuro è europeo, a dio piacendo; che larga parte della storia, almeno nel Nord-Est, è ampiamente condivisa, e sotto diverse bandiere, e da secoli. Per i triestini questo è un libro che scotta. Scotta parecchio agli italiani trapiantati a Trieste, triestini della Repubblica Italiana, perché sono stati addomesticati a ripetere italia, italia, come fosse un mantra, e altro non possono vedere che tricolore, anche laddove non può esistere da solo; risulta luminoso invece e suggestivo per i triestini veri, e per chi conosce la storia della città senza filtro ideologico coevo: e allora finalmente trova la risposta a tante domande, a tanti silenzi, a tanta rassegnazione all’isolamento, e alla rivendicazione delle proprie peculiarità e della propria storia; trova il senso di tanto orgoglio. Per molti anni abbiamo studiato, nelle scuole e nelle università, l’importanza delle testimonianze e delle dichiarazioni dell’alterità, o del nemico. Qui il nemico non c’è più, c’è un concittadino che parla un’altra lingua; e offre comprensione e solidarietà per la tragedia dell’Istria, raccontando che in quell’esodo ha riconosciuto frammenti della storia del suo popolo. Qui c’è un letterato dalla ricca lingua letteraria, dalle notevoli capacità descrittive, capace di scolpire dialoghi esatti e mai artificiosi. Qui c’è, in altre parole, un altro pezzo del mosaico di Trieste. Senza, il disegno non sarà mai giusto e non sarà mai vero per nessuno.
E la Slovenia, cosa potrà portare all’Europa? – domandava Floramo sempre nell’intervista citata in apertura. Boris Pahor: “Per prima cosa l’esempio di come si possa restare fedeli alla propria identità senza armate, senza generali e senza ammiragli. Un’identità bastata sulla cultura. E questo gli sloveni hanno imparato a farlo sopravvivendo a una storia che da sempre ha cercato di assorbirli, di omologarli: prima la germanizzazione dell’Impero Asburgico, poi il Fascismo e l’Italianizzazione forzata e infine gli anni iugoslavi, serbizzanti, orientalizzanti. L’internazionalismo di Tito è sempre stato contrario alla salvaguardia delle identità nazionali (…)” (da un’intervista di “Eco Mancina”).
Non è poco. È una lezione – sono dei messaggi – da tenere bene a mente, da qui in avanti. Vogliamo leggere tutto Pahor in italiano, e scoprire Kosovel. Che niente ci venga nascosto, meno che mai l’arte e la verità. Chi ci ascolta?
EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE
Boris Pahor (Triest, 1913), letterato sloveno, triestino. Laureato in Lettere presso l’Università di Padova, insegnò nelle scuole medie superiori slovene di Trieste. Vice-presidente dell’Associazione Internazionale per la difesa delle lingue e delle culture minacciate. Autore di romanzi e novelle, saggista, è direttore di “Zaliv” (“Il golfo”, rivista che si è battuta per la democrazia in Slovenia e per l’affermazione dell’identità slovena.
Boris Pahor, “Il rogo nel porto”, Nicolodi, Rovereto 2001. Traduzione di Mirella Urdih Merkù, Diomira Fabjan Bajc, Mara Debeljuh. Due novelle sono state riscritte dall’autore.
Gianfranco Franchi, luglio 2007.
Prima pubblicazione: Lankelot.
