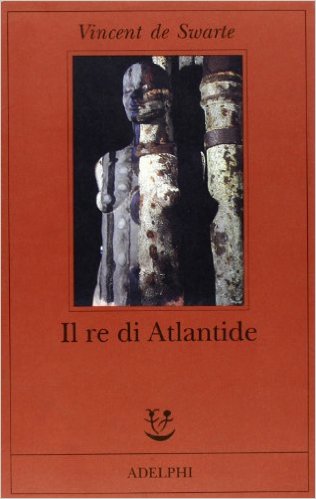 Il re di Atlantide
Il re di Atlantide
Adelphi
2000
9788845915222

Storia di un guardiano del faro, e della dissoluzione del suo equilibrio psichico. Storia della corrosione della lucidità d’una mente, e d’un amore disperato, di folli e di alienati. Storia di un romanzo che va letto non dico dimenticando, ma letteralmente dileguando qualsiasi pregiudizio di natura etica, limitandosi a godere lo stile, scabro e incisivo, apprezzando l’ennesima avvincente incarnazione del gotico, enfatizzando il sublime che avvolge e domina l’opera.
“Il re di Atlantide” del titolo è il faro che il protagonista dell’opera, nella più totale solitudine, va ad abitare per un lasso di tempo che appare sin dalle prime battute interminabile, e inchiodato ad uno scorrere lento e farraginoso, macchiato dalla progressiva perdita di controllo e di lucidità del guardiano.
Il guardiano scoprirà, nella contemplazione della bellezza monumentale del faro, d’essersene come invaghito: e aderirà, con tutto il suo spirito, alla perfezione del faro, vivendo una simbiosi delirante. La solitudine è straziante, ed è il filo conduttore del testo, strutturato come un diario e dunque narrato in prima persona da Geoffrey, l’egiziano: così era stato chiamato, per via dei suoi lunghi silenzi, dagli amici di un tempo. La personalità sinistra del guardiano si delinea allora attraverso narcisistiche riflessioni su se stesso, nel tentativo di annacquare il suo malessere persuadendosi della propria gentilezza, e attraverso inquietanti riflessioni sulla bellezza, e sulla morte.
Sin dalle prime pagine scopriamo che Geoffrey è un abile impagliatore: e ciò che riesce a creare, regalando immortalità alle creature che così trasforma, è spesso salutato da quanti vi incappano come una meraviglia: e il guardiano diventa agli occhi del pubblico un artista. L’opera è inquietante, si diceva, ed ossessiva; e scorrendo nella lettura delle pagine di questo diario osserviamo, passo dopo passo, scricchiolare e quindi precipitare l’equilibrio mentale del guardiano. Un giorno, giunge nei pressi del faro una coppia di inglesi, prossimi alle nozze; lui è innamorato del faro sin da bambino, e ha promesso alla sua compagna che lì avverrà il loro matrimonio; sono felici, vengono tratteggiati con pochi sapienti cenni dal De Swarte, che offre al lettore un’immagine d’una coppia unita e solare. Il guardiano li ospita per cena, e quindi decide di ucciderli: e nell’atroce squilibrio della sua psiche ritiene di doverli impagliare, per regalare così loro l’immortalità, e la perfezione sublime d’un amore altrimenti irrealizzabile: saranno per sempre assieme, e vivranno nel faro, come avrebbero desiderato.
Pochi giorni dopo il delitto, giunge nei pressi del faro una donna, ingegnere addetto alla supervisione dell’attività del faro. Da questo tratto in poi, tuttavia, evito di procedere nella sintesi della trama, preferendo che siate voi stessi ad addentrarvi nella tenebrosa foresta di questo romanzo. Tenebrosa, non intricata: nella follia di Geoffrey sono comprensibili ed evidenti dei sentieri, e non è difficile tentare una lettura psicanalitica dell’opera. Questo amore folle e autodistruttivo che vivrà avrà lo stessa impeccabile colore della sua ricerca: l’immortalità, e la perfezione.
Non è semplice accostarsi ad un testo del genere, perché così grande è la dannazione del protagonista e la corruzione della sua mente che è difficile, per ragioni etiche ribadisco, trarne un giudizio estetico scevro da malintesi e pregiudizi. Nella vita reale non troveremmo nulla di poetico o di affascinante nel delirio di un assassino. Qui, tuttavia, siamo nel regno della letteratura; nella dimensione della menzogna, e nell’universo della fantasia e dell’immaginazione. E allora, quanto scrissi tempo addietro a proposito del “Caligola” di Camus, in fin dei conti posso qui ripeterlo, perché mi sembra che la sintesi sia analoga: Geoffrey ha un progetto lucido. Tramite la morte, restituire la vita. Cercando una morte che presto otterrà, disperando in punto di perdere la vita di essere ancora vivo; e singhiozzando, perché quel che avviene è ciò che aveva desiderato.
A differenza del “Caligola” di Camus, qui se possibile la perversione è ancora maggiore e in un certo senso meno sofisticata: la parvenza di vita, lo spettro in vita rappresentato dalle creature umane e animali che Geoffrey impaglia ha un che di eccessivo, di grossolano, di irrimediabilmente concreto; e non è la parvenza di bellezza esteriore che regala loro a renderli immortali, ma la sostanza della loro stessa presenza al suo fianco. L’isolamento del guardiano lo induce a riconoscere vita in ciò che è non parvenza, ma simulacro di vita: parole in chi non può parlare, sentimenti in chi ha cessato di esistere. De Swarte vuole forse creare una visione da inferno di Boesch, e ciò che la rende se possibile più demoniaca è la macabra forma di lucidità che regala al suo personaggio.
Mentre leggevo il testo mi sforzavo di cercare dei parallelismi con altre opere; mi è tornato in mente “Follia” di MacGrath, per via della stessa morbosa e ossessiva descrizione di un amore tra alienati o tra ossessi, uno dei quali è uno scultore ospite di un asilo mentale per via dell’omicidio della moglie. Ciò che inquinava quel romanzo era l’abilità dell’autore di trasfigurare la propria ricerca artistica in uno psicolabile; quando parlava della creazione, e dello strazio del confronto tra ideale e reale, non doveva far altro che attingere alla propria esperienza. Tutto questo generava un cortocircuito nell’interpretazione del lettore. Ecco, in questo romanzo di de Swarte affrontiamo una tematica per certi versi analoga: lo stesso insolubile conflitto tra ideale e reale, tra volontà, o velleità, di esprimere e di esternare e frustrante incomunicabilità; tra vita, e desiderio di vita e di amore, e morte, prigione di ogni pensiero.
Un’opera disturbata e cupa; letterariamente pregevole, per carità, ma probabilmente giocata con astuzia sul confine tra le (irritanti) predilezioni di parte della nostra società per tutto ciò che è morbo o malattia, e il gusto noir e gotico di certo altro pubblico. Riservato agli appassionati del genere.
EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE
Vincent de Swarte (Montauban, 1963-Parigi, 2006), scrittore francese.
Vincent de Swarte, “Il re di Atlantide”, Adelphi, 2000. Collana Fabula, 124. Traduzione di Giorgio Pinotti.
Gianfranco Franchi, maggio 2002.
Prima pubblicazione: ciao.com.
Storia di un guardiano del faro, e della dissoluzione del suo equilibrio psichico…
