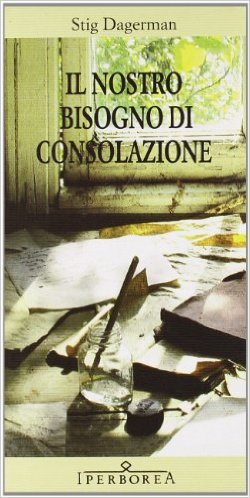 Il nostro bisogno di consolazione
Il nostro bisogno di consolazione
Iperborea
2015
9788870910216

Ribelle alla condizione umana, alla nostra estraneità alla libertà, alla nostra debole ricerca d’un sollievo alla sofferenza, al dolore, all’insensatezza, Stig Dagerman monologa sognando di non più essere: agogna il niente, l’oblio di sé, la cancellazione della memoria della sua esistenza – il silenzio vivente.
Il male del Novecento è stata la coscienza dei letterati di non avere più fede in nulla, neppure nella parola: il suicidio di Dagerman è speculare al suicidio di Drieu La Rochelle. Scriveva, Drieu, nel “Diario segreto”, agognando il niente: “Vorrei rientrare nella notte che non è la notte, nella notte senza stelle, nella notte senza dèi, nella notte che non ha mai portato il giorno, nella notte immobile, muta, intatta, nella notte che non è mai esistita e non esisterà mai. Così sia”. (“Diario 1944-1945”, 17 ottobre). Il suicidio è, consapevolmente, per entrambi, l’unica e autentica manifestazione di libertà dell’io: nel primo Novecento, analoga coscienza aveva spinto al volontario congedo i giovani e geniali intellettuali e artisti mitteleuropei Otto Weininger e Carlo Michelstaedter. Qual è la ragione della dedizione al niente? La speranza – e forse non è un paradosso eccessivo, se consideriamo quel che insegnava Max Stirner. La coscienza dell’io vanifica l’esistenza d’altro che non sia io: nessuna fede, nessun principio, nessun valore, nessuna verità. L’io non è tutto. L’io distrugge tutto. L’io che si dissolve è realmente io. Tutto quel che separa dall’io la sua essenza – Dio, Stato, Partito, Amore, Libertà, Uguaglianza, Fratellanza – è una menzogna e un artificio. Stirner – ecco il punto di contatto con Dagerman – ha uno spirito sinceramente anarchico: il suo scritto è un omaggio a una libertà totale e sconosciuta alla nostra razza. E questo libretto dell’artista svedese è un grido di rabbia, furore e disperazione di chi questa libertà assoluta dell’io ha intuito l’esistenza, ma ne disconosce l’attuabilità e la plausibilità in questo tempo. È un libro d’amore che si conclude con una promessa di suicidio: la tragedia è la negazione dell’intelligenza e dell’esistenza per guadagnare questo rifugio nell’infinito – ad ascoltare le confessioni dolci del silenzio.
Il nostro bisogno di consolazione non può essere soddisfatto. “Cosa stringo allora tra le mie braccia? Poiché sono solo: una donna amata o un infelice compagno di strada. Poiché sono un poeta: un arco di parole che tendo sentendomi pervadere di gioia e di spavento. Poiché sono un prigioniero: un improvviso spiraglio di libertà. Poiché sono minacciato dalla morte: un animale caldo e vivo, un cuore che batte irridente. Poiché sono minacciato dal mare: uno scoglio d’inamovibile granito” (p. 18).
Dagerman cerca espiazione. L’espiazione non è possibile. S’intuisce soltanto, nel testo – come nota intelligentemente Ferrari nell’introduzione – uno spiraglio di fede nella felicità e nella “consolazione” nell’esistenza: la bellezza. E tuttavia è uno spiraglio bruscamente accantonato – bruscamente, e forse non del tutto plausibilmente. La traccia del sostegno autentico al malessere dell’artista andava approfondita proprio in questa direzione. Con sereno estremismo espressionista: avanzando per negazioni dell’alterità, disboscando l’io da ogni sovrastruttura; sbarazzandosi di tutto quel che t’imprigiona, appartenendoti; e tuttavia consentendo contemplazione e adesione empatica alle fonti della bellezza. S’oppone tuttavia Dagerman, e così argomenta: “Ma tutto quel che mi accade di importante, tutto quel che conferisce alla mia vita il suo contenuto meraviglioso – l’incontro con una persona amata, una carezza sulla pelle, un aiuto nel bisogno, il chiaro di luna, una gita in barca sul mare, la gioia che dà un bambino, il brivido di fronte alla bellezza – tutto questo si svolge totalmente al di fuori del tempo. Che io incontri la bellezza per un secondo o per cent’anni è del tutto indifferente. Non solo la beatitudine si trova al di fuori del tempo, ma essa nega anche ogni relazione tra il tempo e la vita” (p. 24).
La libertà è in nessun luogo: solo letterario il sogno dell’utopia. Dagerman era un grande letterato: e tuttavia sentiva terribilmente la responsabilità d’essere un talento riconosciuto, e pativa al solo pensiero di tradire il suo nome. Non voleva significare niente per nessuno: combatteva la colpa dell’innocenza, aveva fame d’oblio.
La lucidità delle osservazioni di Dagerman trascina l’artista sino a salutare in ogni cosa falsa consolazione della disperazione, o dell’insensatezza: bastava spingersi un passo più avanti, per salutare nella meta dell’annullamento l’ennesima falsa consolazione. Curiosamente, Dagerman – come i suoi cupi simili novecenteschi – confida nella morte come in un riparo perfetto: identificandola, sic et simpliciter, con il “non-è”.
“La mia potenza sarà illimitata il giorno in cui avrò solo il mio silenzio per difendere la mia inviolabilità, perché non esiste ascia capace di intaccare un silenzio vivente. Questa è la mia unica consolazione. So che le ricadute nella disperazione saranno molte e profonde, ma il ricordo del miracolo della liberazione mi sostiene come un’ala verso una meta vertiginosa: una consolazione più bella di una consolazione e più grande di una filosofia, vale a dire una ragione di vita” (p. 26).
Possibile che questa sia la soluzione e questo il sentiero, e cioè che il suicidio possa manifestarsi come l’unica e autentica affermazione di libertà dell’io? E se fosse invece la rivendicazione d’una stanchezza irrecuperabile, d’una freddezza nei confronti dell’esistenza ormai immutabile, il sogno di qualcosa di diverso e di finalmente estraneo a dogmi, ruoli, menzogne?
Perché tingere di niente quel che forse niente non è? Dove la garanzia che lo spegnimento sia dissipatio, per dirla con le parole del grande Guido Morselli, e non intervallo, passaggio o – peggio ancora – rigenerazione? Questo non possono perdonare gli intellettuali del nuovo secolo ai talenti suicidi del Novecento: la fiducia nell’ultimo dogma – il più micidiale. Che il niente esista, e che abbia senso non averne affatto. Non era allora il silenzio e l’isolamento ascetico più opportuna e coerente destinazione? Negarsi, pur vivendo: esistere senza più essere. Svanendo dal proprio originario microcosmo, vivendo all’oscuro di tutto quel che aveva un legame col passato: andando a incarnare una monade. Soltanto, meditare. Fino a morire, magari. Senza exploit, e senza spettatori.Oggi è più facile credere nella logica dell’autistico che in quella del suicida. Questo libro si macchierà del sangue dell’artista a due anni di distanza dalla sua pubblicazione. Leggerlo, a cinquant’anni di distanza, è come metabolizzare una pietra: ruvida e incendiata di disperazione e di fede. Nel niente. Splendido, davvero.
EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE
Stig Dagerman (Älvkarleby, 1923 – Stoccolma, 1954), scrittore, poeta, saggista, sceneggiatore svedese. Diresse “Storm”, giornale della gioventù anarchica. Debuttò pubblicando il romanzo “Il serpente” nel 1945.
Stig Dagerman, “Il nostro bisogno di consolazione”, Iperborea, Milano 1991. Traduzione e introduzione di Fulvio Ferrari. In appendice, frammenti.
Prima edizione: “Vårt behov av tröst”, 1952.
Gianfranco Franchi, febbraio 2005.
Prima pubblicazione: Lankelot.
