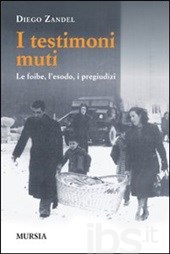 I testimoni muti
I testimoni muti
Mursia
2011
9788842546443

“L'esodo fa parte della storia del nostro Paese. Come fanno parte della nostra storia, rispetto a questo specifico problema, le responsabilità di quanti nell'immediato dopoguerra mostrarono una preconcetta ostilità contro i profughi, ritenendoli solo una massa di fascisti in fuga da chissà quale paradiso socialista. Invece erano in gran parte italiani e per lo più povera gente, vittima di una politica di annessione che aveva tra i suoi primi scopi quello, come diceva Milovan Gilas, di 'indurre tutti gli italiani ad andar via con pressioni di ogni tipo' dall'Istria” (Diego Zandel).
Memoir del letterato fiumano-romano Diego Zandel, giornalista e scrittore classe 1948, “I testimoni muti” è una sintesi delle sofferenze del popolo istriano, fiumano e dalmata costretto all'esilio, e un avvincente romanzo di formazione della prima generazione di figli dell'esodo: l'autore, nato nel campo profughi di Servigliano, si ritrovò a vivere assieme ad altri nostri fratelli nel Villaggio Giuliano-Dalmata di Roma, in via Laurentina. L'aspetto più affascinante dell'opera è decisamente questo: in questo libro Zandel spesso racconta e descrive ciò che è successo subito dopo l'apparizione della parola “fine”, in tanti romanzi e in tanti saggi, vale a dire nel momento in cui aveva realmente inizio la nuova vita degli esuli, in una terra a volte ostile. È una scelta intelligente e piena di sentimento e di onestà – ma non è l'unica strategia sensata adottata dal nostro bravo e talentuoso fiumano.
Zandel, strutturando l'opera in sei capitoli, non si limita a raccontare la vita dei profughi: racconta qualcosa di quella dei nostri fratelli “rimasti”, vale a dire di quegli italiani autoctoni che accettarono o sopportarono di vivere sotto regime comunista e straniero pur di non abbandonare le loro case; racconta significati e portata delle dolorose contrapposizioni tra jugoslavi e italiani (e non soltanto, per capirci, tra “s'ciavoni e fascisti”), denuncia angherie e aggressioni dettate da tutti i nazionalismi, sulla riviera adriatica e balcanica, spiega come ha vissuto e sta vivendo la progressiva accettazione e scoperta dei nostri compatrioti italiani della nostra storia di giuliano-dalmati, e infine si spinge sino a raccontare tanto al neofita delle vicende del confine orientale, tanto al neofita del dramma dell'esodo delle antiche e orgogliose comunità autoctone istriane, fiumane e zaratine, le ragioni in virtù delle quali non s'è verificato il “nuovo ritorno” dopo la caduta del regime comunista jugoslavo e la dissoluzione della nazione jugoslava in diverse e spesso del tutto nuove nazioni.
Zandel sa, come tutti quelli tra noi che non hanno vissuto la loro vita in Friuli-Venezia Giulia o almeno in Veneto, nel corso di queste prime tre generazioni (e la quarta già vagisce...), che raccontare agli italiani con onestà e sentimento la storia degli esuli e dei rimasti, e il clima politico e culturale che ha determinato i fratricidi, l'esodo e la diaspora è incredibilmente difficile. È difficile perché sulla storia dei giuliano-dalmati per decenni è piombata la cappa della damnatiomemoriae, parte per questioni di comodità politica, parte per questioni di prepotente propaganda della vecchia cultura egemone, parte per suprema arroganza o suprema ignoranza dei nostri concittadini. Zandel sa che molto spesso, raccontando da dove vengono le nostre famiglie – da dove venivano, mi viene da dire, sbagliando – ci siamo sentiti obbiettare: “Ma allora eravate slavi”, o “Ma allora eravate coloni italiani...”. E magari molto spesso i cognomi non aiutavano. Zandel sa che in certi frangenti, a darci dei “coloni” o, sic et simpliciter, degli slavi, non erano soltanto persone in malafede per questioni di patente partitica: erano, semplicemente, quegli stessi compatrioti che così dicendo ribadivano l'assurdità e la gravità del nostro sacrificio – quello degli unici italiani che avevano pagato la sconfitta della Seconda Guerra Mondiale e la scabrosa politica fascista nei confronti delle minoranze etniche slovene e croate nell'Istria Costiera, a Fiume e in Dalmazia, o nell'entroterra istriano a maggioranza italiana, come a Pinguente o a Montona, o in terre jugoslave in cui la minoranza eravamo noi italiani. Zandel sa quanto è difficile per i giuliano-dalmati farsi capire, e per questo ha aspettato tanto a scrivere un libro compatto, completo e denso come “I testimoni muti”. Sbaglieremmo però a dimenticare che grande è sempre stato lo spazio, nella produzione dell'autore fiumano-romano, dedicato al suo popolo e alla sua terra. Nella raccolta di racconti “Verso Est” (Campanotto, 2006), ad esempio, Zandel aveva dedicato pagine intense e memorabili, in appendice, ai suoi ricordi del Villaggio Giuliano-Dalmata di Roma, e quattro pezzi a questioni istriane e fiumane; in generale, nei suoi racconti e nei suoi romanzi d'argomento istriano e fiumano, come “I confini dell'odio” (Aragno, 2002) e “Il figlio perduto” (Alacran, 2010; ex “Una storia istriana”, Rusconi, 1987), si sente sempre un'ispirazione radicalmente più intensa – incrollabile. Tutto doveva portare a questo libro: “I testimoni muti” stava già prendendo forma. In un certo senso, culturalmente, spiritualmente e idealmente “I testimoni muti” è la sintesi delle scritture d'argomento fiumano e istriano dell'artista.
Zandel, come scrivevo tempo fa, commentando “Verso Est”, racconta le terre perdute con la nostalgia di chi sa d'essere stato sradicato forse per sempre dal mare e dalle case degli antenati, ma non dalla loro cultura e dalla loro identità. E sa farlo senza mai cadere nella trappola dell'odio etnico, cosa impossibile per tutti noi che di lì veniamo, composti come siamo di tante etnie diverse; e sa farlo senza mai mostrare odio politico. È un nemico dei totalitarismi: è una persona intelligente. È il figlio di un popolo che ha conosciuto gli aspetti più terribili e infami del fascismo e quelli più degradanti e disumani del comunismo. È un letterato puro. È un artista, piuttosto, votato alla pacificazione, alla conciliazione delle memorie e delle storie, nel rispetto della verità storica e nel sogno dell'armoniosa dialettica tra i popoli. È uno a cui essere riconoscente, perché ha saputo essere umano e tollerante nei confronti degli invasori delle nostre terre, limitandosi, con la mansuetudine classica degli istriani, a ricordare loro – con le sue storie – come erano e come andavano realmente le cose prima della disgrazia colossale dello scontro tra fascismo italiano e comunismo titino.
Perché – come scrivevano anni fa Nelida Milani e Annia Maria Mori nel loro magnifico “Bora” - è bene che tutti sappiano, e che tutti imparino a memoria, che “Non è vero che io e tutti i trecentocinquantamila esuli istriani, siamo, eravamo, borghesi e fascisti. Non è vero che tutta l'Istria era slava e doveva tornare alla Jugoslavia. Non è vero che tutta la mia gente è solo nostalgica e irredentista”. Ancora. “Non fummo noi, a volercene andare: la verità era, ed è, che 'loro' non ci volevano su quelle terre, di cui pretendevano di cancellare, insieme alla nostra presenza, anche la storia”. Chi restava doveva “tacere, obbedire, temere”. Il nuovo padrone era slavo e comunista. Non era ciò che diceva di essere: non era un liberatore di popoli. Niente affatto.
Come ricorda lo scrittore serbo Dragan Velikić, oggi ambasciatore della Repubblica di Serbia in Vienna, “All'epoca della mia infanzia, appartenenti a tutte le nazionalità dell'allora Jugoslavia si trasferirono in Istria riempiendo il vuoto demografico che si era creato con l'evacuazione della popolazione italiana dopo la Seconda guerra mondiale, o più precisamente dopo il 1947”.
Nella Fiume del nostro Zandel, passarono da 59.332 abitanti (1940) a 14.500 (1950): altri ancora abbandonarono la città nelle mani dei nuovi occupanti sino al 1955. “Come le case, anche i luoghi di lavoro restarono vacanti. Così il regime, nella necessità stessa di riattivare il porto, il cantiere, la raffineria, le altre fabbriche, favorì in tutti i modi l'emigrazione in città di lavoratori provenienti dall'interno della Jugoslavia, che con Fiume, la sua storia, le sue tradizioni, la sua lingua, non avevano niente a che fare”. Niente a che fare. Niente. Niente. Niente.
**
Entriamo, con Diego Zandel, nel cuore del Villaggio giuliano-dalmata di Roma. Era un'isola. Al di fuori del suo perimetro esisteva un linguaggio diverso, del tutto diverso. E nei primi tempi, guardandosi attorno, da quelle parti “non c'erano case se non, distanti, le mura delle caserme della Cecchignola. Null'altro in mezzo che i prati. La sera li attraversava il suono della tromba militare che annunciava il silenzio. Poi, solo a spostare lo sguardo di un mezzo arco, si vedeva il Monte Cavo con i Castelli Romani sullo sfondo e, più vicino, il castelletto della Cecchignoletta, con la torre merlettata e le mura più basse”.
Si trovava al numero 639 della via Laurentina. Ci si arrivava col bus 223, che partiva dalla Basilica di San Paolo. Zandel ricorda, nell'infanzia, tanta campagna e tante pinete, da quelle parti. “Null'altro c'era intorno. Tra il verde dei pini apparivano, fantasmatici, solitari, gli edifici di quella che doveva essere la mussoliniana E42, l'Esposizione Universale Romana […]. Sorgevano, quegli edifici immensi, bianchissimi nella loro aura futurista, come templi neoclassici precipitosamente abbandonati in mezzo ai campi e ai pini da misteriosi giganti”.
Il Villaggio aveva un ingresso, un largo viale di ghiaia tra due file di pensiline: su di esse s'affacciavano i portoni dei padiglioni: “lunghi falansteri, allineati uno accanto all'altro, dentro ciascuno dei quali era raccolta una media di undici famiglie”. In fondo al viale, una chiesetta sconsacrata. Sarebbe stata dedicata, va da sé, a San Marco.
Soldi e lavoro non ce n'erano. D'estate, per i bambini figli dei profughi, c'erano le colonie dell'Opera Assistenza Profughi Giuliani e Dalmati: tutte in FVG, e con assistenti profughi. “Naturalmente erano facoltative, ma per molti genitori rappresentavano l'unica possibilità economica di vacanza per i figli”.
Comunicare con chi era rimasto indietro – con chi era rimasto a casa – era difficile, nei primi tempi. “Non c'era possibilità di contatto, se non quello epistolare. Lettere che subivano mille ritardi e controlli, dovuti al gelo dei rapporti tra Italia e Jugoslavia. Comunicare per telefono non se ne parlava. Non solo per la rarità dei telefoni pubblici e per le molte linee ancora interrotte. Al Villaggio esisteva un solo telefono pubblico, con tanto di cabina, all'unico bar, il Bar Zara. Mentre Trieste, con il suo Territorio Libero, era ancora in mano agli angloamericani: la rete telefonica trovava lì un'incolmabile soluzione di continuità”.
Da quelle parti era difficile festeggiare il 25 aprile, festa considerata “se non luttuosa almeno ambigua per il prezzo altissimo che la liberazione del Paese aveva fatto pagare interamente ai profughi giuliani: per noi quella non era stata una liberazione, ma l'inizio di una via crucis”. E per questo assurdo e ingiusto sacrificio, i giuliano-dalmati esuli avevano man mano cementato il senso di comunità: era stato questo senso di comunità a dare loro le energie per sopravvivere “alle difficoltà e al dolore dell'esilio”. Questa era la loro – magnifica la definizione di Zandel - “aristocratica diversità”. La ragione è questa: “Perché noi profughi, tutti, per la nostra fedeltà all'Italia e per il nostro sacrificio, ci consideravamo più patrioti di tutti gli altri italiani”.
L'identità giuliano e dalmata, insegna Zandel, “la particolarità soprattutto di essere profughi di Fiume, Pola, Rovigno, Zara, comunque restava viva, incisa nella carne, in testa, nel cuore”. Sempre. Ovunque. Così è stato, e così dev'essere sempre. Ecco perché è stato più che logico e giusto che quando i nostri fratelli nati a Fiume, Pola, Rovigno, Zara, Lussino, Umago e via dicendo, finivano i loro giorni vivendo tanto distanti da casa, nella all'epoca verde campagna romana, si ritrovavano con una bandiera sulla bara: quella della terra originaria. “Tricolore rossa, azzurra e amaranto con l'aquila di Fiume, celeste con la capra dell'Istria, con le tre teste di giaguaro di Zara”. È stato più che logico e giusto, è stato naturale.
Per tutta la vita, i nostri esuli hanno avuto una speranza: tornare a casa. “C'era sempre, sorda, dentro, la speranza: magari in un miracolo, in un ritorno nella loro città. Forse le grandi potenze avevano capito l'errore, i drammi che con le loro risoluzioni avevano procurato”. Sul “Piccolo” di Trieste, Pietro Spirito ha così commentato, nei giorni scorsi: “È una comunità costretta a vivere ripiegata su se stessa, che organizza circoli e luoghi di riunione dove guardare tutti insieme l'unica tv che, e siamo nel '56, annuncia la rivolta di Budapest alimentando la sempre più labile fiammella di un ritorno, se mai il comunismo dovesse cadere. Ma se anche il comunismo non cade, la nostalgia per la terra e gli affetti perduti vince su tutto”.
Vince su tutto. La nostalgia per la terra e gli affetti perduti (casa!) vince su tutto. Ma questo come facciamo a spiegarlo a chi non sa nemmeno chi siamo, Diego? Come facciamo, come facciamo. Facciamo così. Spieghiamo chi erano questi favolosi comunisti che venivano a portare la libertà ai tuoi genitori e ai miei nonni, così magari gli italiani capiscono perché buona parte delle nostre famiglie se ne sono andate. Disperandosi, ma se ne sono andate.
Zandel: “Era cominciato proprio con l'entrata in città dei partigiani di Tito, i druži. La loro presenza non dava tranquillità e sicurezza. La popolazione li viveva come una minaccia. Era gente che veniva da chissà quali parti dei Balcani. La lingua che parlavano, così dura, non era neppure assimilabile al croato, influenzato com'era di influssi veneti, degli slavi che abitavano nei dintorni. E così nei canti, nel tipo di musiche, nei balli, nel cibo, negli odori di questo. Erano diversi, stranieri: in tutto. E davano l'impressione di occupare la città. Non ne erano sicuramente parte. Un'atmosfera ovattata di terrore aleggiava ovunque. Si sapeva di arresti, di sparizioni, di esecuzioni. No, non era quella la Fiume che mamma e papà ricordavano” (pp. 24-25).
Quella gente là ammazzava i partigiani, comunisti come loro, perché erano partigiani italiani. Figuriamoci i borghesi italiani. Questo ai compagni italiani non è mai stato spiegato con la dovuta chiarezza, caro Diego. Mai capito perchè. E non c'è Goli Otok che tenga. Non hanno proprio capito. Non capiranno mai, a questo punto, credo. Non così. Tu in questo libro hai scritto chiaro e tondo che il loro slogan “Morte al fascismo, libertà ai popoli” significava una cosa ben diversa: era un “alibi per piani politici che del fascismo in realtà usavano gli stessi, feroci metodi”. Pensi possa bastare? Dico di no.
**
Zandel: “Il loro obbiettivo era porre il confine addirittura sul fiume Tagliamento, in pratica prendendosi l'intera Venezia Giulia e una parte del Friuli, per cui tutto, anche il mondo nuovo rappresentato dagli ideali socialisti, dei quali i druži si dicevano i portatori, veniva soffocato dalle prevalenti esigenze annessionistiche (purtroppo, tra l'altro, e per un malinteso spirito internazionalista, con la complicità degli stessi comunisti italiani”. Chiamiamola complicità... La storica Elena Aga Rossi, nella prefazione a “Frontiera rossa” di Karlsen, ricorda che “dopo la liberazione del Paese il Pci assistette senza protestare alla eliminazione degli italiani considerati 'fascisti' nelle foibe e nei campi di internamento, e accettò l'interferenza continua di agenti dell'Ozna”: fu soltanto la “aperta frattura” tra Tito e Stalin che spinse il Pci al di fuori di questa supina posizione di accettazione di qualunque violenza fosse commessa nel nome del socialismo. E quando nacque un partito comunista locale, a Trieste, diretto dalla spia Vidali, il Pci cominciò a ricevere i finanziamenti da Mosca, e non più da Belgrado: smarcandosi, finalmente, da una sudditanza incresciosa. Altro che complicità. Dici che così gli italiani capiscono, Diego? Dici che se parliamo così riescono a capire, o almeno finalmente cominciano a ricordare?
**
Prima che il delirio dei nazionalismi devastasse il Novecento, bieca scusa socialista o meno alle spalle, una cosa sapevamo e continuiamo a sapere, come giuliano-dalmati: che la nostra italianità era, prima di tutto, una scelta culturale, non certo soltanto o esclusivamente etnica. La ragione è presto detta, e la spiega bene Zandel: “Gli istriani, i veri istriani erano, e sono, un misto delle tre etnie che, nei secoli, più avevano messo radici nella regione. Questo, sia a dispetto della propaganda tra i profughi, che li voleva italiani, anzi italianissimi, sia a dispetto degli slavi, croati o sloveni che fossero, che a loro volta parlavano degli italiani come occupatori e minoranza”. E già. E più avanti, Zandel conferma: “l'identità nazionale è più il frutto della sorte e della cultura che dell'etnia di appartenenza”. Assolutamente vero. Come scrivi, siamo tutti impastati delle diversità identità che hanno attraversato o attraversano la nostra terra. Ma la patria vera – la lingua che parliamo – abbiamo sempre saputo sceglierla con incredibile naturalezza. Vero? Vero. In un certo senso, non poteva essere altrimenti. In realtà era sia la lingua che la frontiera. Noi eravamo, siamo e torneremo, la frontiera.
Viva Zandel!
EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE
Diego Zandel (Servigliano, 1948), giornalista e scrittore italiano, di sangue istriano, nato in un campo profughi da genitori fiumani. Collabora con «La Gazzetta del Mezzogiorno» e «Il Piccolo».
Diego Zandel, “I testimoni muti. Le foibe, l'esodo, i pregiudizi”, Mursia, Milano 2011.
Approfondimento in rete: WIKI it / La Voce del Popolo / Sito ufficiale di DZ
Gianfranco Franchi, febbraio 2011
Prima pubblicazione: Lankelot.
