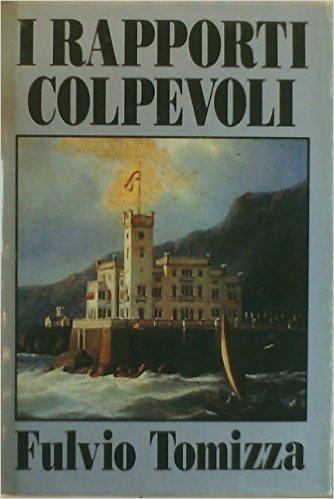 I rapporti colpevoli
I rapporti colpevoli
Bompiani
1993
9788845244360

“Le donne parenti: madre, moglie, figlia. Ovvero i rapporti colpevoli: 'mi devi', 'sei in obbligo di'. Il tossico dell'obbedienza. L'incubo della fedeltà. La schiavitù volontaria (ma perché volontaria?). Prigionia astratta (e perché no vigilata?). Neanche parlare di libertà. Ce l'ho tutta. Chi te la toglie? Chi, solamente, te la limita? Oh, vorrei sparire, che non restasse proprio nulla di me [...]” [Tomizza, “I rapporti colpevoli”, p. 243].
Ventunesimo libro dello scrittore istriano Fulvio Tomizza, triestino d'adozione, “I rapporti colpevoli” è stato pubblicato per la prima volta da Bompiani nel 1993, a breve distanza dal libro-intervista “Destino di frontiera” [Marietti, 1992]. Si tratta di una frammentaria autobiografia romanzata: è un memoir composto da sette diversi capitoli e da una piccola appendice diaristica, sulla falsariga di quella già apparsa, quasi trentacinque anni prima, nell'altro memoir “L'albero dei sogni” [1969].
“I rapporti colpevoli” è un libro di meditazioni e di confessioni; è una profonda immersione nella memoria e nella psiche, e un crudo e dettagliato autodafé. Tomizza, a cinquantasette anni, non ha più bisogno di uno spettro di carta come Stefano Markovic per parlare di sé, dei suoi più segreti stati d'animo e delle sue ossessioni; niente più alter ego. L'artista umaghese si limita a una vaga e fragile dichiarazione di maniera nelle prime battute, quando presenta questo libro come la raccolta dei “sogni” e dei pensieri d'un fratello che se ne è andato. Questo fratello è uno che, proprio come lui, aveva deciso di rovesciare la storia: figlio dell'esodo e della diaspora istroveneta, “s'era ricostruito il suo nido ai margini del villaggio meno frequentato della nostra parrocchia. Là resisteva il paesaggio mai più riassaporato dell'infanzia e dell'adolescenza, un'armonia (quella della stagione piena, imperturbata, dei padri e dei nonni: la nostra selvatica epoca d'oro) in parte sopravvissuta nelle sue diverse componenti” [p. 8].
E cosa aveva fatto, nel villaggio della perduta età dell'oro, Materada? Semplicemente, “sordo soltanto in apparenza alla passività del regime in cui si era incuneato, come pure all'eco di condanna degli esuli istriani che lo vedevano dimostrativamente transfuga, con le sue mani divelse erbe e arbusti nocivi, cancellò muri e siepi divisori, diradò il bosco, risanò gli alberi fruttiferi, ne mise a dimora di nuovi, fece da manovale a muratori, falegnami, fabbri che con difficoltà era riuscito a ingaggiare”. Fatto questo, si costruì uno studio, nel sottotetto, per leggere e scrivere – e in quel rifugio lavorò ad almeno dieci libri, negli anni.
Cosa aveva fatto, insomma, Tomizza? Aveva cercato di dare l'esempio - l'esempio del ritorno – a un popolo che non intendeva più tornare indietro, magari perché ferito e umiliato da quanto accaduto soltanto pochi anni prima; vale a dire, dalla drammatica damnatio memoriae, opportunistica e ideologica, della propria storia e della propria essenza; dalle ripetute incomprensioni dei concittadini italiani, e dei partiti italiani.
Un popolo che non intendeva più tornare indietro, anche, perché ostile, con orgoglio, al regime socialista titino, che s'era macchiato, nel tempo, e sin dai giorni partigiani, di azioni d'una cattiveria immotivata e incancellabile, e non solo a danno degli istroveneti. Un popolo ostile al regime socialista titino, e soprattutto a quegli istroveneti “rimasti”, considerati alla stregua di traditori dei loro fratelli, per ragioni facilmente decifrabili; almeno, tendenzialmente.
Tomizza aveva cercato di dimostrare, agli istriani esuli, che era possibile tornare indietro e fare come gli antenati; vale a dire, vivere sotto una bandiera straniera per il tempo necessario a vederla ammainare e subito sostituire da un'altra. Aveva cercato di dimostrare che un intellettuale doveva e poteva tornare alla terra. Perché la terra era fondamentale. Niente: invano.
“Mi vedo (e quasi posso toccarmi) testimone di questo mondo ormai in agonia. Avverto la piena consapevolezza di questo attimo pieno, come un solenne presentimento di morte. Ecco perché sono tornato: per quest'ultima testimonianza, che però esigeva la completa partecipazione, la totale rinuncia, il lasciarmi coinvolgere fino alla mia stessa agonia. Forse sono stato come pochi fedele al mio mondo, coerente con me stesso” [p. 239], scrive Tomizza.
E in questo contesto, lo scrittore umaghese medita il suicidio finendo per considerarlo chiaramente allegorico. E “I rapporti colpevoli” diventa, a un tratto e incontrovertibilmente, un libro di ossessiva meditazione sul suicidio. Apparentemente è la smania suicida di uno scrittore che sta invecchiando, e da tempo ha smesso di scrivere libri memorabili. In realtà, probabilmente, è la coscienza del suicidio di un popolo, che esodando – pur di non vivere sotto regime jugoslavo; pur di non vivere sotto socialismo – si è disperso, si è infine umiliato e autodistrutto, imprigionandosi in un eterno rimpianto di qualcosa di irripetibile. Di irrimediabilmente andato.
Che il pensiero del suicidio sia legato, in Tomizza, alle sorti del suo popolo, e della sua famiglia, diventa chiaro quando l'artista racconta la “prima volta”: la prima epifania della voglia di ammazzarsi. Siamo negli anni del Territorio Libero di Trieste, poco dopo la seconda guerra mondiale:
“Sui quindici anni, abbandonato il liceo di Capodistria, gestivo coi genitori un bar nella Trieste governata dagli angloamericani. La madre si ammazzava di fatica, come ai tempi d'oro, dietro a un banco per il quale però non era tagliata; il padre faceva il signore intrattenendo i clienti seduto al loro tavolo; io, piantata la scuola col beneplacito dei genitori, non ne potevo più dalla spossatezza, il senso di soffocamento, la mancanza di qualunque prospettiva, le umiliazioni da parte di gentucola, le liti in famiglia. Un pomeriggio mi levai il grembiule, mi liberai del camiciotto bianco, li scaraventai a terra e corsi fuori, deciso a buttarmi nel canale del Ponterosso in panni comuni. Mio padre m'inseguì, mi raggiunse, mi abbracciò smorto in viso dal terrore. Quella sua resa tenera mi fece toccare una dolcezza mai provata […]. La tentazione di farla finita mi accompagnò, sempre, quale ripiego estremo per uscire da una situazione insostenibile. Riemerse, si tenne pronta, quando perdetti il padre” [p. 222].
La tentazione riemerge e Tomizza ne parla con crudezza. “Da anni ormai, al di fuori di ogni speculazione letteraria, mi stavo intimando in dialetto 'Mori, mori', come passando davanti a un capoccia gli si manda a dire: crepa. Ero dunque principalmente io ad avercela con me, a non sopportare di vedermi vivo” [p. 231]. E nella lugubre fantasia di questo libro finisce per riuscire nell'impresa: si suicida dopo essersi seduto, simbolicamente, “alla tavola di pietra del frantoio per le olive dei miei avi” [p. 232]. Si suicida dopo aver scritto che la sua è stata un'agonia intermittente. E l'allegoria è abbastanza chiara: “Mi trovavo come sempre in una terra di nessuno, adesso allargata a entrambi i territori ricompostisi dentro di me e ugualmente non invitanti. Il mio nuovo confine era collocato in verticale e una fitta nebbia ne nascondeva il valico” [p. 233].
**
Tomizza, insomma, sembrava decisamente cosciente di poter essere un simbolo del suo popolo; e forse sperava che, confidando nel suo esempio, tutti e trecentomila, o trecentocinquantamila, gli istriani esodati, con i figli e magari i nipoti, tornassero indietro; tornassero indietro tornando a lavorare la terra, tornando nelle case di pietra, tornando nei borghi veneti, sul mare, tornando tra le antiche rovine Romane. Tomizza sognava che si potesse, tornando indietro, restituire vita a quella civiltà, marinara e contadina, che aveva dato prova di umiltà, di verità e di sacrificio per millenni; e di solidarietà, perché aveva saputo far coesistere la cultura maggioritaria, quella veneta, quella d'ascendenza latina, con quelle slave, minoritarie e forse meno affascinanti, certamente meno gloriose. Tomizza, forse, infine pensava che il sacrificio di uno potesse cancellare le colpe di tutti i popoli; oppure, semplicemente, che fosse possibile, ripartendo dalla letteratura, restituire vita a quel che era perduto. Questo è davvero il sogno più grande di tutti.
**
C'è altro. Ci sono descrizioni della moglie, Ester – già “Miriam”, nella narrativa di FT – e tante cose già lette, sulla sua fedeltà, la sua generosità, la sua educazione, il suo ebraismo; ci sono notevoli descrizioni dei nonni istriani, particolarmente di chi era rimasto a vivere in Istria nonostante il socialismo, nonostante l'esodo di tanti fratelli, nonostante tutto; e ci sono memorie – ancora – dell'avvilimento e del dolore provato, con abnorme intensità, per gli ingiusti processi subiti dal padre in vita, sempre sotto regime titino. Ma stavolta, a differenza del passato, Tomizza esplicita, a un tratto, le ragioni della sua altrimenti incomprensibile successiva adesione a quel regime, almeno in età giovanile: lo contrastava, in realtà, scrive, e insieme vi aderiva: ma faceva questo per vendicare suo padre, “riscattare mia madre e l'intero paese abbrutito: ad ogni modo per farmi male” [p. 150].
Forse, con tanta chiarezza, questo aspetto non era apparso mai nella letteratura del papà di “Materada”. Ci si accorge infine che il vero rapporto colpevole era quello tra Tomizza e la sua storia: la storia d'un popolo distrutto. Incapace di liberarlo dal male, l'artista invecchiava con enorme amarezza – l'amore della moglie e della figlia non bastava a sedare i suoi rimpianti, e non mitigava nemmeno la dolorosa coscienza d'un fallimento imprevisto, ma totale. Esisteva un posto dove tornare, ma non c'era più nessuno, tutto a un tratto. Soltanto ricordi. Come pietre.
EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE
Fulvio Tomizza (Giurizzani di Materada, frazione di Umago, Istria, Italia; 1935 – Trieste, FV-Giulia, Italia, 1999), scrittore e giornalista istriano. Esordì, come narratore, pubblicando “Materada” nel 1960.
Fulvio Tomizza, “I rapporti colpevoli”, Bompiani, Milano 2009. ISBN, 9788845244360.
Prima edizione: 1992.
Approfondimento in rete: WIKI it
Gianfranco Franchi, maggio 2012.
Prima pubblicazione: Lankelot.
Frammentaria autobiografia romanzata: è un memoir composto da sette diversi capitoli e da una piccola appendice diaristica,
