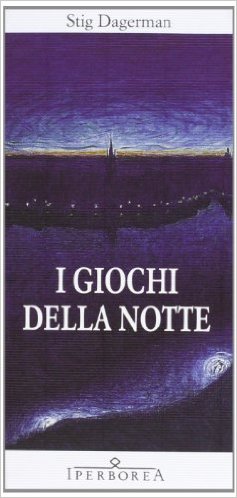 I giochi della notte
I giochi della notte
Iperborea
2011
9788870910599

“Dagerman è vertiginoso. Ha una verticalità perentoria che si aggancia ai moti ineffabili, oscuri dell’essere. Riesce a oggettivare un proprio disagio esistenziale con una spietatezza assoluta e irrevocabile. Scrivere è infondersi nei luoghi più ottenebrati dello spirito, è far cadere le parole, la verità delle parole, dietro il volto, la rappresentazione di una figura: quella del vecchio nonno, di un bambino – dietro la sagoma di un uomo sconosciuto o di un amico tradito. Tutto ciò che Dagerman racconta è vero, non abbiamo mai per un solo momento l’idea che ci sia qualcosa di inventato o di non reale” (Andrea Gibellini, “Introduzione”, p. 9). Piuttosto: il fallimento delle interazioni con l’alterità e la disfatta d’una lacerante tensione comunicativa d’ogni personaggio sono così sistematici, negli otto racconti che compongono questo “I giochi della notte”, da sembrare irreali. Perché patologici. L’archetipo del protagonista delle storie di Dagerman è quello d’un irrisolto egoarca, che sembra andare oscillando tra una blanda (ma nervosa) ricerca di comprensione, partecipazione e ascolto (in due parole: testimonianza, riconoscimento) ed una rovinosa e inconsolabile ritirata in se stesso. L’io è il rifugio: l’io è l’origine del male. Perché è l’io d’un genio della sofferenza o perché è l’io d’un essere (dis- , o sovra-) umano estraneo alla sua specie?
Il drammatico epilogo dell’esistenza di Dagerman – suicida appena trentunenne, nel 1954 – e il suo superbo stile (asciutto e incisivo), condizionano l’interpretazione e suggeriscono d’evitare risposte. È un libro che serve a domandarsi se ha senso comunicare (e quindi: vivere) in un microcosmo sociale che si avverte estraneo e asfittico o freddo e aggressivo. Quindi è un libro-chiave: e non solo per i cultori dell’opera del genio di “Bambino bruciato”.
OSSERVAZIONI, LETTURE, CAMPIONATURE
“Lo sconosciuto”, quinto racconto contenuto nel libro, è la parabola d’una scissione d’un’identità: perduta l’immagine di sé, il protagonista ha conquistato (finalmente, ma non senza dolore) l’estraneità a tutto quel che è stato: l’aberrazione paranoica trascina una mente lucida fino al conflitto con l’ultimo – forse l’unico, autentico – nemico: se stesso.
Il testo paradigmatico dico sia questo: storia d’una coppia che, in una sera che precede un temporale, adatta a scrivere lettere “serene e tranquille su piccole cose” o a guardare fotografie, rovesciando uno scatolone sul tavolo, si ritrova a fronteggiare un passato che, progressivamente, il protagonista s’accorge non essergli appartenuto mai. Dapprima non riconosce oggetti: quindi, ambienti o sfondi: infine – ecco l’amaro e preteso sapore della resa – se stesso.
La moglie, dapprima incredula, è sconvolta. Dagerman, magistralmente, giostra prima e terza persona. Io è un altro. L’abisso è seducente: “Ammettiamo pure che è imbarazzante che la memoria mi tradisca a proposito di avvenimenti passati ai quali anch’io ho partecipato, pensa, ma che non mi ricordi cose che non ho vissuto personalmente, questo non me lo si può certo rimproverare. Prova un violento rancore verso la moglie che gli è seduta di fronte in assoluto silenzio e gli estorce vergogna e paura. Con un gesto spazientito le getta la foto con lo sconosciuto, quel perfetto estraneo il cui volto illuminato dal sole non risveglia in lui il benché minimo ricordo” (“Lo sconosciuto”, p. 81).
La moglie estorce vergogna e paura: conosce una verità che l’io scisso non può più condividere (piuttosto pensa di non averla condivisa mai). Il protagonista non riconosce la compagna di vita e le scaraventa – aggressività puramente paranoide, ecco qui – addosso lo strumento dell’offesa al suo (critico) neo-equilibrio: una fotografia. La vendetta sarà abnorme: soltanto quando accetterà l’idea che quell’uomo sia uno sconosciuto, allora capirà che deve assassinarlo. Lo ucciderà nel sonno, stringendo “spasmodicamente” un martello e colpendo alla tempia.
“Nevischio”, il secondo racconto, è una tragica parabola dell’incomunicabilità: ambientato in uno scenario rurale, in un contesto famigliare poverissimo e corroso da un amore proibito, gioca sull’alternanza tra l’esperienza e la radicalità dell’antico capofamiglia, il nonno, e l’innocenza e la purezza del nipotino, orfano di padre. S’attende l’arrivo d’una zia, reduce da insperate fortune negli Stati Uniti: non vede il vecchio patriarca da venti anni – lui s’è convinto che lei si vergogni delle sue radici, e che rifiuti la sua origine.
Per inciso, la stessa negativa percezione della progressiva americanizzazione degli svedesi, e delle sue conseguenze si respirerà, in altro contesto, nell’ultimo racconto, “La torre e la fonte”: non per gretto conservatorismo, o per amore della tradizione; ma per riconoscimento d’artificialità e di grossolanità, di sfortunata metamorfosi, di degenerazione dello spirito d’un popolo nell’emulazione di quel che non potrà essere mai.
In “Nevischio”, il legame di sangue che pure vincolava indissolubilmente i vecchi fratelli sembra non essere più sufficiente: lei parla una lingua nuova, che nemmeno il nipotino riesce a intendere; le reciproche manifestazioni d’affetto e di rispetto cadono nel vuoto. C’è un divario incolmabile che nessuna parola potrà colmare. Il lettore non comprende dove sia il regresso, e dove il progresso: in nessuno dei due modelli proposti. Ci si accorge del distacco e della distanza: la vittima princeps è la sensibilità e l’innocenza e la fiducia nel prossimo del bambino.
“La torre e la fonte”, invece, tragicomica vicenda di umiliazione del passato – una vecchia guida – e di indifferenza del nuovo, e americanoide presente – una comitiva di studentelli – mostra diverso sbilanciamento.
Dagerman si concentra, fondamentalmente, sulla sofferenza e sull’estraniamento (diremmo: sull’acquisizione della coscienza del distacco) del vecchio: sulla sua accettazione della sconfitta, che sembra – sottotraccia – essere non più madre di lamenti e sospiri, ma di segreta e sordida soddisfazione. L’alterità, in generale, è quella prepotente e arrogante e insensibile protagonista del racconto “Gli implacabili”: un’umanità che l’artista rifiuta e repelle con tutta l’anima.
Opportuno, tuttavia, per restar fedeli all’egocentrica architettura del testo, campionare l’epilogo della sconfitta del vecchio: “Quando non si sentì più nessuna voce ridiscese lentamente e con mitezza e si sedette ai piedi della scala, senza nessun pensiero particolare, senza nessuna rabbia particolare. Non provava più niente. Non pensava più a niente. Neppure alla fonte. Si limitava a star lì seduto, ora dopo ora, o magari anche anno luce dopo anno luce, pervaso da una crescente stanchezza. La stanchezza va molto bene, la stanchezza va sempre bene, in particolare quando ci si esercita nell’arte amara di essere prigionieri di se stessi. Anche una grande calma e una certa capacità di mantenersi freddi vanno molto bene, perché l’uomo deve avere i nervi molto saldi per potersi sopportare” (“La torre e la fonte”, p. 157).
Nervi molto saldi per potersi sopportare: e grande fantasia e immensa immaginazione per poter sopportare il prossimo. Con drammatica difficoltà, quando si tratta d’un genitore. È il caso di quanto avviene nel racconto eponimo, “I giochi della notte”: un bambino soffre indicibilmente per l’alcolismo del padre. Non sopporta più la disperazione della madre, e allora quando s’accorge della sua tristezza, di sera, immagina d’essere invisibile e di poter andare dove vuole, solo con la forza e con la volontà del suo pensiero.
Si ritrova in un locale, e va a perforare il fondo d’una bottiglia d’acquavite; suo padre, barcollando, va verso l’uscita; ma non esce mai. L’attesa è sempre vana – l’immaginazione è soltanto consolazione. È dolcissima e commovente l’estenuata adesione del bambino al sogno, e all’irrealtà: e cupa e degradante la rappresentazione della debolezza del padre, prigioniero d’un vizio assurdo che uccide la sua famiglia.
Lascio allora che descriva questo bambino chi ha inteso e compreso lo spirito delle opere di Dagerman, il giovane letterato Simone Buttazzi: “Un bambino è una falena. Che, fuoco nonostante, è destinata a bruciarsi per curiosità, fame di conoscenza. Coerenza. Il fuoco è più di un canto di sirena: è un imperativo categorico. Non un capriccio, né una debolezza. Bruciarsi significa interiorizzarlo, più che esserne puniti”. (la fine d’una strada è la negazione del sogno: ecce infanzia – crepitare nel fuoco della realtà).
EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE
Stig Dagerman (Älvkarleby, 1923 – Stoccolma, 1954), scrittore, poeta, saggista, sceneggiatore svedese. Diresse “Storm”, giornale della gioventù anarchica. Debuttò pubblicando il romanzo “Il serpente” nel 1945.
Stig Dagerman, “I giochi della notte”, Iperborea, Milano 1996. Traduzione di Carmen Giorgetti Cima. Introduzione di Andrea Gibellini.
Prima edizione: “Nattens lekar”, Stoccolma, 1947.
Gianfranco Franchi, febbraio 2005.
Prima pubblicazione: Lankelot.
