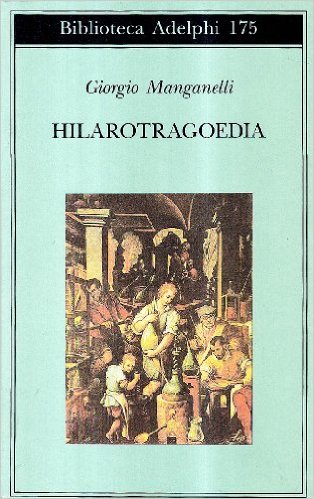 Hilarotragoedia
Hilarotragoedia
Adelphi
1987
9788845902291

“Prigione, donna infedele, sedia sfatta: lì abita l'imperfetta divinità, o forse la perfettissima a noi accessibile” (p. 47). Perché la divinità ingannevole, insegnava l'artista, è l'unica possibile, capricciosa com'è, e sleale, incostante; “occorre la sevizia a fare un dio”, servono esercizi periodici di insonnia e di sperma. Sperma?
Questo libro potrebbe essere, come vedremo, un disperato tentativo di evocare una divinità (non “la”: “la” divinità è il Verbo, e qui è presente e idolatrato); è una speranza flebile, perché l'impressione è che Manganelli ci abbia sottoposto una solenne, magistrale presa per i fondelli, fracassando ogni pretesa di linearità, di raziocinio, di leggibilità; deviando da qualsiasi vagula (blandula) idea di struttura; deragliando dalla lucidità, come niente fosse. Ha giocato a fare Letteratura sulla propria pelle: ha giocato a fare Letteratura della propria vita: ha giocato a fare Letteratura della propria pazzia. È riuscito nell'impresa.
1964. Opera prima di Giorgio Manganelli, letterato lombardo classe 1922, scomparso a Roma nel 1990, “Hilarotragoedia” (una “favola iraconda”, completa di “trattato sulle angosce” e “inserto sugli addii”, se è una struttura dichiarata quella che cercate), delirante, erudito, sperimentale e sguaiato esercizio di stile, venne probabilmente ideato nei tardi anni Quaranta, mentre l'artista combatteva contro la malattia mentale. Si sente. Nell'opera, l'autore parla di un periodo in cui la sua vita si riposa in una breve, rovinosa chiarezza; adesso può redigerne uno “stenografico rendiconto” (p. 101). Curiosa disciplina davvero, la stenografia, non trovate? Chi l'avrebbe mai detto.
“La letteratura” - scrive Calasso nella bandella - “è qui eredità sciamanica, dove al tamburo si sostituisce l'esercizio retorico. Ma il viaggio, il rischio, l'ombra, le voci: tutto questo corrisponde”. Sì – assieme a qualche stravagante latina occupatio, come quando Manganelli asserisce d'avere in odio le nasali lamentazioni autobiografiche e i “corrucci lirici e allusivi”, salvo poi ammettere d'essere pronto a indulgervi per “custodirne la qualità testimoniale”. Perché questo, a ben guardare, altro non è che un torrenziale quaderno di narrativa egoica, egolatrica ed egoarchica: un romanzo d'un pensiero andato in cortocircuito, e in disperata ricerca di senso, di equilibrio, di disciplina.
È un libro d'amore e d'abbandono: di pretesa di una simbolica discesa, a strapiombo, nell'essenza; nell'essenza del linguaggio, nella natura dei sentimenti, nell'Ade che ognuno di noi incarna.
Discendere – verbo che pare “disadorno, povero e frusto: sa di cosa opacata dall'uso, o vestito affranto e liso” – è il termine fondamentale dell'opera: “vocazione discenditiva” ha il corpo umano, “natura discenditiva” ha l'uomo. “La tua vocazione al precipizio” - scrive Manganelli – “non è rinunciante o censurabile: ma riposata, saggia, onestissima; solenne anche, giacché tutta una vita occorre alla consumazione della gran caduta; et anche: rationalissima” (p. 12). Tutta una vita, sin quando non si conquista l'agognato, arcano Ade.
Precipitare “è verbo che ha più del cittadino, del meccanico; descrive scia di fulminose membra per aria asciutta; o furibondo ammusare di aereo, cui scappa la morte. Femmina litigiosa, femmina illusa, disillusa, delusa sventola ruota di sbandierante gonna, all'assalto; sboccia in crisantemo di sé; sul marciapiede si spiega, si ripiega, si disfa” (p. 17).
Manganelli sprofonda nell'esame dell'angoscia; ne distingue tre tipi. Quella titillante, quella disruptiva, quella conclusiva o estatica (p. 39). Quindi tocca a un inserto sugli addii: estrinseco, intrinseco, proiettante. Per ogni amore un addio diverso, per ogni angoscia un contesto diverso. Ma la sensazione è che Manganelli avesse una gran voglia di giostrare, funambolico, aggettivi e verbi a tutto spiano, per dipingere qualcosa di astratto con colori vivi, e forti; che volesse liberarsi dal male, che volesse disarcionarlo, e nominandolo esorcizzarlo; che avesse desiderio di fronteggiare il “non è”, e di fingere questo niente potesse essere – paradossalmente – meno vago; infine, che ambisse a fondere nel suo italiano assolutamente, esclusivamente letterario elementi latini e greci, stabilendo le premesse per un dialogo tra pochi e per pochi. Ci piace, ma irrita la palude dei lettori medi; peccato (per loro). A me sta bene.
**
No, non siamo dalle parti dell'opera immortale, né del libro necessario. Negli anni, nel tempo, ho incontrato un Manganelli capace di chiarezza esemplare, come narratore e come critico; una chiarezza non estranea alla ricercatezza, alla fantasia e all'esibizione di talento linguistico e letterario: non è il Manganelli della sua opera prima. In questo frangente l'artista, giovane, si sbizzarrisce e si lascia andare, sperimenta e provoca, è blasfemo e coprolalico, è intenso e irrequieto, è preda facile dell'aggettivazione abnorme, e d'un periodare bizantino, personalissimo. Ti innamori di certi passi, di certe frasi, di certe scelte lessicali; vorresti questo libro fosse composto soltanto da frammenti, come certe opere monumentali dell'antichità di cui rimangono pochi versi, e quei versi oggi studiamo, fantasticando sul resto. Ecco, è meglio fantasticare, magari partendo da qui: “Ma tu, con distacco, voce colta e modulata, cravatta socievolissima, sorridendo, annotando, festoso precipiti”... e finendo per sognare. Sognare, punto: magari, delirando.
EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE
Giorgio Manganelli (Milano, 1922 – Roma, 1990), narratore, critico, traduttore, giornalista e saggista italiano. Si laureò in Lettere presso l'Università di Pavia; fu consulente editoriale Adelphi, Einaudi, Mondadori.
Giorgio Manganelli, “Hilarotragoedia”, Adelphi, Milano 1987. Collana “Biblioteca Adelphi”, 175. Bandella di GM.
Prima edizione: Feltrinelli, 1964.
Gianfranco Franchi, luglio 2009.
Prima pubblicazione: Lankelot.
