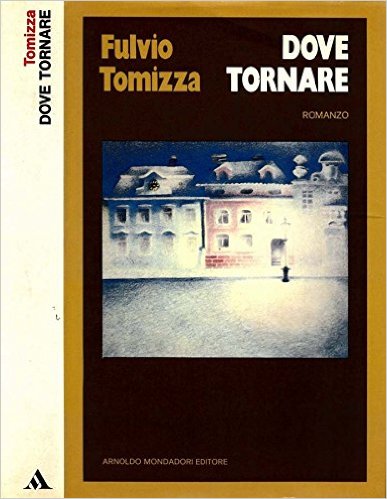 Dove tornare
Dove tornare
Mondadori
1974
9788804115670

1974. Trentanovenne, lo scrittore umaghese Fulvio Tomizza pubblica il suo ottavo libro di narrativa, sempre per Mondadori; si chiama “Dove tornare” ed è un quaderno di scritti di vario argomento, meno compatto e uniforme di quanto si poteva aspettare e sperare, con un titolo del genere. Torna la musa di Stefano Markovich, l'alter ego dell'artista: ma stavolta è soltanto lei, Miriam, a venire nominata. Stefano coincide con Tomizza, senza nessuna scatola cinese, senza nessun gioco di specchi. In questo senso, il libro può essere considerato il quarto della serie dedicata a Stefano Markovich – la sequenza completa è “La quinta stagione” [1965], “L'albero dei sogni” [1969], “La città di Miriam” [1972].
Il narratore di “Dove tornare” è un artista che vagheggia “un socialismo davvero libero e civile, di reciproco rispetto e disincantata fraternità”, consapevole com'è che il socialismo può trovare “il suo coronamento nel procedere abbracciati in una parca festa, nell'unirsi al coro improvvisatorsi intorno a un chiosco durante il primo maggio o a un festival della gioventù […]. Sono momenti di gioia trepida, insicura, che necessita dell'appoggio e del concorso altrui, come del resto avviene per la stessa fede, la decisione, la protesta” [p. 34]. Ma questo suo socialismo è molto letterario e poco ortodosso; sembra più un'inclinazione spirituale che una fede politica. Sembra più una giustificazione della bontà dell'autore che una dichiarazione d'appartenenza partitica.
**
Il libro è diviso in quattro parti: “La guida di Praga”, “L'amico di Roma”, “Piccola pietà” e “La casa in campagna”. È strutturato come una lunga lettera, a metà strada tra un diario e un reportage. L'artista scrive a chi una volta l'ha chiamato “anima gemella”. È una professoressa boema, cattolica, “dissidente”. Una donna piena di speranza e di gentilezza. Non un'amante – diciamo un'amante mancata.
Nella prima lettera, lui le racconta le sue giornate praghesi, poco dopo la sconfitta del grande sogno di Dubček, e sintetizza la sua esperienza da ospite d'una città un tempo grande e in quell'epoca ferita dal “povero, goffo, ingenuo, umano mondo comunista” [p. 21]. Tomizza ha la responsabilità estetica di ritrovarsi, da triestino d'adozione, laddove il giovane istro-triestino Giani Stuparich aveva studiato e insegnato, salvo essere dimenticato dai praghesi, nonostante il suo brillante saggio “La nazione ceca” e il suo amore per la loro cultura e la loro storia. Nella terra di Kafka, e del giovane Kundera, Tomizza s'accorge che la città di Praga “sembra vegliare se stessa. Al suo sottile veleno (autodistruzione e autoespiazione) ogni giovane d'Europa avrebbe venduto l'anima” [p. 36]. Lo scrittore umaghese, l'anima sensibile alle utopie del socialismo e alle romantiche sirene del panslavismo, dipinge una realtà meno disastrosa di quel che doveva essere. Forse, culturalmente, Tomizza era più adatto a raccontare gli slovacchi – nelle ultime battute della sua lettera restituisce qualche ricordo di Bratislava e della sua gente che sembra più fedele alla sua primitiva e orgogliosa istrianità. Naturalmente è solo una sensazione.
Nella terza lettera, Tomizza racconta del ragazzo istriano che s'era dato fuoco, proprio come Jan Palach, nel Giardino Pubblico, a Trieste, lasciando un appello per una maggiore libertà e giustizia tra gli uomini. Diciottenne, orfano di padre, esule con la mamma e due fratelli, cresciuto tra istituti, orfanotrofi [già...] e collegi di vario genere, Ottavio è uno che istantaneamente sembra famigliare al buon Tomizza; perché viene dalla sua stessa campagna mistilingue istriana, fraintesa ed equivocata da tanti. Tomizza racconta della tenera amicizia che nasce col ragazzo istriano moribondo, e di come essa diventi man mano centrale nella sua vita, nel periodo delle sue ultime sofferenze; di quanto quotidiano diventi il pensiero del povero Ottavio, nei giorni del suo viaggio in Terra Santa, con Miriam, e di quanto doloroso finisca per essere il distacco.
Nella seconda lettera, “L'amico di Roma”, leggiamo la storia d'un sodalizio letterario ed editoriale vissuto quasi come un rapporto tra padre e figlio, con grande e forse eccessiva reverenza, e autentico rispetto. Un rispetto così grande che forse non aveva ragione di esistere; perché magari quel sodalizio era vissuto con intensità così forte soltanto da una parte.
Tomizza racconta di un suo amico letterato romano, Niccolò Gallo, schivo, comunista. E molto benestante, carismatico e influente. Lettore fortissimo, elegante, d'aspetto vagamente simile a Vittorini, è uno dei grandi punti di riferimento dell'artista padre di “Materada”, e suo primo, fondamentale editor. Tomizza racconta la loro amicizia e una sua visita a Trieste – della città di Magris, l'umaghese sceglie di mostrare “gli angoli più intimamente parlanti perché meno noti, gli itinerari cari a Svevo e a Saba, la curva di Contovello o non piuttosto il cocuzzolo di Conconello da cui abbracciare l'intero panorama fino all'Istria, i ristoranti meno turistici sulle rive” [p. 60].
Il letterato suo ospite finisce poi per sconfinare in Istria, per andare a omaggiare le terre raccontate da Tomizza, ma con sua discreta sorpresa s'accorge che Materada non è altro che una piccolissima frazione della già piccola Umago – tanto che nemmeno è sicuro d'averne riconosciute le case – e poi di lì scende per Parenzo e Pisino, prima di tornare indietro. Passa del tempo, e la loro dialettica procede tra alti e bassi, sempre più frequenti; Tomizza sembra confondere la cordialità e la gentilezza del letterato romano per vera amicizia: e così, è soltanto la morte di lui a restituirgli il senso delle proporzioni, e a farlo meditare sulla vera natura del loro rapporto, con crudele lucidità: “Rappresentavo per lui non più di una conoscenza, magari stimata, gradita, ma facilmente sommersa da decenni di sodalizio assiduo con altri […]. Il patetico ricorrere a lui col pensiero quasi in ogni ora per sciogliere un dubbio, accertare una speranza, dissipare un malumore […] era un fatto soltanto mio, e riguardava me solo. Dipendeva da una sete di totalità e insieme dalla costante necessità di un'approvazione superiore, e s'iscriveva forse nel destino di una città troppo lontana e troppo a lungo rimasta sola” [p. 85].
Nella quarta lettera, infine, Tomizza racconta della casetta di campagna – nella prima abbiamo letto che era stata “finita da tempo”, e che l'artista, assieme alla sua Miriam, ci aveva già passato un'estate. È proprio da là che scrive le sue lettere, “riposando lo sguardo su un grande gelso, un'aia con erba scomposta e spini secchi, più avanti un appezzamento di terra rossa tra ulivi, seduto a una finestra” [p. 10]. Miriam, signora di città, borghese, per quelle campagne e quelle viottole si perde facilmente. Ma per lui quella è casa – la casa in assoluto. Lui ama quella “povertà appartata ma tutta aperta alla luce e perciò decorosa; ben si adattava all'umiltà del mio desiderio d'isolamento e alla discrezione che doveva accompagnare l'eventuale ritorno” [p. 148].
La meraviglia è che sembra essersi fermato il tempo, dai giorni dell'infanzia e dell'adolescenza, dai giorni dell'esodo. L'aria è pulita e il verde selvatico, il cielo terso e i rumori diversi e nitidi - non sono soltanto quelli delle auto e degli aerei: è la natura che domina. A Tomizza piaceva, nella sua nuova vecchia terra, lavorare e “spiare le nuvole, fiutare il corso dei venti che le sospingevano” [p. 178]. E che emozione tornare a sentir messa nella Chiesa eretta, nel Seicento, dal capostipite della sua famiglia. Ma a qualcuno in paese non andava giù, quel ritorno. Non sembrava normale, non sembrava naturale. E così, l'artista si ritrova in commissariato, a dover spiegare a un imbarazzato inquirente cos'era venuto a fare nella terra dei suoi antenati. “La mia presenza dava fastidio o semplicemente sollevava sospetti in alcune persone del paese. Non si riusciva a comprenderla e un po' strideva, ecco tutto. Certamente erano venuti a lamentarsene, o loro avevano i debiti informatori chiamati ogni tanto a fare il punto della situazione locale” [p. 185].
La morale della favola è che forse, per Tomizza, non esiste più la terra in cui tornare – perché è passato del tempo e molte cose sono accadute, e altre sono state dimenticate, e l'esodo non è stato perdonato da chi è rimasto, e nemmeno chi se ne è andato ha perdonato chi è rimasto. L'unica radice dell'artista, adesso, è la moglie. Sua speranza, sua forza, suo bene.
Secondo Mario Petrucciani, “il titolo del romanzo-confessione è stato interpretato dai più come un cartello segnaletico di tutta la sua narrativa: un viaggio di ritorno – 'nostos', dicevano i greci, da cui 'nostalgia' – verso il paese dei padri nell'Istria più appartata e segreta. Anzi neppure un paese, ma una parrocchia, perché in quei posti, ha osservato lo scrittore in una recente intervista, 'la chiesa riassume in sé le funzioni essenziali di una civiltà contadina': la piccola parrocchia di Materada, fatta di frazioni sparse tra gli alberi, di cantine, di spiazzi erbosi, di pietra: dunque un paese, come concluse Niccolò Gallo dopo esserci stato, che di fatto non esisteva. Ma è un'interpretazione parziale, anche un po' equivoca, che può portare su una pista fuorviante […]”, medita il critico.
E più avanti: “Nel lessico di Tomizza 'tornare' non equivale propriamente a nostalgia, non significa semplicemente rivistare la musica elegiaca dell'infanzia felice e della casa perduta, e quindi arrendersi alla solipsistica dilettazione del patetico. L'operazione di Tomizza si configura ma si coniuga solo in parte come una 'ricerca del tempo perduto', è piuttosto una reinvenzione strutturale del grande archetipo del viaggio come 'ricerca della propria identità', il viaggio della conoscenza di sé e del mondo, e insieme il viaggio della coscienza problematica. Non c'è ritorno se non nel rapporto interiore con il trauma iniziale, con lo strappo della partenza: per ritrovarsi faccia con i sogni, le allucinazioni […]. Il viaggio è così diventato verticale, verso l'io profondo, le memorie del sottosuolo: dunque verso l'inconscio” [tratto dall'introduzione a “L'albero dei sogni”, Mondadori, 1977]. Quella di Petrucciani è un'ipotesi forse fantasiosa – perché la realtà era probabilmente molto più semplice – ma comunque fertile di meditazione. E meditando, allora, chiudo la mia pagina.
EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE
Fulvio Tomizza (Giurizzani di Materada, frazione di Umago, Istria, Italia; 1935 – Trieste, FV-Giulia, Italia, 1999), scrittore e giornalista istriano. Esordì, come narratore, pubblicando “Materada” nel 1960.
Fulvio Tomizza, “Dove tornare”, Mondadori, Milano 1974.
Prima edizione: Mondadori, 1974.
Gianfranco Franchi, aprile 2012.
Prima pubblicazione: Lankelot.
Quaderno di scritti di vario argomento, meno compatto e uniforme di quanto si poteva aspettare e sperare, con un titolo del genere…
