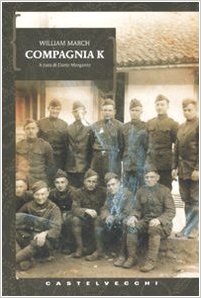 Compagnia K
Compagnia K
Castelvecchi
2010
9788876154027

“Restammo sulle rive della Mosella per dodici deliziosi giorni e poi, con gran dispiacere, sgomberammo. Ma avevamo imparato tutti una cosa: se i comuni soldati di qualsiasi esercito potessero riunirsi sulla riva di un fiume e discutere le cose con calma, nessuna guerra durerebbe più di una settimana” (William March, “Compagnia K”, frammento del soldato semplice Plez Yancey, p. 92).
A quasi quarantacinque anni dall'ultima edizione (Longanesi, 1967), torna nelle librerie italiane, nella datata ma felice traduzione di Adriana Pellegrini, “Compagnia K” (già noto come “Fuoco!”) dello scrittore statunitense William March, socialista, reduce dalla Prima Guerra Mondiale. La nuova edizione (Castelvecchi, 2010) include – unica differenza con la prima – un'appassionata introduzione di Dario Morgante. In ogni caso, era semplicemente fondamentale che questo libro tornasse a disposizione di tutti i cittadini, a un prezzo accessibile (16 euro): va bene così. Perché “Company K” (1933) è la Spoon River narrativa di tutta una serie di reduci della Grande Guerra, soldati e ufficiali, di diverse convinzioni politiche e diverse estrazioni sociali.
C'è chi, come il soldato semplice Joseph Delaney, scrive pensando che la storia della sua compagnia sia la storia di tutte le compagnie, di tutti gli eserciti. C'è chi, come il soldato semplice Archie Lemon, medita con i suoi commilitoni a proposito del senso della guerra: non sembrano tutti convinti che il loro sacrificio possa servire a “metter fine alle ingiustizie” per sempre. Non a caso, il sergente Donohoe scrive, poco più avanti, che considera la guerra un lavoro come un altro: quando capita, ci si deve adattare, ci si deve giocare tutte le carte. C'è chi, come il soldato Ayres, non vuole dare retta ai suoi amici ex universitari che ripetono che ogni guerra nasce da interessi finanziari, per scopi esclusivamente egoistici, e “ridono dell'idea che l'idealismo o l'amore per il proprio Paese abbiano qualcosa a che fare con la guerra. È brutale e degradante, dicono, e gli sciocchi che vanno a combattere sono pedine spinte qua e là per servire gli interessi di altri” (p. 97).
C'è chi si stanca di scrivere finte lettere romantiche e piene di elogi ai famigliari dei soldati caduti, e racconta le cose come stanno, nude e crude. Ed è terribile. E c'è chi muore senza sapere come andrà a finire, naturalmente, cade disperato perché non ha idea se il suo martirio ha avuto senso. È il soldato semplice William Mulcahey. C'è chi non vuole sparare a degli esseri umani a sangue freddo, prigionieri di guerra, e scappa. E poi torna indietro, disposto ad accettare vent'anni di galera per non aver eseguito gli ordini. C'è chi ha preso cinque anni per aver abbandonato il posto di guardia, a trenta chilometri di distanza dalla prima linea, per andare a scaldarsi i piedi in baracca. C'è chi si mette in piedi sulle trincee pur di essere ucciso, perché non ne può più. C'è chi si suicida, quando riconosce un contadino come lui, identico a lui, nelle fila nemiche.
C'è chi, come il sergente Michael Riggin, non capisce i compagni che prendono e scrivono alle mamme, o alle fidanzate: “Non me ne importa un accidente di niente al mondo” – commenta – “agguanta quel che puoi, dico, e non dar niente in cambio, se puoi farne a meno” (p. 35). C'è chi s'accorge che uccide, come franco tiratore, solo perché non riesce a guardare in faccia il nemico: è il sergente Tietjen. E chi spara a un nemico inerme pensando che stesse per lanciargli una bomba, mentre invece era la foto della sua bambina (p. 68). E c'è chi spara a tutti i nemici perché una volta un prigioniero lo ha fregato, e ha ammazzato un suo amico.
Intanto, c'è chi si lamenta del rancio, come il soldato Carter Atlas: questo il suo racconto... “A colazione, del caffè acquoso, una fettina di pane e una gavetta piena di minestra sciapa: per pranzo, due patate fradice con la terra ancora attaccata alla buccia, un pezzo di carne grande come un pollice e un cucchiaio di marmellata. La sera, di nuovo caffè, ma ancora più acquoso, e un tegame di riso scotto. Come si fa a campare con delle razioni simili? Ma prova a chiedere di più, prova e vedrai cosa ti succede!” (p. 42). E c'è chi, per fame, mangia il pane del nemico, sporco del suo sangue. Non si può sprecare il pane, al fronte. C'è chi sogna un po' di cognac, spesso proibito per i soldati americani. Quel cognac arriva, magari, per i malati che stanno per morire. Tira su il morale e attenua la sofferenza, proprio nel momento clou. È il bicchierino della pietà.
E c'è chi si lamenta, come Lucien Janoff, per le ferite ai piedi, derivate dagli scarponi tre numeri più grandi, fatti come di ferro battuto; e nonostante calli e vesciche, il corpo cede, e ci si ritrova a subire un intervento per eliminare l'infezione. È arrivata quasi all'osso. C'è chi diserta per amore, soltanto una manciata di giorni, torna al fronte ma viene accusato d'essere un traditore, come il soldato Benjamin Hunzinger.
E poi tutto finisce così, come racconta il soldato semplice Charles Upson: “La prima cosa che notammo fu il silenzio dell'artiglieria tedesca. Poi la nostra artiglieria smise di sparare. Ci guardammo l'un l'altro, sorpresi dell'improvviso silenzio, domandandoci che cosa accadesse. Arrivò un portaordini con un messaggio della divisione. Il tenente Bartelstone, comandante della nostra compagnia, lo lesse lentamente e poi riunì i sergenti. 'Passate parola agli uomini di cessare il fuoco, la guerra è finita', disse” (p. 171). Basta un attimo. Ecco tutto.
Nel contesto della narrativa antimilitarista, “Compagnia K” va annoverato tra quei romanzi occidentali, dal satirico “Comma 22” di Joseph Heller (1961) al tragicomico “Un anno sull'altipiano” del nostro Lussu (1938), dall'umanissimo “Mattatoio n. 5” di Vonnegut (1968) al doloroso, consapevole e lirico “Libro di un teppista” di Ottone Rosai (1919), capaci di raccontare la tragedia e l'assurdità e tutte le incredibili avversità e contraddizioni della guerra. La nostra Prima Guerra Mondiale, vale la pena ricordarlo, a differenza di quella statunitense aveva un senso profondo, patriottico e non politico; quello di liberare dal giogo asburgico le città di Trento e Trieste, l'Istria e Fiume. Si può e si deve obbiettare che questo risultato si poteva conquistare con l'arte della diplomazia, e della politica, evitando allucinanti spargimenti di sangue. In un mondo perfetto sarebbe andata così. E non si può non essere riconoscenti a tutti i soldati caduti nell'impresa. E non si può non meditare sul senso delle guerre quando si leggono documenti – narrativa? Poco conta – come questo di William March. Non parlo solo da obiettore di coscienza, parlo da semplice cittadino. Questo libro scava nella coscienza del lettore un buco che somiglia a una grotta carsica. Provare a dare un volto e un corpo a ognuno dei nomi presenti nel libro, e provare a identificarsi con le loro storie e le loro memorie, nella maggioranza assoluta dei casi, è un'esperienza estetica di singolare dolore e profondità. Si chiude il libro e si sente una morsa di freddo, terrificante. Tanti pensieri si incrociano, t'annebbiano.
Bellissimo, inquietante, tragico. Fondamentale.
EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE
William Edward Campbell, alias William March (Mobile, 1893 – New Orleans, 1954), romanziere americano, combattente durante la Prima Guerra Mondiale.
William March, “Compagnia K”, Castelvecchi, Roma, 2010. Traduzione di Adriana Pellegrini [1967: immutata]. Prefazione di Dario Morgante.
Prima edizione IT: “Fuoco!”, Longanesi, 1967. Traduzione di Adriana Pellegrini.
Prima edizione US: "Company K", 1933.
Gianfranco Franchi, giugno 2010.
Prima pubblicazione: Lankelot.
