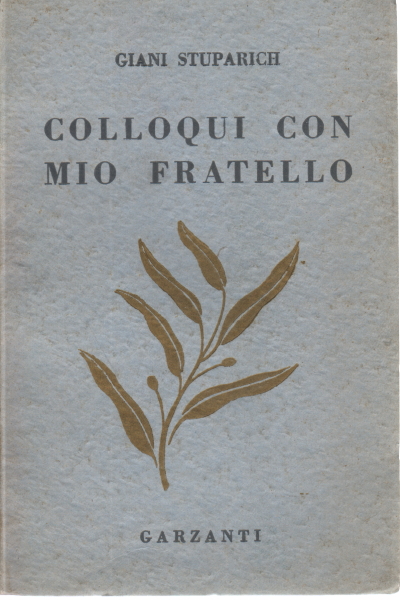 Colloqui con mio fratello
Colloqui con mio fratello
Treves
1924
9788831747929

“Non c'è volta nei nostri colloqui ch'io non mi senta più indegno e nel tempo stesso io non trovi in me una nuova forza e speranza di far la mia vita migliore. Perché s'io possa un giorno per l'ultima volta chinare il capo tra le mie figliole e queste con dolore tranquillo mi congedassero: padre, tu ci lasci pur una vita da vivere senza disperare – oh, io avrei portato alla felicità la mia fatica e ritrovato Dio, per te, fratello” [Stuparich, “Colloqui con mio fratello”, p. 97].
A due anni di distanza dalla pubblicazione dei “Colloqui” di Giani Stuparich, e quindi nel 1927, un lettore d'eccezione come Italo Svevo, scrivendo al critico francese Benjamin Crémieux, sosteneva che questo è “un libro che pare un tempio”. E in un certo senso è così davvero: è il tempio di Carlo Stuparich. È il tempio di Carlo, il fratello di Giani Stuparich. Caduto in guerra e rimasto, per tutta la vita, come uno spirito, al fianco di chi lo aveva così tanto amato, e di chi continuava a sentire un bisogno disperato di lui. Questo libro è il tempio di Carlo, costruito da Giani. Giani senza pace. Questo libro è un quaderno di prose sentimentali, liriche e sconnesse, misticheggianti e spirituali: fondate sul fratello perduto e consacrate al fratello perduto; alla perduta idea di patria e di giovinezza e di eroismo: alla piena comprensione del significato dell'amore, dell'eternità, della patria di tutti gli uomini – della divinità.
Carlo Stuparich, caduto il 30 maggio 1916 sul Monte Cengio, non ancora ventiduenne, fu medaglia d'oro – esempio per tutti i cittadini e per tutti i combattenti – con questa motivazione: “comandante di una posizione completamente isolata di fronte a forze nemiche sovrastanti, accerchiato da tutte le parti, senza recedere di un passo, sempre sulla linea del fuoco, animò ed incitò i dipendenti, fulgido esempio di valore, finché rimasti uccisi e feriti quasi tutti i suoi uomini e finite le munizioni, si diede la morte per non cadere vivo nelle mani dell'odiato avversario”.
Vale a dire – e stavolta con le parole di Giani, e in letteratura: “Che un'isola avanti eravate sin dal mattino accerchiata di fuoco e intorno ingorgava il nemico rabbioso per non potersi gettar sulla nostra difesa e fulminava sì che in pochi rimasti tu, piantato, quasi inumano agli invocanti rispondevi: qui si rimane” [p. 17]. E lì, eroicamente, sarebbe rimasto. Uccidendosi, uccidendosi pur non di non ritrovarsi nelle galere austriache, trattato da disertore e non da prigioniero di guerra.
Il ritorno a casa di Giani era stato ben diverso da quello immaginato e vagheggiato per anni, parlando con Carlo e con Scipio Slataper, fraterno amico, grande letterato e vero patriota, caduto combattendo, giovanissimo. Come Carlo. Ogni cosa raccontava la perdita del fratello – ogni stanza, in casa, sprigionava la sua assenza. Lo sguardo sconsolato della madre ripeteva la sua assenza. Carlo era diventato lo spettro che tutto infestava: il senso di colpa, il rimpianto, il passato sogno distrutto. La giovinezza disintegrata.
Carlo era diventato la morte serena divina: la purezza perfetta. “Io son senza pace; tu sei perfetto. Così fosti più puro di me e potesti affidarti alla morte divina che ti accolse nel tempo più pieno. Ed io per mezzo tuo la vedevo, ma poi più non la vidi né seppi far nascere in me la chiara preghiera” [p. 45].
Giani conosceva fondamentalmente la solitudine, a quel punto. Una solitudine assoluta, commovente, e lirica. “Esco quando annotta e s'illuminano le baracche, ma so di non trovar riposo neppure in quest'aria così tranquilla. Giri più inutili del sangue che mantiene questa mia vita e non sa perché. Sono solo. Parlare anche col migliore dei miei compagni, una fontana sarei che invece d'acqua spicciasse cenere. Perciò scelgo quest'ora. Meglio incontrare la ronda che mi ricacci dentro con ringhio di muta rabbiosa” [p. 13].
Questa solitudine ha dato vita a pagine di narrativa intense, umanissime, strappacuore: naturalmente estranee ad artifici retorici e a qualsiasi capziosità, espressione d'un dolore bambinesco, complicato però da un senso di responsabilità da padre della patria. “Colloqui con mio fratello” non ha la potenza e il respiro del capolavoro giuliano dell'epoca, vale a dire “Il mio Carso” di Slataper, ma ha almeno discreta letterarietà, e enorme sentimento. Nessuna maniera: nessuna bassezza: nessuna scorciatoia retorica. Infinita pietà – e nessuna apologia patriottarda, nessuna spacconata nazionalista. Ci sono tutte le lacrime di un ragazzo partito al fronte col fratello, tornato a casa senza fratello.
**
In appendice all'edizione Marsilio, 1985 – la terza della storia, sinora, post Treves, 1925 e Garzanti, 1950 – Cesare De Michelis ha raccolto “poche limpide pagine sparse di Giani dedicate a Carlo che segnano, accanto alle altre già note in volumi facilmente accessibili, la presenza lungo tutta la vita di quell'affetto [...]”: si tratta di quattro pezzi. Nella fattispecie: “Il ciliegio di Bigliana”, originariamente apparso sulla rivista “L'armonica” nel 1916; “Colloquio con mio fratello”, già uscito su “La Stampa” del 2 giugno 1938 e poi nel libro “Pietà del sole” [Sansoni, 1942]; “Mio fratello Carlo e i supi libri”, pubblicato nella rivista “Inediti triestini”, preparato per il X Congresso dell'Associazione Italiana per le Biblioteche [Trieste, 18-22 giugno 1956]; infine, “Sull'altipiano di Asiago”, pubblicato sul quotidiano capitolino “Il Tempo” il 6 marzo 1960.
“Il ciliegio di Bigliana” è un breve frammento: è il ricordo della prima mattina di riposo, dopo nove giorni di trincea e fango, nella guerra del 1916: “poter guardare il cielo ci pareva una grazia” - sospirava Stuparich. Lui e suo fratello Carlo stavano ai piedi d'un ciliegio, a riprendere il respiro, tra i campi, nelle retrovie: da quelle parti, qua e là, ciondolavano altri soldati disarmati. Inermi, e sembrava che “da un momento all'altro avrebbero potuto diventar contadini” [p. 126], ritrovando quiete. Era la primavera, e quella sensazione di pace e di beatitudine rigenerava i due ragazzi – e per la prima volta la primavera sembrava irreale. A un tratto, le schegge d'uno shrapnel, caduto fuori bersaglio – a un passo dai fratelli – ad ammonirli della fine della tregua, e dell'incanto.
“Colloquio con mio fratello” è la trasfigurazione d'un allucinato ritorno sull'altipiano, sul luogo della tragica morte di Carlo, ascoltando il verso del cuculo come fosse un richiamo segreto: “Qui, sul muricciolo di sassi che chiude la zolla che t'ha coperto quando cadesti, mi siedo e ascolto le grandi voci del vento e della pioggia, del sole e della terra. Ogni volta – scrive, lirico, Stuparich – intrecciano sull'anima, raccolta a intenderle, una sinfonia piena di fremiti, di dolorosi echi, di elevate consolazioni: vi passano la storia e le vicende umane, ma sono come tolte alla rigidità dei loro schemi, sono fluide [...]” [p. 130].
E a un tratto Giani racconta che Carlo appare: appare come Angelo della Verità, e parla con una voce nuova, e giudica il fratello e le sue scelte. Giani si sente colpevole di non essere riuscito ad andare fino in fondo con le cose della vita – di non aver saputo combattere abbastanza la menzogna, e il male. E in quel silenzio dove Carlo gli parla Giani si rigenera, meditando, e si ripromette infine di restare fedele a quelle idee di purezza, di valore e di giustizia che per anni avevano condiviso. Fino alla fine.
Nel terzo pezzo, “Mio fratello Carlo e i suoi libri”, Giani racconta le emozioni sentite sfogliando i libri fraterni, sul suo vecchio scaffale, in casa. “L'atmosfera viva della nostra giovinezza emana ancora di là; gli anni e le vicende non sono riusciti a soffocarla”, scrive. E ricorda quanto suo fratello amava ogni suo libro, e quanti risparmi e quanti sacrifici materni erano serviti perché potesse avere, ragazzino, tutti i libri desiderati – e con quanta pazienza aveva atteso ognuno di essi. E infine ricorda quanti libri Carlo si faceva mandare, al fronte, per poterli leggere nei momenti di tregua. In guerra, il fratello leggeva Polibio, Tucidide e Stendhal, Teocrito e Leopardi, Wells e Catullo – per esorcizzare la sofferenza, la morte e il male con la bellezza, e con l'intelligenza.
Infine, nell'ultimo pezzo scelto da De Michelis, “Sull'altipiano di Asiago”, l'artista giuliano, ormai vecchio, racconta quanto sia cambiato lo scenario nel corso di quarant'anni e oltre di pellegrinaggi sulla tomba del fratello, e sui luoghi della Grande Guerra – soltanto la natura, ripete, è rimasta fedele, e riconoscibile. Ma il resto, col tempo, sembra proprio essersi dissolto: fienili, case e piccoli cimiteri. Già altrove, in questo suo libro, l'artista scriveva che la natura non pretende d'avere una storia: una primavera si dimentica dell'altra. Ma il resto no. “Come è avvenuto che tutto il sangue sparso – scrive, sconsolato –, che gli ultimi respiri degli uomini dietro le siepi, che tante vite perdute non abbiano lasciato traccia? E se non fosse la mia memoria che fa incendiare quel fienile presso i due ciliegi, che popola quei pietroni di figure d'austriaci e di ungheresi in agguato, che scuote l'aria con sibili e strazi e mucchi di terra sollevati nel fumo delle granate, tutto parrebbe da secoli tranquillo e sereno, idillico e innocente” [p. 145]. Come niente fosse, in altre parole. Come altrove dev'essere, e già da un pezzo, per i due fratelli Stuparich. Altrove. Finalmente.
EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE
Giani Stuparich (Triest, Austria, 1891 – Roma, 1961), giornalista e scrittore italiano, di madre triestina (Gisella Gentili) e padre di Lussino (Marco Stuparich). Iscritto all’Università di Praga, si trasferì assieme a Slataper all’Università di Firenze. Si laureò in Letteratura Italiana con una tesi su Machiavelli.
Giani Stuparich, “Colloqui con mio fratello”, Marsilio, Venezia, 1985. A cura e con una nota [“Amor fraterno”] di Cesare De Michelis.
Prima edizione: Treves, Milano, Natale 1924, con data 1925.
Approfondimento in rete: Wikipedia.
Gianfranco Franchi, agosto, 2011.
Prima pubblicazione: Lankelot.
Scriveva Svevo: “Questo libro pare un tempio”.
