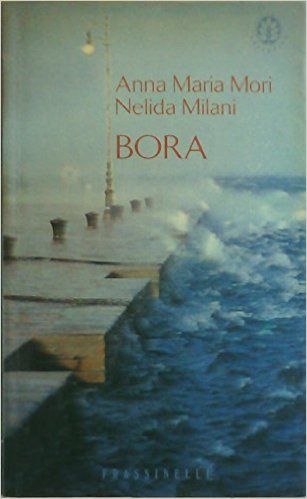 Bora
Bora
Frassinelli
2005
9788882749019

Pola aveva 31.700 abitanti italiani. Esuli, tra 1946 e 1947, furono 28.025. Gli slavo-comunisti occuparono una città fantasma, e con barbara prepotenza la slavizzarono, popolandola di forestieri. Una polesana “rimasta” dialoga, in questo libro, con una polesana vissuta esule tra Firenze e Roma. Ho letto questo libro, ho sofferto, ho sentito una rabbia terrificante, ho amato i miei fratelli esuli di prima, seconda o terza generazione con maggior intensità ancora, se possibile; e ho disprezzato chi s'è spacciato per liberatore, slavo o italiano che fosse, armato di falce e martello, con tutto me stesso. Perché il “liberatore” ha cancellato la storia, e sradicato un popolo, in nome della sua triste ideologia. E ha preteso d'avere ragione.
Per l'ingiustizia sofferta dal popolo istriano, fiumano e zaratino non esiste compenso, né parola adatta a consolare e dare pace. Ma alla denuncia dei responsabili del male inferto, italiani e slavi, non esisterà fine. Molto semplice. Questo è il compito di chi viene da sangue istriano. Rivendicare eternamente giustizia, domandare verità, pretendere le scuse. Dagli italiani e dagli slavi, dai comunisti e dai democristiani, dagli inglesi e dagli americani. E infine, sognare un futuro diverso. È sempre possibile. Nessuno lo vieta: nei sogni i regimi non possono entrare. I regimi albergano soltanto negli incubi.
“L'esodo ha diviso tante famiglie quante il muro di Berlino. Ma nessuno qua desidera parlarne: un oggetto privo di stile, un tabù che gioca a nascondino con la storia, una metafora non abbastanza raffinata? Che sarà mai? L'esodo è il campo di concentramento della nostra gente. Sul muro del Cimitero della Marina i ragazzi avevano tracciato in rosso un graffito: 'Il vero divorzio è l'esodo'. Così si è cominciato a cedere ai bordi, con i matrimoni tra italiani e slavi (...)” (p. 49). Per gli americani e gli inglesi di Radio Londra, Pola bombardata era, in codice, “Tommaso Moro”. “Tommaso Moro, attento”, diceva. “Perché gli 'Alleati' ci bombardavano, distruggendo le case, uccidendo gli amici e i vicini di casa? Cos'avevamo fatto, io, mamma, papà e le due nonne, perché gli americani e gli inglesi mettessero a rischio la nostra vita notte e giorno con i loro bombardamenti a tappeto? (…) E perché, alla fine della guerra, tutto risolto per tutti, noi dovevamo continuare ad avere paura? Perché si dovevano temere i partigiani slavi, che pure avevano fatto la resistenza insieme ai partigiani italiani? (…) Perché gli slavi ci odiavano?” (p. 154).
“Non è vero che io e tutti i trecentocinquantamila esuli istriani, siamo, eravamo, borghesi e fascisti. Non è vero che tutta l'Istria era slava e doveva tornare alla Jugoslavia. Non è vero che tutta la mia gente è solo nostalgica e irredentista” (p. 7). A parlare è una delle narratrici: Anna Maria Mori, istriana di Pola, di famiglia laica, democratica, antifascista; costretta all'esilio a Firenze e infine a Roma assieme a molte migliaia di nostri compatrioti tanto tempo fa. Costretti ad andarsene dall'occupazione slavo-comunista, spacciata per “liberazione”. “Perché” - come si legge a p. 101 - “non fummo noi, a volercene andare: la verità era, ed è, che 'loro' non ci volevano su quelle terre, di cui pretendevano di cancellare, insieme alla nostra presenza, anche la storia”. Chi restava doveva “tacere, obbedire, temere” (p. 108). Agli slavi, ai comunisti.
Tutto comincia con una foto. C'è una bambina che sorride. Sul retro della foto, a penna, è scritto “giugno 1937”. Scrivere il luogo non serviva, perché “è dato per ovvio e sottinteso. Perché, salvo avvenimenti straordinari, il luogo del nascere sarà quello del vivere in seguito: insensatamente si pensa, quasi senza pensarlo, che sarà il luogo del 'sempre' (…)” (p. 3). Quel luogo è Pola, Istria, Italia. “Fino a cinquant'anni fa era quel che si dice una ridente cittadina che ha dato i natali, tra gli altri, a musicisti come Luigi Dallapiccola e Antonio Smareglia, trenta-quarantamila abitanti, un porto militare di primaria importanza, e l'eleganza straordinaria di vistosi e bellissimi resti Romani: oggi, più niente; a tal punto è stata cancellata dalla storia e dalla memoria collettiva, che il computer, al suo nome, si innervosisce, si inceppa e segnala 'errore'” (p. 3). Anna Maria Mori se ne è andata via da casa, esule, nel 1946, s'è ritrovata a Roma, e da allora ha cercato di rimuovere, cercando di dimenticare, di cancellare tutto, rispondendo con stizza alle canzoni in dialetto cantate dalla madre. A nessuno diceva d'essere nata a Pola, per evitare illazioni e provocazioni. Poi incontra un libro, scritto da una ragazza che a Pola era rimasta, Nelida Milani. È uscito per Sellerio nei primi anni Novanta, parla del suo popolo e della sua terra, si chiama “Una valigia di cartone”. Cerca di entrare in contatto con lei, ma la Milani inizialmente nicchia, e poi tentenna. Ha paura di “non saper parlare, di non riuscire a spiegare decentemente in quella terza lingua fuori codice, nata dal pasticcio tra croato e italiano, ciò che preme dentro” (p. 11); si sente ormai estranea agli italiani. E ha una strana visione dei suoi 32mila concittadini esuli: lei e gli altri rimasti sono diventati “italiani speciali”, nostalgici dei vecchi legami e desiderosi di tramandare tutte le antiche tradizioni agli eredi. Ma è difficile. Perché un bel giorno, o forse un brutto giorno, la guerra finì: “Ma per noi, per la gente dell'Istria con i paesi e le città affacciate su quel mare bellissimo, incorniciato da ghirlande di ciottoli bianchi e da rocce grigie a strapiombo, non arrivò la pace come per il resto d'Italia” (p. 22).
Tra le due nasce una corrispondenza: e anima questo libro. Quando la guerra finì, l'Istria fu occupata dalle truppe di Tito; ma poi arrivarono inglesi e neozelandesi. Nell'italianissima Pola, pazzi di felicità, i cittadini offrivano fiori al loro esercito, e in cambio ricevevano barrette di cioccolata. Lì per lì si sperava nella pace. Tirava, purtroppo, una brutta aria. “Si capì quasi subito che il destino delle nostre terre era segnato. Cercammo di cambiarlo” (p. 27) manifestando tutti insieme, di fronte ai diplomatici delle grandi potenze, per mostrare quanti erano. E gli slavi, intanto, con tanta gente presa dalle campagne, facevano la stessa cosa, incapaci di essere in tanti a rivendicare Pola. Con loro, qualche italiano. Indovinate...
“Oh, i comunisti, Gesù mio, molti comunisti italiani avevano fatto con loro la lotta partigiana nei boschi, e ora marciavano con gli slavi – la testa piena delle loro grandi idee romantiche – cantavano in coro gli inni della rivoluzione con grandi schitarrate, abbaiavano contro i borghesi italiani con incredibile disprezzo, come se fossero stati degli assassini, come se l'intera popolazione fosse composta da idioti che certe cose se le potevano bere solo così (...)” (p. 70). Molti di quei partigiani furono giustiziati sommariamente da Tito. Comunista come loro; ma imperialista jugoslavo (p. 72). Su Pola marciarono partigiani comunisti, slavi, anti-italiani, antiborghesi e... anticittadini. I polesani li chiamavano “l'esercito in ciabatte”. Altro che croati, spesso erano bosniaci, montenegrini. Quella gente straniera entrava nelle case degli italiani, presto “nazionalizzate”, e usava i bidet per seminare prezzemolo e basilico. L'ignoranza e la barbarie sanno essere creative.
Emergono “I ricordi di bambina delle violenze degli occupanti sugli occupati, degli slavi sugli italiani di Istria, uomini che uccidevano altri uomini, e da altri venivano uccisi, spesso solo per vendetta personale o di classe, e sempre in maniera 'virilmente' spettacolare” (p. 28). I ricordi di chi si opponeva, tra le adulte italiane, al marito slavo e comunista che organizzava spedizioni nel buiese per “bastonare gli italiani, per farli fuggire in Italia, per confiscare i loro beni mobili e immobili” (p. 29). E di quella lingua d'allora, in cui in croato al limite si bestemmiava, sotto le bombe, o si giocava a dire “cuciza”, casa, “liepa”, per dire bella mia a un'amica... ma insomma tutto era fuorché “la lingua della violenza, dell'aggressione e della paura” (p. 40). Ossia la lingua che sarebbe diventata. Quella della morte.
E poi, ecco il racconto di come gli slavi impedirono si parlasse italiano a scuola, quando la speranza era morta: altro che Pahor... “Se vi sento ancora parlare italiano, mollo il cane che vi divori – diceva un guardiano con un grosso cane, dalle parti della scuola “Vladimir Goitan” -. Ve la faccio passare io la voglia di parlare questa lingua fascista” (p. 41). Questo diceva a due bambini, una femmina e un maschietto, colpevoli di parlare soltanto nella loro lingua. E il maschietto lasciò la terza classe elementare italiana, per andare a iscriversi alla terza croata. I fratellini della piccola, Claudio e Diego, per i registri slavocomunisti erano “Klaudio” e “Dijego” (p. 42). Cambiavano nome, proprio come Pola diventava “Pula”, e Orsera “Vrsar”. “Il nome era un simbolo, e quando i simboli cadono, nulla è più come prima” (p. 162). Tanti ragazzi rimasti e costretti a essere slavizzati oggi hanno messo figli e nipoti nella scuola italiana, “ma ancora cercano sé stessi, ancora non si sono completamente ritrovati” (p. 169). I comunisti hanno falsato l'essenza dei rimasti; ne hanno stuprato l'identità.
Si racconta delle osterie “nazionalizzate” da comunisti slavi di nome Zika, Mustafa, Andrija, Rifat. Sì, le osterie. Dove adesso certi slavi sputavano in fronte a una cantante slava, perché pensavano portasse fortuna. E delle chiese che diventavano caserme. Si racconta del tricolore con la stella rossa appeso qua e là dai comunisti. Italiani. Della gente che spariva tutte le notti, senza colpa, presa e portata al massacro dagli invasori. Innocenti massacrati nel nome della stella rossa. Ma Togliatti salutava, per radio, “il grande capo ed eroe nazionale” Tito; e in certe case, allora, si spegneva la radio e si metteva su un disco.
Tutta colpa del fascismo? “Ma il fascismo ha svuotato i paesi slavi? Dov'è il contraltare di Portole e Montona? Di Capodistria e di Pola? Di Fiume e Dignano? Di Grisignana e Orsera? Di Gallesano e Albona? Ha svuotato l'Istria dei suoi abitanti, il fascismo?” (p. 86). Punto. Tutto molto chiaro. Bisognava fuggire dal comunismo. Il regime slavo comunista era intollerabile. Qualcuno scelse la via più drammatica e definitiva: “Bepi, che Dio ghe 'brazi l'anima, si sparò una domenica e lasciò scritto sul foglio di carta no xe per mi 'sta roba. Lo trovarono accanto alla sua verdura, la mano rattrappita vicino alla tempia (…). Aveva la testa aperta in due” (p. 133).
Chi riesce ad andarsene, già nei primi tempi, pensa: “Mi hanno rubato il mio destino”. E poi, quando venne il momento, “Tutta la città di pietra prese il mare, racchiusa nei cassoni di legno. Non so se fosse mai accaduto che un'intera città venisse trasportata via mare, ma è proprio ciò che accadde” (p. 143). Partivano, e le loro case venivano nazionalizzate e date a ex contadini provenienti da tutta la Yugoslavia, per accelerare l'edificazione del socialismo. E la slavizzazione delle terre istrovenete. Come Stalin insegnava, gli slavi applicavano ingegneria sociale nel nome della loro ideologia.
Gli slavi infoibavano già dal 1943 (p. 110). Rapivano la gente di notte, colpevole solo di essere italiana, la massacravano, la gettavano in fondo a quei crepacci. I luoghi delle sparizioni saranno rivelati soltanto post caduta del Muro di Berlino, ma i contadini sapevano, “a causa dei lamenti che provenivano dalle fenditure rocciose. Raccontarono che a lungo avevano sentito provenire dalle viscere della terra richiami e invocazioni d'aiuto, i gemiti della troppo lunga agonia di coloro che erano rimasti vivi e anelavano ancora alla vita pur nel terrore della fine certa, terrore che si concludeva con il rantolo della morte” (p. 118).
E adesso basta, fermiamoci qua. Perché credo d'aver detto abbastanza. E paradossalmente so che questo abbastanza non sarà mai abbastanza. Non mi stancherò mai di difendere la storia del popolo istriano. Viva Pola, viva l'Istria. Viva tutti quelli che difendono la verità.
«Un dialogo di due donne sui grandi temi dell'esilio, della fedeltà e incertezza dell'identità, della frontiera, della memoria perduta, rimossa e ritrovata... È un libro vivacissimo, lucido, e poetico» (CLAUDIO MAGRIS,Corriere della Sera)
EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE
Anna Maria Mori (Pola, Istria, IT, 1936), esule istriana, ha studiato a Firenze e vive a Roma. Giornalista e scrittrice italiana (“Messaggero”, ex di “Repubblica” e di “Anna”).
Nelida Milani in Kruljac (Pola, Istria, IT, 1939), vive a Pola, da qualche tempo città croata. Si è laureata in Lettere a Zagabria. Docente di linguistica generale e di semantica presso l'Università di Pola. In narrativa, titolo più memorabile è “Una valigia di cartone” (Sellerio, 1991; Premio Mondello 1992). Per quindici anni è stata caporedattrice de “La Battana” pubblicato dalla EDIT di Fiume.
Anna Maria Mori e Nelida Milani “Bora”, Frassinelli, Milano 1998. In appendice, Cronologia.
Gianfranco Franchi, ottobre 2009.
Prima pubblicazione: Lankelot.
