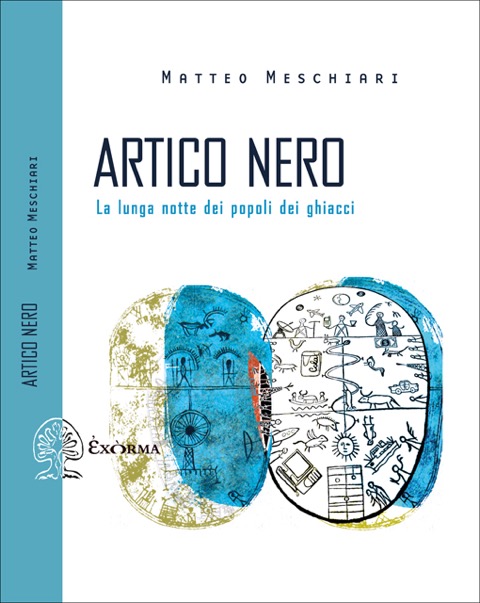 Artico nero. La lunga notte dei popoli dei ghiacci
Artico nero. La lunga notte dei popoli dei ghiacci
Exorma
2016
9788898848379

L'antropologo modenese Matteo Meschiari, classe 1968, ha dimostrato, con questo “Artico nero. La lunga notte dei popoli dei ghiacci” [Exorma, 2016; euro 14,50, pp. 168], che ibridare narrativa, poesia [da performance], reportage, fotografia e antropologia è possibile, con esiti notevoli e spiazzanti: questo nuovo genere è l'antropofiction. Dialogando col “Trentino”, Meschiari ha spiegato: “Il termine 'antropofiction' l’ha usato per primo Marc Augé, ma in un'accezione molto diversa da quella che propongo io. Per me 'antropofiction' significa non inventare nulla, ma dare alle storie etnografiche quella forza linguistica e quella visibilità poetica che sono tipiche delle grandi narrazioni romanzesche. Storie reali raccontate, non trasformate in articoli specializzati».
“Io non cerco la verità, mi interessa l'intensità” - spiega nell'introduzione al libro. Naturalmente, la sensazione è che questa intensità sia, potenzialmente, eccezionalmente vicina alla verità, o almeno alla veridicità; non si può non ammettere che la lettura di “Artico nero” sia sconcertante, che sia anzi, ogni tanto, letteralmente scombussolante. Una delle ragioni è che, per restare alla lettera dell'antropologo Meschiari, “le terre all'estremo Nord sono uno specchio del prossimo futuro. Guardarle significa guardare il mondo tra qualche anno”. Ed è il mondo ferito dai cambiamenti climatici, è l'ambiente macchiato dalla prepotenza dell'uomo occidentale e delle sue industrie, è l'autodistruzione del cosiddetto antropocene. L'altra ragione è che questo libro racconta “un lento genocidio etnico”: quello dei Sami, dal Medioevo in avanti, poi quello degli Inuit della Groenlandia, degli Ahiarmiut già deportati dai canadesi, dei Ciukci: “Va bene raccontare storie, ma questo libro ha anche la presunzione, oltre che di abbaiare contro lo stupro dell'Artico, di spiegare il colonialismo e i suoi trucchi. Alcol, stato di diritto, silenzio e disinformazione, modelli fuori portata, promesse non mantenute, denaro e diversificazione della povertà. Ma soprattutto costruzione scientifica dell'Altro” [p. 72]
5 capitoli su 7 di questa “mappatura ai margini di un Artico nero e morente” hanno una potenza impressionante. Gli ultimi due tendono a mostrare più di qualche debolezza – perché perdono quasi del tutto ogni aspetto saggistico, sprofondando nella fiction pura; il sesto è sostanzialmente una lunga performance, il settimo un racconto non sempre coinvolgente. È quando l'antropologo Meschiari rimane fedele alla sua disciplina, e all'intelligenza anfibia che anima la sua antropofiction, cioè nei primi cinque pezzi, che “Artico nero” scintilla di una disperata lucidità, di una folgorante rabbia, e periodicamente sgomenta e sbalordisce il lettore. Meschiari è forse il primo intellettuale italiano a raccontare le terribili e sconosciute (o misconosciute) sorti dei popoli artici, con tanta esattezza e tanta empatia; è probabilmente il primo ad aver invertito la percezione europea, e occidentale in genere, delle sofferenze del mondo [“Il Sud del mondo soffre, ma è al Nord più estremo che la fine di un mondo sta anticipando la fine del mondo. Rovesci ambientali, menti bruciate, saperi svaporati in nulla”], e in questo senso va speso, nei suoi confronti, il raro e luccicante aggettivo “rivoluzionario”. Un aggettivo che pesa parecchio: soprattutto in un'epoca come questa, che sembra ostinatamente estranea alle rivoluzioni (preferendo piuttosto precipitare per involuzioni).
Si comincia dalla Jamalia: scopriamo che i Russi ormai chiamano le antiche popolazioni autoctone siberiane “inozemtsy”, vale a dire “forestiere”: forestiere nella loro terra, nella terra che hanno abitato per tanti millenni. Sotto socialismo sovietico, l'imperialismo russo le ha massacrate e snaturate con “scolarizzazione forzata, perdita della lingua nativa, obbligo di sedentarietà, confisca delle renne, arresto e uccisione degli sciamani, conversione del pastore-cacciatore in operaio-minatore-contadino”, cancellando saperi millenari e millenari, superbi equilibri ecologici e ambientali in genere. Sotto zar, le cose non erano state differenti: “Espropriazioni. Terreni di caccia ceduti agli agricoltori russi. Cristianizzazione. Servitù della gleba”; e allucinante mercificazione della donna (“ostaggi, schiave, concubine”).
In questo contesto di disastro culturale, si risvegliano antichi virus come l'antrace: è accaduto nel luglio del 2016, per via dello scioglimento eccessivo del permafrost, che va risvegliando “cose ghiacciate e agghiaccianti”, non soltanto sacche di metano e gas, in genere, col rischio di “pandemie boreali”.
Si passa alla Norvegia: siamo in quella che chiamiamo Lapponia, nella terra dei Sami. Un nome che sembra significare, semplicemente, “quelli della terra”: “cacciatori-raccoglitori, allevatori nomadi, forse i primi a ripopolare il Nord Europa alla fine dell'Epoca Glaciale”. I Sami sono stati uguali a se stessi per millenni. “Sempre su basi genetiche, c'è chi sostiene che i Sami, durante il massimo glaciale, 18mila anni fa, vivevano dove vivono oggi. Un fossile circumpolare”. Siamo riusciti a snaturarli: creando confini tra nazioni [Norvegia-Finlandia] laddove per loro esistevano semplicemente terre dove portare le renne, a seconda delle stagioni; strappando i loro diritti di caccia e di pesca sulla propria terra; lucrando con compagnie minerarie nei loro giacimenti; negando la loro lingua (riconosciuta come lingua ufficiale solo nel 2000).
Eccoci in Groenlandia, tra gli Inuit, negli anni della Guerra Fredda: a testimoniare l'assurda fondazione di una base nucleare americana tra i ghiacci, a osservare l'espropriazione della terra degli Inuit e il loro trasferimento forzato, a deplorare l'allucinante incidente nucleare di Thule del 1968: incidente di un B52 yankee, quattro bombe a testata nucleare si schiantano sui ghiacci, il plutonio si disperde; e poi “2 milioni di metri cubi di ghiaccio contaminato vengono asportati dal sito dello schianto”. Già: “negli anni successivi 450 operai danesi sui 1500 intervenuti sul luogo del disastro moriranno di cancro per radiazioni. Molti dei loro figli sono disabili, deformi. Il tasso di tumori a Thule è del 50% più alto rispetto alla media. La fauna marina è contaminata per generazioni […]. Il vero disastro rimane segreto per vent'anni […]. La Danimarca si è sempre dichiarata denuclearizzata” - e non manca una bomba perduta, ufficialmente negata dai rapporti, rimasta intrappolata tra i ghiacci dei poveri Inuit, o chissà Dio.
Per probabile effetto del genocidio culturale, la Groenlandia è il paese al mondo in cui ci si suicida di più [“come se a Centocelle ci fossero 60 suicidi l'anno”].
Leggendo storie come questa – e come quelle del disastroso scenario dei villaggi dell'Alaska, dove “l'acqua si fa strada ogni anno di più verso il grappolo di case, striscia centimetro dopo centimetro come un grosso animale liquido”, mentre il permafrost si scioglie e il terreno sprofonda, e la gente non sa proprio dove scappare, e non ha denari per costruire dighe o spostare di peso interi paesi – la coscienza è abbacinata da tanta sofferenza, e non si può non sentire solidarietà e rabbia e pietà. Non soltanto per i popoli artici: per i nostri figli, per il mondo che stanno ereditando, per la nostra incapacità di rallentare il collasso del sistema, per la nostra vigliacca smania di disintegrare tutto ciò che è diverso e distante dalla civiltà occidentale, per aver perduto intere piccole civiltà che oggi avrebbero potuto guidarci nella resistenza ai cambiamenti climatici, restituendoci forse un più profondo e antico rispetto per la natura, e per il creato.
Gianfranco Franchi, maggio 2017
“Le terre all’estremo Nord sono uno specchio del prossimo futuro. Guardarle significa guardare il mondo tra qualche anno”.

One thought on “Artico nero. La lunga notte dei popoli dei ghiacci”
Comments are closed.