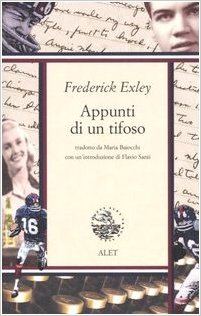 Appunti di un tifoso
Appunti di un tifoso
Alet Edizioni
2005
9788875200084

Opera prima di Frederick Earl Exley (1929 – 1992), scrittore di Watertown, New York, “Appunti di un tifoso” è un memoir. Il memoir di un “loser”: l’incubo wasp del fallito, dell’inadempiente alla vita, parassita della società e depresso cronico. È un’autobiografia romanzata di notevole intensità; nelle trame, inevitabilmente, e nella scrittura. Chi è Fred Exley da Waterland, New York? È un insegnante fallito (o mancato, o privo del senso della “missione”?), un marito incapace di tenere in piedi il suo matrimonio, un vagabondo arrestato e internato, un ex lettore instancabile che sogna recensori generosi, affabili e divertenti, mai neutri, un alcolista incallito e uno scrittore ossessionato dalla conquista della fama e dell’immortalità (cfr. omaggio ad Hawthorne, incipit: “sogno più potente di mille realtà”): o forse solo compiaciuto dall’aura di “artista”, da piccolo borghese ribelle, eternamente malinconico, insoddisfatto, incompreso. È – anche – un flaneur americano. Cambia città senza cambiare stile di vita. Cerca una realizzazione impossibile. Esiste solo un’ossessione.
È, e sempre rimane, ovunque sia e comunque viva, un tifoso: come annuncia il secondo e definitivo titolo dell’opera (cfr. “Bere, tifare, guardare il soffitto” di Flavio Santi, p. 10: il titolo originario era “Footnotes of North Country”), questo è il libro d’un uomo che si riconosceva in uno e un solo ruolo. Un tifoso non solo sanguigno: un fanatico. L’identità di Exley coincide con la fede nella sua squadra del cuore; e con quel suo campione, Frank Gifford, che sembra essere il suo doppio integrato e vincente – campione amatissimo, realizzato, idolatrato sin dai tempi dell’Università, quando voleva gridargli che la vita non era solo trionfo e ammirazione, ma “rifiuto, dolore e perdita”: forse per difenderlo, forse semplicemente per provare a intaccarlo. Ma di fronte all’opportunità di parlargli, allora, le parole rimasero impiccate nello scafandro della gola, impietrite dal sorriso innocente del campione. La linearità di Exley, a proposito della natura simbolica del suo rapporto di identificazione-adorazione nei confronti di Gifford, è esemplare: “Se io non riuscivo a dare forma alle mie fantasie attraverso le parole, Gifford, con la sua straordinaria velocità, con le sue grosse mani, con le sue finte straordinarie, sapeva dare forma alle sue. Ma era qualcosa di più di questo: (…) la mia ansia divorante finì per appropriarsi del suo desiderio di sfuggire allo squallido anonimato dell’esistenza, e ciò al punto che, dopo un po’ di tempo, Gifford diventò il mio alter ego, la parte di me che viveva nel competitivo universo maschile; e per quanto incredibile oggi mi possa sembrare, arrivai a convincermi che io ero, per effetto di una qualche magia, un reale strumento del suo successo (…)” (p. 166).
Quel ragazzo, incarnazione dello spirito americano (cfr. p.89 e ss.), è il feticcio d’una vita perfetta, integrata, vincente. Il confronto con le sorti del suo fan è depressivo, stomacante, massacrante. Exley vive guadagnando irregolarmente, poco e male; si ritrova in manicomio e non sembra essere pienamente cosciente delle cause, “schizofrenico paranoico” è una definizione che lo invita al limite ad approfondire Freud. C’è qualche amore che frammenta la continuità di questo vagabondaggio tra gli americani di un antiamericano; tutto è percepito e raccontato come un dormiveglia, è opaco; è come se Exley fosse sempre richiamato dalla coscienza dell’abisso. Dalla coscienza della sua vita.
Figlio di un grande giocatore di football della squadra locale, ex atleta morto d’una grave malattia ad appena quarant’anni, Exley sente di dovergli quella ricerca dell’adulazione e della riconoscibilità (attenuiamo così “fama” e “immortalità”, precedentemente adottati) che fondava la sua esistenza; dannandola alla sofferenza, all’incomprensione e alla ricerca di qualcosa che lo calmasse. Niente di naturale. L’artificio demoniaco e avvilente viene incontro facilmente, ecce alcol: “A differenza di altri, non avevo mai bevuto per farmi coraggio, per diventare seducente o brillante; avevo sempre usato l’alcol proprio per quello che era, un sedativo, per tenere sotto controllo l’eccitazione mentale prodotta in me da una prolungata sobrietà” (p. 51).
La vita di Exley è “lungo malessere”, stando alle parole dell’autore (cfr. Nota, p. 19); tifare Giants è qualcosa di diverso. “Ma tifare è una definizione avvilente. I Giants erano la mia gioia, la mia follia, il mio analgesico, il mio stimolo intellettuale” (pp. 25-26); ancora, poco oltre: “Perché il football era capace di restituirmi alla vita? Non so dirlo con precisione. In parte perché avevo la sensazione che rappresentasse un’isola di franchezza in un mondo dominato dalla prudenza. Nel football dovevi fare un gioco difficile e brutale. O lo facevi o lasciavi perdere. Non c’era niente di retorico o di vago e io avevo deciso di pensare che, in un passato più felice, dovesse essere stato così in tutte le faccende degli uomini” (p. 32).
La chiarezza di questi passi è tale che la glossa risulta superflua; allora vediamo qual è il miglior sigillo a queste annotazioni, sempre con le parole dell’autore: “Mi era impossibile immaginare cosa sarebbe stata la mia vita senza il football ad attutirne i colpi, e per questo il mio lutto era doveroso. Mi viene in mente solo ora che la mia passione avrebbe potuto essere rivolta con migliori risultati a Dio o alla Letteratura o all’Umanità, ma nella penombra di queste più serie devozioni ho sempre provato una sorta di estremo pudore che mi ha fatto ammutolire, o mi ha costretto a profferire alcune di quelle espressioni ciniche e brutali con cui gli ignoranti affrontano le cose che non conoscono” (p. 56).
È un libro che lascia un segno. Per la profonda consapevolezza dei contrasti, della loro composizione e della loro origine; per la tragedia d’un’eredità insopportabile, a dispetto della sua essenzialità, della sua semplicità; per il nitore della descrizione della vita da niente di chi infine comprende che “To sit in the stands with most men and acclaim others. It was my fate, my destiny, my end, to be a fan”. Altro da Nick Hornby e dalla sua “Fever Pitch”: laddove l’inglese, venticinque anni dopo, vive e descrive un rapporto simbiotico, magari eccessivo ma non distruttivo, mai delirante ma semplicemente e felicemente ossessivo, Exley invece ammette che si trattava dell’unica via di fuga, o forse dell’unica ragione di senso nella sua vita. Hornby è pop e divertente, e il suo è un romanzo di formazione: dalla gradinata alla tribuna, nel nome del padre sempre lontano, e dell’assimilazione tra lo spirito dell’Arsenal e il suo. Exley è cupo e irrimediabile, il suo è un diario con poche trasfigurazioni e qualche richiamo letterario (spesso Mann) a illuderci che non stia versando il suo sangue e il suo bicchiere di whisky sulle pagine. La società raccontata è la stessa: quella piccolo borghese. La professione è identica: professori. I risultati radicalmente diversi, a dispetto dell’ombra di socialità vissuta da spettatori, al fianco di spettatori.
Exley elabora il lutto della perdita del padre, del suo insuccesso prima sportivo poi professionale (esistenziale), aderendo a una living legend. Hornby non è un giocatore, è una squadra popolare. L’uno implora la pazzia di abbandonarlo, l’altro le sorride e la domina. Non posso non invitarvi a (ri)leggerli in sequenza cronologica. Al termine, pure trattandosi di sport diversi, troverete un pizzico di verità a proposito della società occidentale; non raccontatela a nessuno.
EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE
Frederick Earl Exley (Watertown, New York, 1929 – 1992), romanziere americano.
Frederick Earl Exley, “Appunti di un tifoso”, Alet, Padova 2005. Traduzione di Maria Baiocchi. Introduzione di Flavio Santi.
Prima edizione: “A Fan’s Notes”, New York, 1968.
Adattamento cinematografico: “A Fan’s Notes”, di Eric Till, 1972.
Gianfranco Franchi, agosto 2007.
Prima pubblicazione: Lankelot
