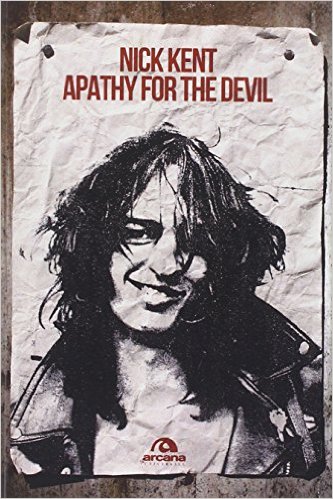 Apathy for the Devil
Apathy for the Devil
Arcana
2010
9788862311724

«Mio padre mi raccontò una volta una storia su Orson Welles, l'illustre regista di “Quarto potere”. Papà, o un suo collega, dovevano stare appresso a Welles mentre gironzolava in un pittoresco villaggio irlandese, nei primi anni Sessanta, registrando ogni sua parola mentre si trascinava da un pub all'altro. Gli anni di gloria erano ormai un ricordo per Welles, che si era ridotto a far sopravvivere la sua leggenda con sciocche comparsate in documentari turistici. Condizione che peraltro non sembrava modificare la percezione che aveva di se stesso. A chiunque incontrasse quel giorno regalava la stessa preziosa informazione: “Sono un genio”. Lo disse infinite volte: ai suoi collaboratori, ormai sfiniti, a baristi e camerieri che non lo capivano, a tutti quelli che entravano in contatto con lui. Lo dico perché Captain Beefheart era esattamente lo stesso tipo di persona, totalmente innamorato di se stesso» (Nick Kent, “Apathy for the Devil”, 1972, pp. 64-65).
Scrivere di rock è un'arte. E se quest'arte viene a insegnarcela uno come Nick Kent, grande allievo di Lester Bangs, allora c'è ragione di interiorizzare la lezione con entusiasmo, umiltà e una certa dose di curiosità. Apathy for the Devil (Arcana, 324 pp., euro 19,50) è il memoir di un giornalista che ha vissuto gli anni Settanta con un'intensità incredibile, nel bene e nel male. Nick Kent è uno che da ragazzino ha preso e se ne è andato al di là dell'oceano per incontrare quello che aveva deciso fosse l'ultimo maestro di giornalismo musicale, Lester Bangs. Nick Kent è stato amico e sodale di artisti radicali e liminari come Iggy Pop, e interprete del disastro interiore di talenti immensi e sfortunati come Syd Barrett, Nick Drake e Brian Wilson: è stato uno dei protagonisti dei primi passi dei Sex Pistols, e un grande ammiratore del talento di Keith Richards. È stato uno che ha capito il genio di Captain Beefheart, e che tra Buckley padre e figlio non ha dubbi: quello più dotato era Tim.
Più di tutto, Kent è un intellettuale borghese che ha rischiato di autodistruggersi per le droghe, nei maledetti e magnifici anni Settanta, ritrovandosi a emulare lo stile di vita maudit delle rockstar che tanto amava, perdendo il controllo e l'orientamento, e bruciando via via giovinezza e identità: ma è riuscito a vincere la sua battaglia contro la dipendenza e a disintegrare il vizio assurdo, è riuscito a scrollarsi di dosso la negatività dei nichilisti e la ruggine dei clown del “no future”. E così, il giornalista rock che per primo intravide la grandezza del punk, e per primo seppe prenderne le distanze, oggi vive a Parigi assieme a moglie e figlio, lavorando come si deve per un grande quotidiano come il Guardian, collaborando con periodici prestigiosi come “Mojo” e “GQ”. Questa sua autobiografia, ritratto d'un'epoca, è una memorabile cavalcata in un decennio che ha scritto la storia della musica leggera: ma chi s'attende toni agiografici sappia che si sta sbagliando di grosso.
Nick Kent è ben distante dai nostalgismi, e non ha nessuna voglia di mitizzare il passato; al contempo, sa guidarci nei primi giorni di quell'incanto, per mostrarcene l'innocenza e l'ingenuità. Per esempio, così: parlando del 1971. «Era davvero un'età dell'oro per i perdigiorno della classe media come me. Gli studenti ricevevano sovvenzioni. Le migliori band del mondo suonavano ancora in teatri da duemila posti al massimo, e il biglietto per andare a vederle non ti costava un rene. I dischi avevano prezzi ragionevoli. Quando ti andava di viaggiare, fare l'autostop non ti costava niente. Il sesso non era pericoloso». È una manciata di frasi, ma basta per entrare nel mood di quel periodo. Una manciata di frasi basta al signor Kent per raccontarci com'era il ragazzo che sarebbe diventato “Crazy Diamond”, quando ancora aveva coscienza di sé e la sua ispirazione non era stata disintegrata dalle droghe. Syd Barret, 1967. Kent ha sedici anni. «Vedere Syd quella sera ha iniettato dentro di me qualcosa da cui sarei stato ossessionato tutta la vita. Il senso di mistero che proiettava dal palco era qualcosa che sentivo un desiderio travolgente di risolvere». Oppure, incontriamo Mick Jagger e compagni al principio della loro strada. Con una semplicità che sconfina in una credibile naturalezza: «I Rolling Stones la fronte non ce l'avevano. Solo capelli, labbra turgide, e un'insolenza collettiva senza limiti. Stavano indolenti sul palco, a osservare con un disprezzo raggelante la folla, mentre accordavano i loro strumenti. Il presentatore li annunciò in fretta prima di essere sommerso dalle urla. Dopo di che cominciarono a suonare». Erano gli anni di Brian Jones. Nick Kent era minorenne. I suoi genitori non avevano mai sentito parlare della band, ancora. Altrimenti sarebbe stata dura. Meglio così per noi.
Il libro è suddiviso in una decina di capitoli: uno per anno, dal 1970 al 1977, poi 1978 e 1979 assieme, quindi una panoramica su ciò che è capitato più avanti all'autore, infine una magnifica discografia ragionata: una discografia che sembra essere stata ideata per far tornare i lettori nei negozi di dischi sopravvissuti alla deprecabile e sciagurata fortuna degli mp3, per andare a colmare le lacune delle proprie vecchie collezioni di vinili o di cd. Magari si potesse tornare indietro, da questo punto di vista. Addio...
A proposito, qualcuno si potrebbe chiedere perché Nick Kent ha riunito due anni come il 1978 e il 1979 in un unico capitolo: la risposta è semplice. «Per me, gli anni Settanta che contano sono i sei che vanno dalla nascita di Ziggy Stardust alla fine dei Sex Pistols. Ciò che è avvenuto dopo è stato solo il preludio degli anni Ottanta». E l'annuncio della fortuna non sempre gradevole di quello che l'autore chiama “rock da yuppie”. Last but not least, si segnala, nell'edizione Arcana, uno dei refusi più belli e rappresentativi della storia: “straordinario foglio di puttana”. Probabilmente il refuso è stato approvato e incoraggiato dal grande giornalista inglese: ha il sapore di un sottotitolo alternativo per il suo memoir.
**
Veniamo adesso a un robusto invito alla lettura, a partire da tre diversi assaggi. Ci sono parecchie cose che mi sono rimaste impresse, in questa esperienza estetica. Con grande fatica ne ho selezionate tre soltanto. La prima, è la descrizione di Lester Bangs. “Non avevo mai visto una sua fotografia prima di quella notte, così per la prima volta potei associare una realtà fisica all'uomo celato dietro una firma. La mia prima impressione fu che sembrava un clown da rodeo senza trucco. O un operaio della catena di montaggio in pausa per una birra. Era un omone con una massa aggrovigliata di capelli scuri, né lunghi né corti, e dei baffoni che addobbavano la sua sorridente faccia da squilibrato. Non lo avrei definito un bell'uomo, ma non era neanche orrendo. Fin da subito la sua natura gentile mi apparve evidente. C'era una passione in quel tizio, nella sua umanità dispiegata, che era persino palpabile” (p. 97).
La seconda, è il giudizio di Kent sulla morte di Nick Drake e sul suicidio di Ian Curtis. “Scrissi che Drake non si tolse volontariamente la vita, e nulla di ciò che ho letto, visto o ascoltato da allora mi ha fatto cambiare idea. Per come la vedo io, Nick Drake e più tardi Ian Curtis furono le vittime sfortunate di medici incompetenti, che li usarono come cavie inconsapevoli per testare gli ultimi discutibili prodotti delle ditte farmaceutiche. Gli anni Settanta furono il decennio delle nefaste pillole antidepressive. Di punto in bianco, gli apprendisti stregoni del servizio sanitario nazionale si erano messi a prescriverli ai loro pazienti come fosse cibo per gli affamati. Alla fine del decennio migliaia e migliaia di casalinghe inglesi di mezza età si erano trasformate in zombie con attacchi di panico. Fu il risultato dell'aver reso il valium una moda. La fine tragica di Nick Drake era un'anticipazione del loro triste destino” (p. 169).
La terza, è l'analisi del rapporto tra Iggy Pop e le droghe: “Il problema era che a Iggy le droghe piacevano, ma lui non piaceva alla maggior parte delle droghe. L'eroina faceva cagliare la sua personalità, e la cocaina gli istigava disturbi mentali istantanei. I tranquillanti lo lasciavano comatoso e gli eccitanti lo spedivano in orbita verso la pazzia. Eppure lui insisteva, convinto nel profondo di sé che l'abuso di sostanze e il disorientamento cerebrale che innescavano fossero il mezzo per raggiungere l'iggysmo assoluto. Bangs condivideva la stessa filosofia: era un ardente apostolo della scuola di pensiero secondo cui più ti avveleni, più vicino giungi all'illuminazione artistica” (p. 111).
**
Quando ho chiuso il libro, una notte fa, a bordo di un aereo che mi riportava a Roma, mi sono reso conto che avrei dovuto scrivere un pezzo da cinquantamila battute, e non da diecimila, per dare adeguata visibilità alla qualità della scrittura di Nick Kent, e all'incredibile quantità di ritratti fascinosi e seducenti e vivi infilati in questo suo libro. Tornando a casa, nel buio di Roma, ho pensato che più di tutto mi aveva affascinato una cosa, vale a dire quel che scrive Kent sul suo rapporto con la scrittura. Non soltanto quel che scrive sulle tecniche di scrittura, e sulle influenze delle varie sostanze e dei suoi stati d'animo sulla scrittura. Ma non ho, dico davvero, nessuna voglia di scriverne, per nessuna testata, neanche per quella di casa mia. E mi tengo per me ciò che mi ha colpito più a fondo di questo libro, forse perché non può motivare nessuno all'acquisto o alla lettura dell'opera, perché è troppo personale. E allora – obietterà qualcuno – perché il tuo articolo finisce così?
EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE
Nick Kent (1951), giornalista e musicista inglese. Ha scritto per “Times”, “Guardian”, “Mojo”, “GQ”. Vive a Parigi con moglie e figlio.
Nick Kent, “Apathy for the Devil. Memorie dagli anni Settanta”, Arcana, Roma 2011. Traduzione di Carlo Bordone.
Prima edizione: “Apathy for the Devil”, Faber and Faber, 2010.
Approfondimento in rete: WIKI en /
Gianfranco Franchi, marzo 2011.
In cartaceo, questo articolo è apparso sul Secolo d'Italia, in altra e più sintetica forma. Tutti i diritti appartengono al Secolo. A ruota, su Lankelot.
