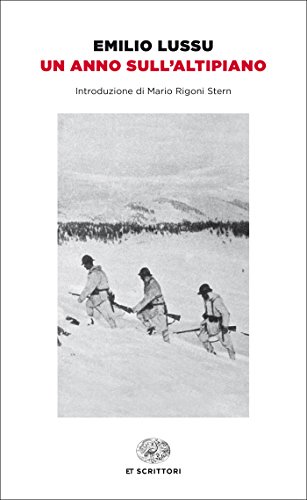 Un anno sull'altipiano
Un anno sull'altipiano
Einaudi
2014
9788806219178

“Un anno sull’altipiano” è un romanzo storico, fondato sull’esperienza autobiografica del tenente Emilio Lussu, ufficiale di fanteria della Brigata Sassari nella Grande Guerra, più volte decorato al valor militare. L’artista, scrivendo a circa venti anni di distanza dall’accaduto, voleva il libro fosse “solo una testimonianza italiana della guerra” (pref., p. 21): appellandosi alla memoria, e non alla fantasia. Scrive Della Corte nell’introduzione: “Sull’Altipiano di Asiago non viene ricostruito, dalla narrazione, solo un anno di affanni, di situazioni tragiche e di assurde meschinità, tali da risolversi molte volte – anche sotto lo schermo della ‘buona intenzione’ o della sfida al pericolo – in un duro aggravamento della tragedia intima alla guerra. Dal giugno 1916 al luglio 1917 accade qualcosa di meno evidente e più radicale: la guerra in quanto strage dà la misura dell’orrore, ma non ancora quella della storia e della sua ‘astuzia’. La quale, nel caso del tenente Lussu, prende un senso esemplare: il giovane è entrato fiduciosamente nel macello, convinto interventista, come tanti suoi coetanei. Ed esce dal conflitto portando dentro di sé, a un grado eccezionale di chiarezza e fervore, idee socialiste” (pp. 7-8)
Al di là della metamorfosi delle idee politiche dell’autore, e dell’eccezionalità di questo suo acquisito “fervore socialista”, quel che può interessare, colpire e affascinare il lettore contemporaneo non ha certo colore politico; ma tinta unica, d’umanità. Perché “Un anno sull’altipiano” documenta la quotidianità della guerra atroce di trincea, contraddistinta da intervalli di vuoto d’un’angoscia e d’una ripetitività traumatizzante, e da improvvisi assalti ad un nemico che non si vede quasi mai negli occhi. Perché si cade prima d’aver raggiunto le sue trincee, o si ripiega in attesa d’un nuovo, allucinante assalto suicida. Lo stile della narrazione è asciutto, sobrio, scarno; puntinato da un sarcasmo e da un gusto per il paradosso che caratterizzano e contraddistinguono l’intelligenza dell’artista. Lussu ha lasciato passare venti anni prima di raccontare quel che aveva vissuto combattendo al fronte: eppure, che sia artificio letterario o attestazione d’una memoria impeccabile (e quindi non umana), la sensazione è quella di sfogliare le pagine del suo diario di guerra, scritte giorno per giorno. Il lettore s’accorge che si tratta d’un’illusoria percezione quando, passando da un capitolo all’altro, nota che gli argomenti trattati sembrano seguire un filo più “aneddotico” e bozzettistico che autenticamente diaristico o memorialistico; la scansione cronologica degli eventi viene rispettata, ma tenendo fede a questa logica “dell’episodio emblematico”, che inevitabilmente compromette e censura giornate sempre uguali, trascorse nell’attesa che qualcosa avvenisse, fosse l’arrivo dell’agognata artiglieria o il congedo d’un generale invasato e macellaio; oppure, selezionando (che è peggio) quel che doveva, e quel che non doveva essere raccontato – per ragioni che non è difficile immaginare.
Si pretende dunque – dal lettore – una capacità di immaginare quel che oggi non più è, fortunatamente, immaginabile. Nel frattempo, si va disegnando un libro che non sembra anti-militarista, ma anti-gerarchico; colpisce come e quanto, progressivamente, il nemico austriaco venga descritto con umanità e comprensione, mentre la politica, le strategie e le tattiche delle più alte cariche vengono fatte oggetto di polemica, irrisione, disprezzo.
La suggestione – a un tratto – si fa nitida: stiamo testimoniando non il libro d’un interventista, ma d’un uomo che ha smesso di credere nelle ragioni che l’hanno spinto a farsi volontario e a combattere per la propria nazione; c’è un Lussu spettrale, che vagabonda tra le pagine del romanzo, apparendo singolarmente più cronista che ufficiale, e un Lussu vivissimo, che dal suo presente (1937) e dall’esilio francese si sovrappone e altera quel che aveva vissuto: ideologicamente, prima ancora che esistenzialmente. Questo elemento non va trascurato: probabilmente, una narrazione autenticamente contemporanea agli eventi avrebbe consentito di considerare questo libro una “memoria”, e non un romanzo. Cosa emerge, in primo luogo, da questo romanzo?
Il cognac. I soldati e gli ufficiali sono descritti come creature aggrappate al liquore per trovare il coraggio d’aggredire il nemico, o di resistere alle brutali condizioni di vita nella trincea. Lo Stato è dipinto come il massimo spacciatore di cognac: sostanzialmente, l’Italia diventa non più Patria, ma madre del cognac per intontire o galvanizzare (dipende dal contesto) i suoi figli al fronte. E questa insistenza sull’alcolico come motore primo della sopravvivenza dei soldati al fronte è l’unica, autentica costante del romanzo: e – sinistra coincidenza – l’unico a risultare estraneo al fascino del liquore è, manco a dirlo, il narratore: l’ufficiale Lussu.
L’insistenza su questo aspetto è tanto eccessiva che, a poche righe dalla conclusione del romanzo, l’autore mette queste parole sulla bocca d’un altissimo ufficiale: «Io avrei dovuto bere anche acqua e molto caffè. Ma ormai, non sono più a tempo. Il caffè eccita lo spirito, ma non l’accende. I liquori l’accendono. Io mi sono bruciato il cervello. Non ho, nella testa, che ceneri spente. Io agito ancora, agito le ceneri per trovarvi un briciolo da accendere. Non ce n’è più. Almeno avessimo ancora neve e ghiaccio. Se n’è andato anche il freddo. Con questo sole maledetto, non vedo che cannoni, fucili, morti e feriti che urlano. Cerco l’ombra come una salvezza. Ma non ne ho più per molto tempo. Addio, capitano.» (cap. XXX, p. 243)
Una guerra combattuta nel nome della nazione, e dell’unità della Patria, diventa una guerra etilica, e tra etilisti: gli stessi austriaci vengono descritti, senza nessuna remora, come alfieri dell’assalto da cognac. Tanto che addirittura l’odore del liquore contrassegna i loro avvicinamenti. Quanto al resto: Trieste è ancora e sempre distante, i soldati rimangono in trincea a sognare il ritorno a casa, a maledire e prendersi gioco dei generali, ad abiurare e rinnegare il sacrificio nel nome della nazione che pure aveva conquistato tanti tra loro; la retorica bellica diventa retorica patriottarda, Lussu fa convergere l’idea della guerra nel nome d’un’idea e dell’unità d’un popolo con quella della guerra savoiarda, badando nel frattempo a eroicizzare i soldati semplici (su tutti, il meridionale “zio Francesco”, cinque figli e scarsa alfabetizzazione, che pare combattere più per spedire denaro alla famiglia che per quelle terre che evidentemente non sente gli appartengano) e a mostrare follia, alcolismo e pressappochismo nei generali.
Si racconta che ci si spara, inavvertitamente, tra italiani; arrivando perfino a catturare prigionieri che si rivelano connazionali un po’ maldestri (ma, al solito, furbastri: prima mangiano cioccolata e bevono vino, poi si rivelano compatrioti); si racconta che si spara da un anno senza aver mai visto in faccia un solo nemico; si riflette che uccidersi senza conoscersi o vedersi, è orribile (p. 50); si descrive, sempre, l’alcool come “benzina”, come primo motore dei combattimenti; si racconta che a volte le trincee vengono scavate con le unghie; che sono spesso improvvisate, senza parapetti o sacchetti di terra. Si descrive la gioia della licenza, e il dramma d’un ammutinamento; si racconta d’un generale che confonde una postazione di mitragliatrici con una latrina.
Lussu rivela cosa sia un assalto. Questo paragrafo, tratto dal cap. XV, mi sembra emblematico. «Di tutti i momenti della guerra, quello precedente l’assalto era il più terribile. “Pronti per l’assalto!” ripeté ancora il capitano. L’assalto! Dove si andava? Si abbandonavano i ripari e si usciva. Dove? Le mitragliatrici, tutte, sdraiate sul ventre imbottito di cartucce, ci aspettavano. Chi non ha conosciuto quegli istanti, non ha conosciuto la guerra. Le parole del capitano caddero come un colpo di scure. La 9° era in piedi, ma io non la vedevo tutta, talmente era addossata ai parapetti della trincea. La 10° stava di fronte, lungo la trincea, e ne distinguevo tutti i soldati. Due soldati si mossero e io li vidi, uno a fianco dell’altro, aggiustarsi il fucile sotto il mento. Uno si curvò, fece partire il colpo e s’accovacciò su se stesso. L’altro l’imitò e stramazzò accanto al primo. Era codardia, coraggio, pazzia? Il primo era un veterano del Carso» (p. 125; si veda, avanti, fino a p. 131).
È una guerra raccontata dal punto di vista dei soldati semplici – parrebbe – senza che il narratore sia stato soldato semplice. È un’altra guerra, diversa da quella che ha combattuto l’ufficiale Lussu. È la guerra del popolo mandato al massacro senza che potesse rifiutare (la leva era obbligatoria per tutti gli uomini), a combattere per una Patria che non sempre, o niente affatto, sentiva come sua, o per un popolo che non sentiva fratello (quando non addirittura estraneo). È la guerra di chi – trovandosi al fronte – s’affratella, nella disgrazia e nella disperazione d’esser vicino alla morte, e sogna la libertà. Bevendo cognac.
Non è la guerra raccontata dalla propaganda di allora, o idolatrata dalla propaganda (o da certa letteratura) contemporanea e successiva: è una carneficina. Privata di senso, ideale e significato, è un macello. Come ogni altra guerra. In fondo, il meccanismo non è complesso: privato d’un significato o della fede in un’idea, tutto diventa diverso. È per questo che avremmo preferito fossero “due” Lussu a raccontare: e non solo l’esule, venti anni dopo. Ma è questione che preferiamo lasciare agli storici: dal punto di vista letterario, il romanzo è ineccepibile; appassiona, coinvolge, “diverte” (si virgoletta a ragione, considerando il sangue realmente versato), emoziona. Ma il “fervore socialista” poteva essere risparmiato – nessun dubbio in proposito. Oppure: avremmo potuto approvarlo, senza la falsa dichiarazione d’apertura di voler raccontare quel che l’autore “aveva visto” e l’aveva “maggiormente colpito” (l’emotività, e la distanza di tempo, intaccano: non sempre, e non solo, schiariscono le idee). Ribadendo che è letteratura, e letteratura fondata sulle memorie d’uno, e d’uno solo, e non Storia, concludiamo invitando alla lettura tutti – con le dovute cautele che il lettore accorto avrà già intuito di dover assumere, evitando di lasciarsi ingannare dai nascosti “fervori”.
EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE
Emilio Lussu (Armungia, Cagliari 1890 – Roma, 1975), scrittore italiano. Fondò il Partito sardo d’Azione nel 1919. Antifascista intransigente, subì delle aggressioni – in particolare nel 1926 (cfr. “Marcia su Roma e dintorni”, Mondadori, 1968). Confinato a Lipari, evase con Nitti e Rosselli nel 1929: assieme a loro, fondò a Parigi “Giustizia e Libertà”. Militò nel Partito d’Azione dopo l’8 settembre 1943, partecipando alla Resistenza. Fu ministro nel governo Parri.
Emilio Lussu, “Un anno sull’altipiano”, Mondadori, Milano 1970. Introduzione di Carlo della Corte. Il romanzo fu scritto in Francia, nel sanatorio di Clavadel, sopra Davos, tra 1936 e 1937. L’autore era convalescente da una delicata operazione chirurgica.
Salvemini domandava, sin dal 1921, la scrittura del “libro” sulla Grande Guerra al suo vecchio amico. Fu accontentato sedici anni dopo.
Prima edizione: Edizioni Italiane di Cultura, Parigi, 1938.
Italia: Einaudi, Torino 1945. Dal libro, è stato tratto il film “Uomini contro” di Francesco Rosi, con Gianmaria Volontè (Ita-Yug, 1970).
Gianfranco Franchi, settembre 2004.
Prima pubblicazione: Lankelot.
