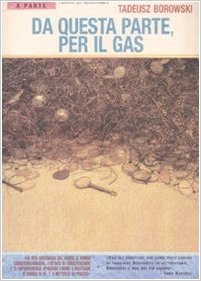 Da questa parte, per il gas
Da questa parte, per il gas
Ancora del Mediterraneo
2008
9788883252440

Vittima del comunismo durante l'infanzia, del nazismo nella prima giovinezza, del comunismo, infine e una volta ancora, poco prima del suicidio (ventinovenne), Tadeusz Borowksi è il paradigma del letterato martire.
Un martire polacco dei regimi totalitari del Novecento. La tragedia della famiglia Borowski ha radici antiche. Il clan veniva dalla città ucraina di Zhytomyr, ex regno polacco-lituano, una delle cittadine più popolate da polacchi, extra-confine, famosa per un grande cimitero cattolico, edificato nel 1800 (si tratta del terzo cimitero polacco più grande in Europa, dopo quello di Vilnius e di Leopoli). I Borowski, polacchi d'Ucraina, patirono le atrocità del regime socialista sovietico. I comunisti nazionalizzarono la libreria del padre nel 1926; quindi, lo costrinsero prigioniero nel gulag di Karelia. Il figlioletto, a 4 anni, stava per perdere anche la mamma: venne arrestata e imprigionata in un gulag siberiano, pochi mesi dopo. Senza nessun senso, nessuna ragione, nessuna motivazione. Mosca aveva decretato, punto. Eseguire!
Soltanto nel 1932 e nel 1934 gli assassini sovietici avrebbero restituito all'ormai adolescente Tadeusz i suoi genitori, ma in un'altra terra: la Polonia. Quei buontemponi armati di falce e martello la chiamavano “ingegneria sociale”. Presto sarebbero stati sostituiti da altri pazzi, meditando di spartirsi le rovine della Polonia. Non senza aver massacrato, a Katyn, 22mila cittadini polacchi: per ordine di Stalin, tutti i prigionieri di guerra andavano sterminati. Soprattutto gli ufficiali: si trattava di giovani laureati, si trattava della futura classe dirigente. Andava decapitata. Era il 1940. Lavorarono giorno dopo giorno, dal 3 aprile al 19 maggio, fermandosi soltanto il primo maggio. Santificate le feste, continuarono a freddare con un colpo alla nuca i “nemici”. Uno dopo l'altro. E poi via, nelle fosse comuni. La verità venne rivelata al mondo – con qualche imbarazzo – solo nel 1989. Attualmente, Russia e Polonia discutono la natura dell'accaduto. Genocidio? Chissà. Sta di fatto che Borowski sarebbe risultato sgradito al regime socialista sovietico, post guerra, proprio per aver fatto riferimenti a quei massacri, che andavano nascosti o almeno imputati ai nazisti. Con stile tutto bolscevico.
Il giovanotto studiò a Varsavia. In istituti clandestini: il Reich aveva proibito ai polacchi di accedere a un'istruzione superiore. Le sue sofferenze non erano affatto terminate. Il nazismo pretendeva un tributo. L'intellettuale e scrittore Borowski, reduce dalla pubblicazione clandestina del libro di poesia “Gdziekolwiek Ziemia” (“Wherever the Earth”), si trovò a vivere le esperienze atroci dei campi di concentramento: Auschwitz e Dachau. Nel frattempo, la sua amata compagna, Maria, viveva esperienze analoghe. Sopravvisse – e in questo libro vedremo come, e come ne uscì psichicamente – e si ritrovò a vivere nuovamente sotto regime. Comunista, sovietico. Atroce. Qualcuno si domanda perché questo ragazzo si sia ammazzato. Risponde la coscienza di ognuno di noi.
Torniamo alla sua biografia. A quel punto della sua vita scriveva in prosa, convinto che non avesse più nulla da dire in versi. Che forse scrivere in versi non avesse più senso. Dopo un periodo di iniziale adesione al socialismo, quando si trovò a testimoniare le violenze, le menzogne, la propaganda e le torture dei comunisti, disilluso e sconvolto, convinto che i sovietici non avrebbero mai impedito future Auschwitz, crollò psicologicamente. Al contempo, una sua relazione extraconiugale faceva vacillare il matrimonio con Maria. Al secondo tentativo riuscì a suicidarsi, barbiturici e gas. Proprio quel gas che aveva evitato nei lager nazisti. Paradosso, o forse dannazione. Tragica predestinazione. Difficile trovare un termine adatto.
Questo libro, raccolta di dieci racconti originariamente titolata “Addio a Maria” (1947), oggi – sulla scia delle edizioni inglesi, con l'inclusione delle prose apparse in “Mondo di pietra” (1948) – diventa “Da questa parte per il Gas”. Probabilmente un titolo più feroce e incisivo rispetto a un altrimenti equivocabile e sentimentale saluto a una donna. Senza dubbio, un titolo non deciso dall'autore. Il libro appare per la prima volta in Italia grazie alle pregevoli edizioni dell'Ancora del Mediterraneo, in una raccolta curata da Giovanna Tomassucci. È letteratura concentrazionaria considerata un classico in Polonia, amata da artisti come Milosz (vecchio amico di Borowski) e Kertész. Diceva Todorov: "La norma inderogabile di Borowski è che si possa scrivere su Auschwitz solo se si è capaci di assumersi le peggiori umiliazioni che il lager ha inflitto ai detenuti. In tal modo egli ha compiuto una nuova scelta, un nuovo atto morale".
Il primo racconto, l'eponimo “Addio a Maria”, è una forte testimonianza d'uno stile iperdescrittivo, lirico, eccezionalmente aggettivato e visivo. Soltanto nell'incipit, ecco “nubi turgide spinte dal vento” e una casa bruciata che nereggia, mentre incontriamo violacei riflessi della luce di un lampione. Un albero spoglio contro un cielo turbinoso, “avviluppato da pennacchi lattiginosi”. Borowski aveva smania di nominare e descrivere tutto, senza lasciare spazio all'immaginazione del lettore. Era un'urgenza. Qualcosa s'era impresso a fuoco nella sua memoria, e andava nominata precisamente.
Trama: Maria sta leggendo, e intanto osserva che nel mondo non più esiste altro che non siano loro due. Lei e Tadeusz. Parlano di poesia (“Solo la poesia riesce a mostrare l'uomo com'è (...), nella sua integrità”), e della comprensione delle cose della vita: se fosse perfetta, dominerebbe l'amore.
La scena passa a includere amici della coppia, e più avanti incontri con lavoratori e cittadini affranti. Si sentono discorsi sulla religione, sul Cristo disertore o combattente, sulla capacità della poesia e delle illustrazioni di superare la guerra, di sopravvivere nel futuro; sui nuovi ghetti in costruzione (senza via di scampo). L'atmosfera si fa man mano plumbea. “Deportazione” è la parola che spaventa e angoscia. Più della crisi economica, della recessione, della guerra. “Se la prenderanno con noi come hanno fatto con gli ebrei?” - si domandano gli amici di Tadeusz. Ortodossi, sotto tiro dei nazisti. Le retate si ripetono, soffocando le esistenze di tutti. Maria non torna. Maria non può tornare: è stata caricata su un autocarro, perché “mischling ariano-semita”. Borowski dice, nella finzione narrativa, che è finita in una camera a gas, trasformata poi in sapone, ma non è vero: la soluzione del racconto è un'invenzione. Un incubo, un esorcismo. Non so dire. Maria si salvò, grazie a Dio, superando indenne la prigionia nei campi e una terribile polmonite; quando suo marito si suicidò, nel 1951, aveva appena dato alla luce una bambina. Sicuramente sorte simile avranno avuto altri amori polacchi, e in questo senso l'autore interpreta la loro triste sorte. Non mi sento di criticare un epilogo comunque plausibile.
Ecco “Da noi ad Auschwitz”: strutturato come una lettera a Maria, intriso di nostalgia del corpo di lei e della loro intimità, del suo profumo, della sua vestaglia rossa, della loro casa. Della perduta perfezione, cristallizzata nella memoria. L'io narrante pensa di poter morire, ma sente che di sé rimarranno l'amore e la poesia, e il ricordo tra gli amici. Racconta del corso sanitario, a Birkenau, destinato a quei prigionieri che cureranno i malati; e del successivo trasferimento in Auschwitz. Al bracco ha il triangolo rosso, il Winkel dei prigionieri politici. Descrive la condizione e la sorte degli internati, ci introduce a un termine di incerta (?) etimologia, “musulmano”, che indicava i deportati giunti all'ultimo stadio della resistenza fisica, “fantasmi senza energia e volontà”. Descrive il Puff, la “joy division” della terribile prostituzione coatta delle deportate; racconta del granaio dipinto di bianco dove asfissiano la gente. Non evoca il male, perché sa che sta sprofondando nel male. Al male non c'è rimedio. Il male è anche la mascherata, l'inganno che da fuori viene percepito; raccontando che nel campo suonino orchestre, che si tengano incontri di pugilato, che non manchino le coperte... non sono menzogne, ma nascondono le atrocità che quotidianamente si ripetono. “Non c'è alcun Bello che implichi un torto sull'uomo – insegna il perduto scrittore ucraino-polacco – né alcuna verità che sottaccia quel torto. Né un Bene che lo permetta” (p. 82).
Borowski riesce nel complesso compito di raccontare cosa sia la speranza, in quei giorni: qualcosa di diverso da quel che potremmo attenderci. Terribile: “È proprio questa speranza che fa andare con inerzia alle camere a gas, che la trattiene dal rischiare la rivolta, la fa sprofondare nel torpore. È la speranza a spezzare i legami famigliari, spingendo le madri a rinnegare i figli, le mogli a prostituirsi per un tozzo di pane e i mariti ad ammazzare. È la speranza che li fa lottare per un giorno di vita in più, perché forse la liberazione giungerà proprio quel giorno. Ah, dopotutto non è nemmeno più la speranza in un mondo diverso e migliore, ma semplicemente quella in una vita in cui ci sia pace e riposto. Mai, nella storia dell'umanità, la speranza è stata più forte dell'uomo, e mai essa è stata causa di tanto male quanto in questa guerra, in questo campo. Nessuno ci ha insegnato a disfarci della speranza, per questo moriremo nelle camere a gas” (pp. 71-72). Il male diventa falso e grottesco. Come la tecnica di accensione del fuoco nel camino, a sentire un soldato tedesco. Prendere per i capelli quattro ragazzini, unire le teste e dare loro fuoco. Ecco, il male adesso ha sporcato per sempre il Novecento. Niente lava le coscienze e la memoria. Siamo contaminati.
Terzo racconto è “Una giornata ad Harmenze”, nei pressi di Birkenau. Si lavora sulle rotaie. I prigionieri soffrono la fame, e mentre si sostengono e si sfogano come possono, parlando una sorta di esperanto, tra stranieri costretti alla convivenza sotto bastone nazista, s'angosciano pensando al forno crematorio. Qualcuno si consola pensando che un giorno arriveranno i bolscevichi (certo: dal lager al gulag. Chiamatela “Liberazione”). Si spia – accidentalmente, avanzando per Harmenze – la normalità delle fattorie e delle piccole case tedesche. Chi è troppo generoso e cede la propria zuppa viene punito: digiunerà il giorno dopo. Altri domandano qualcosa da mangiare per un'ultima cena prima del camino. E nemmeno riescono più ad arrampicarsi sulle brande.
Ecco il racconto che ha dato il titolo all'edizione italiana e a quelle inglesi: “Signore e signori, da questa parte per il gas”. Uomini e donne nudi per il campo. Ammassati per le strade, all'ombra dei muri e dei tetti. Nelle cuccette, altrove, odore terribile di sudore e di escrementi. È un incubo.
Altrove. Vagoni merci trasportano pallide facce sgualcite, terrorizzate. Sfilano lentamente. Gridano acqua!, aria!, invano. Sono quelli che andranno al gas. L'unica forma di pietà che conoscono nei lager è ingannare sino all'ultimo chi verrà assassinato. Una morte collettiva, dice Borowski, ignominiosa, ripugnante. Chi finisce gasato non diventa nemmeno cenere. È una nuvola di fumo che sale sino al cielo. Questo racconto è un incubo, neonati malati o morti a fianco di madri ormai disumanizzate, anime smarrite, corpi svuotati; intanto, truppe naziste marciano, minacciando il futuro del mondo. Inquinandolo.
“La morte dell'insorto” è un'altra cupa cronaca di sopravvivenza e di resistenza al male, di nostalgia della perduta quiete, di rabbia e di dolore. Di indigestioni da verdura in corpi distrutti, piegati dalla denutrizione. “La battaglia di Grunwald” è la grottesca storia della fine d'una giovane uccisa dagli inglesi: la liberazione è avvenuta, ma la malasorte non ha abbandonato certi deportati del campo. Infine, ecco “Il mondo di pietra”, prosa breve. È una breve meditazione sul presente d'un narratore sopravvissuto all'orrore, finalmente sposato, tutto teso ad ascoltare i rumori della strada, il suono della recuperata normalità. E poi, tutto a un tratto...
“Mi allontano precipitosamente dalla finestra, come per strappare via un laccio che mi ostacola nei movimenti, mi siedo alla scrivania con la sensazione di aver di nuovo perso irrimediabilmente tempo, estraggo dal fondo del cassetto fogli a lungo abbandonati e – giacché per oggi il mondo non si è ancora dissolto – tiro fuori dei fogli bianchi che sistemo con pedante solerzia sul piano: socchiudendo gli occhi cerco di scovare in me affetto e amicizia per gli operai chini sulle rotaie del tram, per le donnette di campagna con la loro panna adulterata, per i treni merci, per il cielo che si fa più scuro sopra le macerie, per i passanti sul viale e per i nuovi infissi, per mia moglie che asciuga i piatti: (...) inizio a desiderare di essere in grado di cogliere il senso delle cose, degli avvenimenti e delle persone che ho visto” (p. 228). Infine, s'annuncia il desiderio di scrivere un'epopea su questo mondo imperituro, scolpito nella pietra.
“La morte di Schillinger” è la vicenda d'un ex sergente maggiore SS di Birkenau, feroce e spietato, ucciso in circostanze misteriose. Una voce accreditata voleva fosse stata una donna che stava corteggiando poco prima che venisse gasata; l'atto aveva originato una ribellione degli ebrei, terminata nel sangue. Poche mitragliatrici erano bastate. Infine, “Silenzio”. Un ufficiale americano parla agli ex prigionieri. Promette loro giustizia, assicura che in futuro la legge prevarrà sull'arbitrio. Domanda di evitare vendette personali. Inutile: i prigionieri stanno pestando un kapò.
Un libro fondamentale per restituire attenzione al dramma del popolo polacco, mai adeguatamente indagato; per restituire dignità e centralità europea a un narratore che ha avuto il coraggio di tornare nell'incubo, senza riuscire a liberarsene, rivelando e trasfigurando le sue memorie; per non dimenticare i lager, i gulag, l'assurda malvagità nazista e comunista. Per un'Europa libera e democratica. Capace di risorgere dalle ceneri d'un secolo sporco di sangue, e di menzogne. Per un'anima d'un ragazzo che s'è ammazzato a ventinove anni. E non ha scritto perché.
EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE
Tadeusz Borowski (Zhytomyr, Ucraina, allora URSS 1922 – Varsavia, Polonia 1951), poeta, scrittore e giornalista polacco, sopravvissuto ad Auschwitz e Dachau. Esordì pubblicando (clandestino) il libro di poesia Gdziekolwiek Ziemia (Wherever the Earth) negli anni Quaranta.
Tadeusz Borowski, “Da questa parte per il gas”, Ancora del Mediterraneo, Napoli, 2009. A cura di Giovanna Tomassucci. Traduzioni di Luca Bernardini, Valentina Parisi, Giovanna Tomassucci.
In appendice: nota editoriale; glossario dei termini del linguaggio in uso nei lager nazisti; dizionario essenziale dei personaggi storici e fantastici nominati; una nota sull'autore e sull'opera.
Prima edizione: “Pożegnanie z Marią”, 1947. Nelle parole dell'autore, “Addio a Maria” è un “viaggio al termine di una certa morale”. “This Way for the Gas, Ladies and Gentlemen (Proszę państwa do gazu)”, Penguin Books, London, 1992.
Gianfranco Franchi, gennaio 2009.
Prima pubblicazione: Lankelot.
