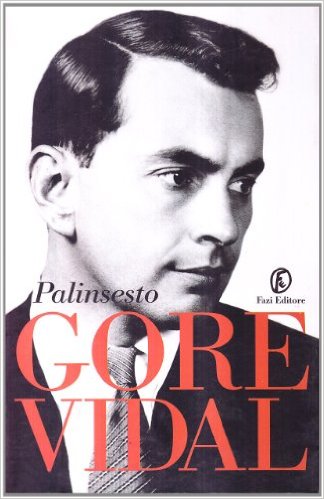 Palinsesto
Palinsesto
Fazi
2007
9788881128358

Ravello, Golfo di Salerno: il dixie ribelle, apparentemente contrario all’imperialismo yankee come il nonno senatore, scrive il suo memoir. E talvolta è come se stesse raccontando un’altra storia a quel nonno cieco, che amava ascoltare le sue letture. Vidal ha un pubblico diverso, rispetto a quei giorni. Ma non ha smesso di raccontare, mai. E così, qui mescola politica, letteratura, memorie d’infanzia e d’adolescenza, gossip e amarcord, romanzo sentimentale e puttantour a Roma. E i ciechi, che ascoltano soltanto e leggere a volte non sanno, siamo noi. Vedremo. “Ho appena cercato il significato principale di palinsesto. Si presta ancora più di quanto non credessi: ‘Foglio di carta, pergamena ecc., preparato per la scrittura e poi cancellato come una lavagnetta’ e ‘Una pergamena ecc. che è stata scritta due volte, dopo è che stata cancellata la scrittura originale’. Questo è quello che praticamente fa il mio genere di scrittore. Comincia con la vita; crea un testo; poi una re-visione, letteralmente una seconda visione, un ripensamento, cancellando qualcosa, ma non tutto, dell’originale, mentre riscrive qualcosa sopra il primo strato di testo. Alla fine, in un libro di memorie, ci sono molte cancellature e aggiunte (…)” (Gore Vidal, “Palinsesto”, p. 11).
Memoir di Gore Vidal, “Palimpsest” (1995), ideato e composto tra 1993 e 1995, è come la degustazione verticale d’un grande vino: ecco diverse annate dell’esistenza d’un intellettuale e d’un artista americano atipico, proposte in sequenza. Al termine della lettura non dovremo, tuttavia, comparare diversi periodi della vita dell’autore di “Giuliano” per decidere qual è stato il momento migliore. Perché questo figlio di West Point, classe 1925, ha acquisito abbastanza distanza dal passato: e in ogni caso non avrebbe senso apprezzare le qualità di annate tanto distanti. Perché spesso sono due vini totalmente diversi. Andiamo in verticale. Gore, adesso, non vuole niente (p. 196): ma tutto ha avuto.
Posso raccontare la mia esperienza di lettore, senza pretesa di verità. Sono testimone. Dico che la stagione più intensa è quella del suo immortale amore per Jimmie Trimble; è irripetibile, ed è quel che rimarrà nel tempo. Le altre saranno tramandate e interpretate con diverse finalità: diaristiche, sociopolitiche, cronachistiche; come regolamenti di conti in ambito letterario, e come favolosi pettegolezzi (cfr. l’acqua di colonia di Mussolini…).
Naturalmente, non nascondo il mio perplesso dissenso nei confronti dei pettegolezzi; onestà intellettuale impone comunque di segnalare che in queste pagine incontrerete e apprezzerete, in salsa Vidal, apparizioni più o meno robuste di una ricca galleria di personaggi. Dal mazzo pesco JFK, Truman Capote, Tennessee Williams, Calvino, Calasso, Allen Ginsberg, “Fred” Fellini, Jack Kerouac, Paul Newman, Marlon Brando. A volte si tratta di rapidi saluti e omaggi (Calvino, Calasso), altre volte di retroscena sulle rivalità (Capote, Anais Nin), di campionature di vari aneddoti (l’amico Williams; il vecchio Santayana), di nostalgiche memorie di millantate avventure sessuali (Kerouac). Ne emerge e ne deriva il ritratto di un tempo, come probabilmente l’autore poteva auspicare; d’un tempo e d’una società letteraria perdute, d’una diversa percezione dello Stato Americano e della vita politica, d’uno straripante orgoglio omosessuale. Che davvero predomina e determina l’opera.
“Poi andai a Parigi, e alloggiai al Pont Royal Hotel. Sartre e De Beauvoir tenevano corte al bar sottostante: i turisti li avevano cacciati dal Café Flore. Adesso, alla fine del secolo, mi risulta difficile credere di essere vissuto in un’epoca in cui gli scrittori erano figure universali per quello che scrivevano, e che le loro idee erano note addirittura all’eterna grande maggioranza che non legge mai. Il mondo era molto attento a Sartre e Camus, e la gente si schierava nei loro duelli. Gide e Mauriac, il mio preferito, De Montherlant, erano come oracoli che andavano consultati” (p. 190). Attenzione: l’autoritratto – differito – è memoir e non autobiografia. La distinzione non è così sottile: significa che Vidal non voleva scrivere un documento storico: questa è opera letteraria. Tenetelo bene a mente.
Le cicatrici del palinsesto fanno capolino, come l’autore annunciava in ouverture. Con esperienza e un pizzico di malizia: “Ora faccio irruzione su me stesso. Che direzione sta prendendo questo racconto? D’un tratto apprezzo il valore della narrativa consapevole, dove il protagonista, se non altro nella testa del suo creatore, si muove verso un obbiettivo o un capolinea previsto. Ma in questo testo io non mi sto muovendo verso niente di cui sia consapevole, e la flora e la fauna che osservo lungo il percorso cominciano a sembrare un po’ a caso e incoerenti e troppo simili alla vita (…)” (p. 192). La scrittura è ancora come un tempo, torrenziale e “realistica”, in uno stile che l’autore definisce “piuttosto semplice” (p. 129) e – cautela… - “incline ad essere veritiero”. Che errore. Ma va bene così.
Vidal sosteneva di apprezzare la pornografia solo come finzione; difficile credere che non abbia mentito affatto, in queste pagine. Perché memorie di avventure sessuali non mancano davvero: nemmeno numeri garibaldini (oltre 1000 incontri sessuali già nel 1950) che lasciano piuttosto interdetti (p. 140).
E proprio nell’incipit, con disinvoltura, s’accenna a un ordito di menzogne, perché gran bugiardi erano i personaggi protagonisti (Kennedy in primis: p. 123). Bene: tutte queste spie dovrebbero aver allertato il lettore; il narcisismo del bugiardo lo spinge, regolarmente, a lasciare tracce delle menzogne. Del resto, con buona pace di tutti, è soltanto Letteratura. Mille e non più mille, Gore Vidal.
La ragione è romantica? Voglio crederci. Scelgo la grande causa, Jimmie Trimble. Vidal non ha mai dimenticato il suo perduto amore, caduto al fronte in guerra, giovanissimo e splendido. Ne parla come dell’altra metà perduta per sempre (p. 42), e quel che scrive è universale, e perfetto: “Così, fummo una sola cosa, per quella che si rivelò per entrambi l’ultima volta – e per me, se non per lui, per sempre. E non solo non ho più incontrato l’altra metà, ma quando arrivai all’età di venticinque anni avevo abbandonato ogni ricerca, accontentandomi di mille brevi congiungimenti anonimi, come direbbe Walt Whitman, nei quali la totalità sembra, per un attimo, raggiunta. Ed è più che abbastanza, credo, se lo scopo è stato raggiunto. Almeno una volta, in termini platonici, avevo completato me stesso” (p. 42).
Jimmie è stato “l’opera incompiuta” della sua vita (p. 29); “Non c’era colpa, né sensi di tabù. Ma del resto ci trovavamo nell’Arcadia, non nel diabolico Eden” (p. 38); “Non ho mai avuto storie con nessuno. Sesso, sì. Amicizia, sì. Le due cose combinate? No. Jimmie, naturalmente, era qualcos’altro: era me” (p. 188).
Assieme, si celebrano i giorni delle prime pubblicazioni: dall’esordio, “Williwaw”, per il convenzionale “In a Yellow Wood”, sino alle polemiche, agli ostracismi e al boicottaggio per la “La statua di sale” (fondato su un “incrocio di generi”: e sull’amore gay): e all’attività artistica sotto pseudonimo. Intanto, dodici anni di scuola, tre di esercito, sei mesi nell’ufficio di un editore. Assieme, si ricostruisce il dna d’una famiglia d’antiche e quasi rimosse origini italiane (friulane), probabilmente ebraiche (nessuna testimonianza pre-trecentesca: p. 454), senza dubbio dixie e impegnata coraggiosamente in politica; aristocrazia dixie, attenta all’immagine, populista, economicamente fortunata. Gente che badava ai matrimoni (nonno Gore disse “non essere fecondo, non moltiplicarti”, sbaragliando la povera giovane compagna di Vidal) e non frequentava negri. L’autore non lo nasconde, quello era il background. D’altra parte, negli USA, nel 1957 mancava spesso il bidet, nelle case: la civiltà è una conquista progressiva. Così l’umanità. Ma Vidal si leva diversi sassolini. Uno dei più taglienti è rivolto al padre; probabilmente omosessuale come lui. La vicenda – curiosa matrioska – è raccontata tra p. 156 e p. 160, e vede protagonisti, a ruoli invertiti, uno scrittore e un atleta. Stavolta l’atleta è Gore padre. Menzogna o meno, psicologicamente interessante.
L’America raccontata da Vidal – filtro dixie – è memoria della Dottrina Monroe (pp. 70-71), quella splendida e disattesa sacra carta abiurata da Wilson nel 1917 (significa: principio della fine dell’autonomia europea), dello sterminio dell’originaria popolazione mongola, della “singolare istituzione” della schiavitù. È memoria della più grande “invenzione di Wilson”: la Jugoslavia, ovviamente. Sempre a firma yankee. È memoria dei tempi della Union Fruit, del controllo esercitato su tante nazioni, dal Guatemala alla Norvegia, sino – eccoci – alla nostra Italia. Nota molto dolente dell’opera: Vidal fa a pezzi Roma. E sparge sale. Mantiene viva e splendida la misera Roma del dopoguerra, raccontando delle marchette facili e delle strade deserte di macchine. È tra quegli americani che sbarcano, da padroni (per sua ammissione, ignoranti di Roma), nel 1948. E i toni sono saccenti, arroganti, sbagliati. Sbagliati. Come qui: “Gli italiani avevano cominciato a rimettersi in sesto, dimostrando ancora una volta la loro sorprendente capacità di reagire al disastro, così perfettamente bilanciata dalla loro incapacità di trattare con il successo” (p. 170): che è un concetto che richiederebbe ondate di chiarimenti, di precisazioni, di puntualizzazioni, per quanto è antistorico e poco pertinente (a quali “italiani” si riferisce? A quelli vissuti tra 1861 e 1943? It’s not so easy, Gore Vidal. Che politica stai facendo? Per chi semplifichi le cose? A che pro?).
Del resto, ecco il boom economico secondo Vidal: il sesso libero in uno Stato povero e sconfitto. “Ogni sera centinaia di ragazzi convergevano al Pincio per prendere accordi con le persone interessate. La droga era ancora campo di pochi, principalmente artisti; c’erano i furti, ma non la violenza. Non c’era l’AIDS, e il sesso era spontaneo e spensierato (…) splendide orge, di solito fra le otto e mezzanotte (…)”. Quindi, non volendo creare false aspettative tra gli atleti sessuali americani, si sbriga a dire che “La Roma di oggi è cupa, dall’aria mefitica, piena di ogni sorta di crimine (…) la prostituzione è molto costosa e asettica (…). Ma nel 1961, quando decidemmo di prendere un appartamento vicino al Tevere, Roma era, nel suo modo grave e discreto, un paradiso sessuale” (p. 438). Bene. Americano.
Se considerate che, agli occhi degli yankee, questo signore è un anti-imperialista, assieme a Chomsky, potete avere un’idea di cosa significhi essere intellettuali statunitensi ribelli al regime. Non è difficile, basta essere lievemente in disaccordo. L’imprinting è questo: quest’aria odiosa e allucinante di superiorità, questa capacità di umiliare gli Stati sconfitti e occupati – militarmente, economicamente, culturalmente – trattandoli come bestie al guinzaglio dello Zio Sam. Come animali da monta.
Vidal è vissuto per tanti anni a Roma, prima di conquistare il buon ritiro di Ravello (infine, prima di tornarsene a casa). Possibile che questo sia il volto intelligente del nemico “liberatore”, che ha distrutto un regime per imporre uno stato vassallo e fantoccio? Direi di sì. È anche questo. Non mi aspetto niente di diverso. Un ricco esteta, un raffinato intellettuale che viene a scoparsi i nostri ragazzi e le nostre ragazze, trattandoci come schiavi, e che peraltro si lamenta che i tempi sono cambiati…? Non ci siamo. Rispetto al resto dell’opera, questi passi sono molto deludenti, e umilianti. Per noi romani, e per Vidal. Potrei replicare sullo stesso tono. Dovrei. Mi tengo, invece, il sasso in bocca e prendo nota. Altro passo vigliacco: “Sono pochissimi i giornalisti italiani che parlano inglese – la lingua che io fermamente uso con loro – e pochissimi quelli che conoscono il mondo fuori dall’Italia. La ricerca, persino quella di un genere molto primitivo, non si sa cosa sia (…)” (p. 368). Vigliacco, decisamente. Ma i giornalisti italiani avranno letto il libro? Dico di no. Non fino in fondo. Non sarebbe una novità.
Vidal è figlio di una nazione troppo giovane, e con troppo potere. Ecco i risultati. L’arroganza, la codardia, l’oltraggio, la diffamazione. Questo – ribadisco – è un intellettuale quasi salutato come comunista, in patria. Ma per carità. Questo è un dixie evoluto: è uno yankee di minoranza, perché legge e scrive libri, e non è nato dalla piccola borghesia. È uno Svetonio… un cortigiano dell’Impero. Che da cortigiano ribelle scrive, ma cortigiano rimane. Sempre. Ne ha l’odore, dell’americano, e quell’odore l’Italia non glielo poteva lavare via, neanche nella monta, e nella monta ripetuta. No. Quell’odore vi rimane addosso, pure quando scrivete.
Quanta (ridicola) decadenza, oggi, Vidal trova in Roma Centro: “I prezzi esorbitanti e l’aria inquinata hanno svuotato la città non solo dagli stranieri, ma anche dei poveri e di gran parte del ceto medio. Solo i ricchi e l’onnipresente governo risiedono nella Vecchia Roma, di notte una specie di quartiere spettrale” (p. 458). Una caratteristica dell’Italia? I lavori in casa: “infiniti”, p. 166: “nessun lavoro viene portato a termine (…) relazione eterna e spesso irritabile tra artigiano e committente. Per l’artigiano, un lavoro finito è come una tomba finita per il faraone”.
Non si glissa sui colpi bassi, e qui Vidal ne ha sparati tanti. Non solo a Truman Capote. È un gioco? Giochiamo. Uno a uno. Oh yankee doodle keep it up, yankee doodle dandy…
EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE
Eugene Luther Gore Vidal (West Point, New York, USA 1925 – Hollywood, California, 2012), saggista, sceneggiatore e romanziere americano. Vive a Hollywood Hills. Debuttò pubblicando “Williwaw” nel 1946.
Gore Vidal, “Palinsesto”, Fazi, Roma 2000. Traduzione di Maurizio Bartocci. Progetto grafico di copertina: Maurizio Ceccato.
Prima edizione: “Palimpsest”, 1995.
Gianfranco Franchi, settembre 2007.
Prima pubblicazione: Lankelot.
