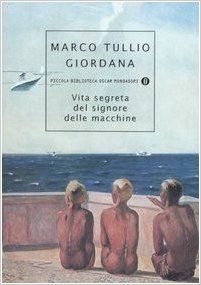 Vita segreta del signore delle macchine
Vita segreta del signore delle macchine
Mondadori
2005
9788804544418

Storia di x, trentotto anni, alias Nicolò Maineri, trentaquattro anni. Nelle prime battute sta in aereo, a fianco del suo amico giudice. Il giudice è uno che ha bisogno di un'iniezione di morfina ogni otto ore. Nicolò sente mancanza di sua figlia, Ginevra, cresciuta e allevata dalla mamma. Manca poco a Caracas. A Caracas c'è un altro che ha cambiato nome, adesso è Ricardo. Prima era un brigatista rosso, e prima ancora un antico compagno – in tutti i sensi – di Nicolò. Adesso è uno da giustiziare. Come tutto il passato di quella generazione, che si sente fallita e si vuole autodistruggere. Ma non ne ha il coraggio, a ben guardare.
Nicolò viene da una buona famiglia borghese, ricca possidente lombarda, d'antica tradizione. È convinto che la buona borghesia meneghina non sia asburgica o napoleonica, né mitteleuropea: è “l'eco di un'anima visionaria e di un ego ipertrofico continuamente tormentato dalle mortificazioni della Controriforma e dall'ectoplasma di san Carlo Borromeo. Di tutte le dominazioni subite – continua – è stata quella spagnola a identificare con maggior precisione le ubbie punitive del genius loci, incidendo col suo bulino pessimista gli arabeschi dell'orgoglio, della voluttà di dominio e di martirio, il sentimento doloroso della elezione e della diversità” (p. 28).
Ha due sorelle, Benedetta e Virginia, rimaste fedeli al dna del casato; una vive a Torino, l'altra a Roma. Ha perso suo padre, imprenditore ex partigiano, quando aveva soltanto nove anni, restando combattuto a lungo tra vergogna e rimorso. È cresciuto come l'unico maschio di casa, viziato e coccolato, felice di avere tante donne per casa – soprattutto, tante amiche delle sorelle. S'è divertito parecchio. Poi è arrivato il Sessantotto, le cose sono migliorate ancora. Ha civettato con la rivoluzione, come “tutti quelli della mia generazione”, scrive. Ha militato in un gruppuscolo estremista e dogmatico, presto evaporato come uno sbuffo di polvere. E proprio mentre il movimento si incanagliva “nei primi cupori violenti”, ha preso ed è andato a studiare in Inghilterra e negli Stati Uniti. Al suo ritorno non c'era più concorrenza e lui era diventato in un attimo numero due dell'Ospedale.
S'è sposato con Ottavia, sua simile ma diversamente ribelle. È stato libero amore, non grande amore. Lei era una che amava le foto, ma a un tratto aveva cambiato soggetti, mostrando “i casermoni immensi delle periferie, il mattonato cirrotico di vecchie case in abbandono, i cortei turbolenti e lugubri degli anni Settanta, così diversi dalla soave illegalità del decennio precedente” (p. 31). Chiaro che crescendo sarebbe maturata e passata a “Vogue”, è stato il percorso di quasi tutti loro. Non c'è niente di male.
I due si separano presto, ma rimangono amanti. Lei rimane incinta. Nasce Ginevra, cresce bene con la mamma. Nicolò adesso ha trent'anni, vive tranquillo, s'è dimenticato la politica, guida una Aston Martin come James Bond. Ma un giorno, proprio come in 007, s'accorge che c'è una sobria e anonima Alfetta che lo sta seguendo. È la polizia. È il suo passato. Un suo vecchio compagno, politico e di scuola, giudice, gliel'ha messa alle costole. Perché? Anni prima, lui, il giudice e un gruppo di giovani, come il futuro assassino Mario Fano, avevano occupato una fabbrichetta, con tanto di manciata di giorni di galera. Ci si conosceva bene, allora. Poi tante cose erano cambiate. Pochi giorni prima, in un covo di terroristi, la polizia aveva ritrovato documenti e armi. Tra i documenti c'erano lettere di quindici anni prima. Le aveva scritte lui, Nicolò. Ma aveva rimosso tutto. C'è un perché.
Lui e Mario Fano, coetanei, s'erano conosciuti a diciott'anni, Mario emigrato a Baranzate, posto terribile. Il narratore e i suoi compagni avevano aperto la sede del loro gruppo marxista-leninista, faccioni del mostro Mao e del suo braccio armato Lin Piao dappertutto. Mario imparava il loro vangelo, compreso di accuse di “revisionismo” ai compagni democratici del PCI. Mario piaceva molto, al narratore. Da tutti i punti di vista. Dopo un'estate di sesso e di comunismo, l'aveva lasciato, e aveva lasciato i marxisti. Tornando etero, borghese e tranquillo. Mario però non aveva dimenticato né l'amore di lui, né quello per la lotta armata.
Il giudice gli restituisce le lettere, e via. Sì, Mario ha già massacrato la sua scorta, lui è scampato per miracolo. Succede. Passano i giorni. Altre donne. Un nuovo amore, Esterina. Un po' troppo giovane. Il narratore sembra sereno. Sereno almeno fin quando la Tv non mostra Mario. È fuggito, post conflitto a fuoco. Morta la donna che era con lui, morti due poveri onesti carabinieri. Se lo ritrova nel letto, al posto di Ester, una manciata d'ore dopo. È il principio della fine. Fermiamoci qua.
**
Com'è Marco Tullio Giordana narratore? È descrittivo. È politico. È uno che scrive veramente molto bene, cercando a volte di nascondere la buona letterarietà parte della sua formazione, infilando qualche preziosismo (anche eccessivo) qua e là (“discingere la loro aristocratica castità” è solo un buon esempio). Questo suo primo romanzo è un'autodafé d'una generazione che ha creduto di poter essere rivoluzionaria ma ha semplicemente rovinato sé stessa, macchiandosi di responsabilità dolorose e dure da sopportare. Più dure ancora, volendo, da raccontare. Non c'è nessun intento apologetico – ci mancherebbe – ma nemmeno nessun livore. C'è una serena ma amara accettazione del proprio passato, dei propri sbagli, di quelli figli dell'ideologia e di quelli figli dell'amore. C'è – anche – una sorta di ammissione di colpa; quella d'aver voluto dimenticare tutto, il marxismo, l'omosessualità, il libero amore, il senso d'esser medico e figlio di partigiano ma nipote di fascista, per voler essere altro. Ecco: c'è una cosa che manca a questi personaggi: manca terribilmente, manca inequivocabilmente. È l'identità. Nessuno è sé stesso. Non lo è il terrorista Mario, figlio del popolo che non aveva studiato e niente aveva capito, e di Marx e Lenin aveva accettato soltanto l'invito alla violenza, e alla legittimazione della morte. Non lo è Nicolò, che non a caso non ha nome diverso dal suo pseudonimo, e non sa bene cosa stia facendo, non agisce e sembra sempre essere agito. E non lo è il giudice, allegoricamente malato di tumore come la coscienza di una generazione intera; prima rivoluzionario, poi difensore dello Stato, è schizofrenico e paradossalmente onesto, nel gran gioco di ruolo della sua vita.
Diciamo che chi ha amato “La meglio gioventù” e sofferto per il delirio brigatista della moglie di Lo Cascio, nel film, qui trova la conferma d'una meditazione antica, e forse irrisolta. La gran ferita di chi era giovane e politicizzato negli anni Settanta non riesce proprio a rimarginarsi.
Intenso, forse non bello, e doloroso. Questo sì, e molto. “Vita segreta del signore delle macchine” non diventerà mai un film, ne diventerà – ne è diventato – tanti altri. Insegnando quel che quella generazione ha capito. Che non c'è proprio niente da capire. C'è molto, ancora, da osservare, da vivere, da studiare, da interiorizzare. Con calma, e senza rancore per essere diventati vecchi senza essere mai stati adulti. Senza più sparare ad altro che non siano le nuvole. Le nuvole non sanno sanguinare, e non portano rancore. Non sanno cos'è il bene, però ridono del male. La lezione dovrebbe bastare.
EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE
Marco Tullio Giordana (Milano, 1950), regista e scrittore italiano. Il suo primo film è stato “Maledetti vi amerò”, nel 1980. Primo libro, questo (1990) seguito da “Pasolini, un delitto italiano” (1994), scritto prima di lavorare al film.
Marco Tullio Giordana, “Vita segreta del signore delle macchine”, Mondadori, Milano 2005. Prima edizione: Mondadori, 1990.
Gianfranco Franchi, marzo 2010.
Prima pubblicazione: Lankelot.
