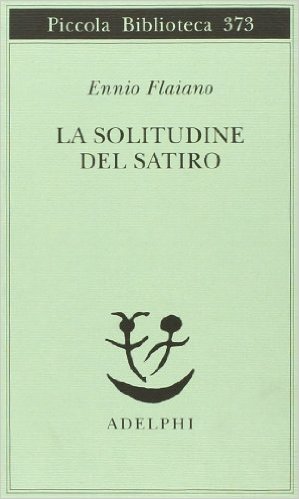 La solitudine del satiro
La solitudine del satiro
Adelphi
1996
9788845912214

“La solitudine del satiro” apparve, in prima edizione, a un anno di distanza dalla morte di Ennio Flaiano, nel 1973, a cura di Giulio Cattaneo e Sergio Pautasso. Il titolo era nelle corde dell'autore: si trovava scritto su una cartella che conteneva articoli apparsi in diversi periodi su quotidiani e periodici (cfr. Nota dei curatori, in appendice). L'opera è strutturata in tre parti: “Fogli di via Veneto”, “Taccuini d'occasione” e “La satira, la noia e la fede”, ossia una toccante intervista rilasciata due settimane prima dell'infarto che ha ucciso il sessantaduenne artista pescarese.
Nei “Fogli di via Veneto” c'è più di qualche passo di straordinario interesse, a dispetto della – consueta – natura frammentaria del testo. In prima battuta, in queste pagine si può ricostruire un (piccolo, ma romantico) spaccato della vita degli artisti romani negli anni Cinquanta e Sessanta: Flaiano raccoglie tutta una serie di aneddoti (protagonisti, Maccari, Cardarelli, Fellini, Brancati), commemora le morti (Brancati, 1954; Cardarelli, 1959; Longanesi, 1957) e descrive via Veneto e Roma com'erano prima degli anni del boom. Ne deriva il quadro di una Roma paesana, caratterizzata da una vita semplice e allegra, povera ma entusiasta, facile a difendersi col cinismo, estranea all'inquinamento, al disordine, al cemento. In seconda battuta, Flaiano racconta – paulo maiora canamus – tutti i retroscena della “Dolce Vita”: come nacque l'idea del film, quali furono le prime difficoltà, come venne scelto il nome Paparazzo.
Nell'ordine: giugno 1958, sta lavorando con Fellini e Pinelli su una vecchia idea, quella del giovane provinciale che sbarca a Roma per fare il giornalista. “Fellini vuole adeguarla ai tempi che corrono, dare un ritratto di questa 'società del caffè che folleggia tra l'erotismo, l'alienazione, la noia e l'improvviso benessere. È una società che, passato lo spavento della Guerra Fredda e forse proprio per reazione, prospera un po' dappertutto. Ma qui a Roma, per una mescolanza di sacro e di profano, di vecchio e di nuovo, per l'arrivo massiccio di stranieri, presenta caratteri più aggressivi, sub-tropicali. Il film avrà per titolo 'La dolce vita' e non ne abbiamo scritto ancora una riga” (pp. 7-8).
Quindi: settembre 1958. “In tre mesi, al mare, abbiamo finito di scrivere 'La dolce vita' e cominciano i soliti guai. Il produttore rifiuta di fare il film. Ha dato in lettura il copione a quattro o cinque critici che ora ci guardano desolati e scuotono la testa: la storia è scucita, falsa, pessimista, insolente: il pubblico invece vuole un po' di speranza. 'No' diceva Elliot 'il pubblico vuole soltanto un po' di spogliarello, ma quel che conta è ciò che riusciamo a fare alle sue spalle, senza che se ne accorga'” (pp. 15-16). Le cose andranno meglio.
Paparazzo? “Per questo fotografo non sappiamo che inventare: finché, aprendo a caso quell'aureo libretto di George Gessing che si intitola 'Sulle rive dello Jonio' troviamo un nome prestigioso: 'Paparazzo'. Il fotografo si chiamerà Paparazzo. Non saprà mai di portare l'onorato nome di un albergatore delle Calabrie, del quale Gessing parla con riconoscenza e con ammirazione. Ma i nomi hanno un loro destino” (p. 14). E pensare che oggi è diventata una parola a sé stante, paparazzo. Pazzesco.
Flaiano, in quegli anni, era 'abbastanza vecchio per ricordare le prime dimissioni di Enrico De Nicola e abbastanza giovane per poter passeggiare in via Giovanni Giolitti' (p. 53). L'ambiente letterario è davvero molto povero, il cinema sembra servire a tenere in vita – a livelli dignitosi – molti scrittori (come Mario Soldati, come lo stesso Flaiano, ex giornalista) che altrimenti sarebbero campati di stenti, come il povero vecchio Cardarelli. È curioso scoprire che nel 1962 in Italia nasceva una nuova moda: quella delle presentazioni dei libri. Sentite come la racconta EF: “Questa moda di presentare i nuovi libri, come i re dal balcone presentavano alla folla il principe ereditario appena nato, è recente: pochi anni fa avrebbe coperto di ridicolo gli autori; oggi si accetta come una forma di persuasione palese, un postulato della cultura di massa” (p. 31). In effetti è una moda che ha attecchito sino a normalizzarsi; peccato non abbia mai saputo conquistare numeri da cultura di massa, nemmeno nel caso degli eventi tenuti per celebrare le opere dei grandi autori stranieri.
C'è qualcosa di immortale, in questa prima sezione del libro. Non parlo della scrittura di Flaiano, parlo dell'aspetto storico-letterario, documentaristico, antropologico. È stato emozionante scoprire certi dietro le quinte della “Dolce vita” di Fellini, scritti “nel momento”; più ancora – ma forse è una deviazione personale, è il mio culto per la perduta grande società letteraria Romana – ritrovare certi nomi e riscoprirli amici, in quotidiano contatto. Ma il massimo splendore documentaristico si nasconde in un passo imprevedibile: è il vecchio Cardarelli a parlare, raccontandoci fatti del 1911. 1911? 1911. Sentite qua: sognava un film su cosa accadde in quell'anno, perché...
“(...) è il cinquantenario dell'Unità nazionale e a Roma si preparano grandiosi festeggiamenti, l'esposizione internazionale di Valle Giulia, la mostra etnografica regionale... si inaugura il monumento a Vittorio Emanuele, il ponte Vittorio Emanuele, il Palazzo di Giustizia, insomma tutta la paccottiglia architettonica possibile. Si inaugura anche il giardino zoologico. Si congiungono il Pincio e Villa Borghese, si congiungono i palazzi capitolini con gallerie di cartapesta... e sempre con la cartapesta si fa un padiglione a piazza Colonna, dove è ora la Galleria. C'erano caffè, trattorie, un cinematografo. Qui, a via Veneto, si inaugura l'Excelsior. Dove siamo seduti ora, c'era una latteria. A Valle Giulia trionfano Zuloaga, Franz von Stuck, Mestrovich, Sartorio, Micheletti, Klimt, Sergent e altri pompieroni. È l'apoteosi e la liquidazione di tutto il pompierismo europeo, il trionfo della cartapesta e del cemento armato floreale. Non si può fare un film con tutti questi trionfi? […] Tutti questi festeggiamenti vanno all'aria, perché i giornali francesi spargono la voce che a Roma c'è il colera. Tutte le proteste sono inutili. A Roma non viene nessuno, il deficit è enorme. […] Non si può fare un film di trionfi mancati e disgrazie?” (p. 26). Mi sembra una grande idea ancora adesso, a dirla tutta.
**
La seconda parte, quella dei “Taccuini d'occasione”, è più ripetitiva e prevedibile, meno brillante, più caotica. Emergono aspetti interessanti; l'estraneità dichiarata e reiterata a fascismo, comunismo e democrazia cristiana; il disprezzo nei confronti dei comunisti per i Fatti di Ungheria, per il cinismo degli intellettuali rossi, per L'Unità che insultava i morti di Budapest e per Togliatti che parlava dei magiari come di “teppisti controrivoluzionari” (p. 60). Al solito, qua e là c'è qualche boutade degna di memoria, il sarcasmo sul concetto “il medium è il messaggio” (quindi, bisogna leggere il postino, non le lettere: p. 156), la leggenda urbana dell'impossibile infinito di Leopardi (a scuola: “leopardare”, p. 175), la dichiarazione d'appartenenza a una “minoranza silenziosa” (p. 206: appartiene a quei pochi che non hanno più nulla da dire e aspettano), l'imbastita degli arabeschi (“In Italia la linea più breve tra due punti è l'arabesco. Viviamo in una rete di arabeschi”, p. 207). C'è qualche ironia sulla mania di fare foto in vacanza (“per avere la certezza di essere vissuti”, sospetta a p. 13) e sulle narratrici italiane (p. 17). Flaiano si lascia leggere, sorridendo ma mai ridendo a crepapelle; è sempre equilibrato e composto nella sua ferocia di satiro, mai offensivo, mai scurrile. Questo va detto a suo merito, aveva una cattiveria pari alla sua educazione. Il suo stile è aristocratico anche per questo; afferma cose enormi, ma senza sembrare prepotente o presuntuoso. Nell'intervista finale, afferma tre cose estremamente interessanti. Vediamole nel dettaglio.
La prima: a proposito della satira in Italia. “La satira in Italia non è molto coltivata, per dei motivi che forse possono ritrovarsi nella estetica di Croce la quale considera la satira come la cenerentola della letteratura. Qui regna il culto dell'arte e della poesia in senso assoluto; ognuno scrivendo ha per modelli 'La divina commedia', 'I promessi sposi', 'I Malavoglia', secondo le proprie intenzioni e ideologie e nessuno si guarda attorno per capire i lati assurdi, non diciamo ridicoli, ma comunque sfrenati della vita che ci circonda; farlo è mettersi in una posizione di isolamento, ma questo a me non dispiace” (p. 215).
La seconda: a proposito della sua ammirazione per Bellow. Lusingato per essere stato accostato ai suoi scritti, sbotta: “(...) è un grande scrittore; io mi considero modesto, nei suoi confronti, e la mia modestia arriva anche all'invidia; e devo dirle infatti che uno dei suoi libri, quello che mi è piaciuto di più, Herzog, non l'ho voluto finire, appunto perché sentivo che era un mio libro e che se avessi avuto io questa idea l'avrei scritto, malissimo, ma lo avrei scritto io. Certo Bellow ha su di me il vantaggio che crede ancora alla serietà della solitudine, dell'ignoto e della morte. Io credo alla solitudine, temo l'ignoto e sono terrorizzato dalla morte” (p. 218)
La terza: a proposito del suo amore per i Padri Latini. “Io forse non ero di questa epoca, non sono di questa epoca, forse appartengo a un altro mondo; io mi sento più in armonia quando leggo Giovenale, Marziale, Catullo. È probabile che io sia un antico romano che sta qui ancora, dimenticato dalla storia, a scrivere delle cose che gli altri hanno scritto molto meglio di me, cioè, ripeto, Catullo, Marziale, Giovenale” (p. 228)
… che forse andrebbe letto in forma di disprezzo per gli scrittori italiani contemporanei, che sia per senso di superiorità o per irritazione di essere salutato come cinematografaro, da qualcuno, e quindi come altro dai letterati: in effetti, guarda un po'?, nella stessa intervista l'Antico Romano scrive che gli scrittori che descrivono meglio l'Italia – e che sanno capirla... - sono gli stranieri. Segue una parata di titoli tutti rimossi o quasi, quarant'anni dopo. Sentite qui: “Il più bel romanzo italiano (!, N.d.R.) è 'Monteriano' scritto da Forster nel 1910. Non parliamo di 'Old Calabria', di 'South Wind', scritti da Norman Douglas, non parliamo di 'Foglie secche' di Huxley, non parliamo di Lawrence. Loro hanno visto l'Italia per quel che è, un insieme di contraddizioni storiche, psicologiche, che vengono dalla mitologia e che fanno di questo popolo un unicum certe volte ridicolo appunto per le sue contaminazioni” (p. 224).
Provocatorio, fino all'ultimo. Ma da leggere, assolutamente, almeno per i “Fogli di via Veneto”, in questa edizione; per quei fogli, e per questa intervista.
EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE
Ennio Flaiano (Pescara, 1910 – Roma, 1972), giornalista, sceneggiatore, critico teatrale e cinematografico, romanziere italiano.
Ennio Flaiano, “La solitudine del satiro”, Rizzoli, Milano 1973. A cura di Giulio Cattaneo e Sergio Pautasso. Oggi, Adelphi, 1996.
Approfondimento in rete: Wiki
Gianfranco Franchi, agosto 2009.
Prima pubblicazione: Lankelot.
