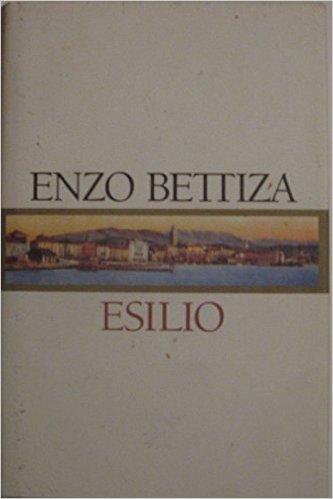 Esilio
Esilio
Mondadori
1999
9788804459439

Già Illirica, Romana, Bizantina, Ungherese, Veneziana, per breve tempo Napoleonica, poi Austriaca e Jugoslava, la Dalmazia – oggi parte della Croazia, e salutata impropriamente come “Croazia del Sud” – ospitava una comunità italiana, un’aristocratica borghesia mercantile, non solo nell’enclave di Zara (oggi Zadar), a maggioranza assoluta etnicamente e culturalmente italiana, retta dall’Italia dal 1919 al 1947, ma anche – ad esempio – nelle città di Sebenico (diede i natali a Niccolò Tommaseo), Ragusa (oggi l’ex Repubblica Marinara, patria di Franco Sacchetti, viene chiamata Dubrovnik), Spalato, cara a Diocleziano.
Da Spalato viene uno dei maggiori intellettuali e giornalisti italiani del Novecento, Enzo Bettiza, che ama definirsi dalmata di lingua italiana. Questo suo “Esilio” è un doloroso memoriale, a metà tra saggistica e biografia romanzata, scritto negli anni dell’ultima guerra dei Balcani, quando diversi popoli slavi si batterono contro la drammatica avanzata serba, che prevedeva pulizia etnica e damnatiomemoriae, sino all’intervento americano. Bettiza, dopo anni di silenzio sulla sua vita pre-esodo, complice una sorta di rimozione ben indagata nel libro, racconta tutto; alterna pagine di interpretazione delle ragioni e dei torti dei serbi nella recente guerra a memorie d’infanzia e giovinezza, spiega cosa significava essere bilingui e come veniva accolta l’aggressione fascista nei tristi giorni della Seconda Guerra Mondiale, racconta la storia d’una terra e d’un popolo che la storia ha snaturato; la presenza italiana è stata sostanzialmente spazzata via. E ricorda – a questo proposito – l’atrocità e la gratuità del bombardamento angloamericano a Zara, la nostra Dresda: suggerendo che serviva a fare piazza pulita dell’ultimo avamposto italiano dalmata in quello che sarebbe divenuto, per una manciata di decenni, lo Stato Jugoslavo di Tito. Ma torniamo alla genesi dell’opera, su Zara discuteremo ancora.
I “truci fragori” dello “stupro culturale” sferrato dai serbi contro Ragusa, in quel periodo, avevano “acceso quasi per sintonia colpevole dentro di me una sorta di rimorso e di pentimento. Quei colpi di cannone e di mortaio non mi facevano sentire in regola né con la memoria né con la coscienza. Io medesimo, al di là di Ragusa, non avevo fino allora perpetrato in silenzio un mio privatissimo eccidio mnemonico nei confronti di Spalato e di Zara, di Salona e di Traù, di Sebenico e dell’isola di Brazza in cui, bambino e ragazzo, avevo soggiornato per tante estati marinare?” (p. 9): è autentica pulizia culturale, quella intentata dai serbi, per distruggere la storia di una delle più belle città dalmate.
La guerra tra serbi e croati stava offendendo, sconvolgendo e mutilando la Dalmazia di Bettiza, quella “lingua di terra carsica e frastagliata”, composta da centinaia di isole e isolotti, dalla tradizione cosmopolita e poliglotta: una Dalmazia sentita come “nazione incompiuta”, perché come ricordava il gran filologo di Sebenico “Badate che la Dalmazia è più lontana dall’Istria di quanto Malta lo sia dall’Inghilterra” (p. 6), quindi le semplificazioni non sono gradite, il messaggio arriva chiaro. I dalmati sono (erano? erano) una razza matta, con manie di lusso e di grandezza: ostile alle ostentazioni sentimentali, piena di ironia e di voglia di vivere (bene). Antico era il sogno d’una Stato autonomo, né croato né italiano, con patrocinio e governo in stile asburgico.
A supporto e sostegno, tutti i ricordi dell’erede dell’aristocratica famiglia Smacchia Bettiza: dalla balia serba che gli raccontava il martirio cristiano per mano ottomana, in Kosovo, alle ore di lezione di serbocroato nelle scuole italiane; dalla ricca e splendida cucina, fondata per espressioni del territorio e superbe contaminazioni europee, al rapporto paritetico o quasi tra servi e padroni; dalla naturalezza della diglossia di chi, pure di “opzione italiana” post-caduta Absburgo e fondazione Regno Jugoslavo, in Dalmazia, non dimenticava che sua madre era slava, la sua balia era serba, i suoi compagni croati e serbi, e che il dialetto veneto (non il dalmatico, attenzione: quella era lingua romanza, estinta) s’accompagnava senza difficoltà al serbocroato, in qualsiasi contesto. Il padre, mai studente di scuola italiana, era pura espressione della Dalmazia austriaca: la sua italianità era più culturale che etnica, parlava correttamente serbocroato, tedesco, veneziano coloniale; eppure aveva scelto l’opzione italiana, post 1918, ritrovandosi “italiano all’estero” in casa sua, dove era nato. È un paradosso che figlia scissioni gravi, ma non è inedito, purtroppo, tra Trieste, Istria, Fiume e Dalmazia: quale che fosse l’etnia (o “l’etnia principale”, o la “cultura principale”) del cittadino, nel Novecento, era un’ipotesi plausibile quella di diventare straniero a casa propria. Riuscite a immaginarlo? Riuscite a capirlo? Estero = Dove sei nato e dove sono nati, magari, tuo padre e tuo nonno. A un tratto, era così.
Comunque: “La mamma, anche se conosceva piuttosto bene il veneziano coloniale, preferiva parlare con i figli in serbocroato; il papà invece, anche se, avendo fatto le ‘reali’ croate, conosceva e scriveva alla perfezione il serbocroato, preferiva usare con noi l’antico dialetto locale di derivazione veneta. Genitori dunque molto simili, perfino nella loro duplicità e intercambiabilità fonetica, alla lingua bifida, imbastardita, quasi esperantesca, che adoperavamo nei nostri giochi e nelle nostre chiacchiere infantili. Confusamente intuivamo di non essere né italiani né slavi completi” (p. 49).
Questo il vivace clima culturale all’interno d’una delle più antiche famiglie italiane di Spalato, là da cinque generazioni, espressione della migliore borghesia cittadina. Sempre sulla diglossia, campionerei un altro passo interessante tratto dal capitolo dedicato alla formazione ginnasiale a Zara del giovane Bettiza, innamorato della sua insegnante zaratina, Consuelo: che partì volontaria per l’Africa non perché “fascista”, ma perché “nazionalista sentimentale”. Durante un’interrogazione l’allievo va in crisi, e…
“Senza capire quello che le dicevo, le farfugliavo di corsa tra una pausa e l’altra, forse in italiano, forse in latino, mentre dentro di me inveivo in serbocroato contro il mondo e contro Consuelo. Dovevo con grande sforzo trattenermi per non bestemmiare a piena voce, nell’aula di un ginnasio italiano, il nome slavo di Dio” (p. 99) – questo passo mi sembra dia chiara testimonianza di come un giovane di Spalato pensava e si sentiva in una scuola italiana di Zara, nel Liceo Classico Gabriele D’Annunzio.
Zara, divenuta “spettro senza corpo e senza volto” (p. 171) dopo il massiccio esodo italiano e l’infame trattamento yankee e limey, è oggi “il fantasma di sé stessa: uno squallido e cariato borgo periferico dell’Adriatico orientale, fino a ieri strozzato dall’assedio dei serbi in armi della limitrofa Krajina morlacca” (p. 146); sparito il florido emporio veneziano, sparito lo stile patrizio e mercantile, sparito il cosmopolitismo, scappati quasi tutti gli italiani. Finito tutto. E Spalato? “La millenaria, suggestiva personalità archeologica (…) è stata deturpata dall’escrescenza di bituminosi e orrendi grattacieli di tipo brasiliano; pure la sua originalità umana, la sua vivacità culturale e cosmopolita, sono state sommerse e cancellate da una vera e propria eruzione di plebi semibarbare, calate con la dirompente violenza della lava dalle montagne dinariche. Basti dire che nel 1945 io avevo lasciato una città di appena 40mila abitanti, diventati oggi, non certo per spinta demografica endogena, 250mila (…)” (p. 147) – e gli autoctoni, slavi o italiani, sono considerati come razza di stambecchi in via d’estinzione. Proprio così scrive l’autore.
Bettiza denuncia il male dei risentimenti nazionalisti e della confusione successiva alla caduta dell’Austria: individua nel nazionalismo (non nel patriottismo, questo è interessante) una delle cause del secolo dei massacri, e degli esodi italiani. Esodi atroci, perché “(…) l’esilio prolungato nello spazio e nel tempo, esilio senza ritorno, aggravato dal vagabondaggio dispersivo in altri mondi, possiede una rara quanto perforante facoltà distruttiva: lentamente carbonizza tutto ciò che siamo stati altrove, recide i vincoli di sangue, spegne i ricordi, fa impercettibilmente tabula rasa del passato” (p. 18).
La responsabilità del disastro dalmata è fascista. L’Italia che sbarca è violenta, aggressiva, razzista e ignorante; aggressioni e umiliazioni contro la maggioranza croata di Spalato sono all’ordine del giorno, la repressione è odiosa. Bettiza parla di sopraffazioni subculturali, della vergogna per la condotta di quei “connazionali”, per la loro stupidità e la loro violenza (cfr., ad es., pp. 297-299). Inevitabilmente, scattano rappresaglie; ampiamente giustificate. Non negli ultimi eccessi e nei risultati finali, sia chiaro: non tutta la cittadinanza, dimostra Bettiza, era fascista o almeno concorde con il fanatismo tricolore. Tutt’altro. Non è bastato. Enzo Bettiza mai fu avanguardista, mai partecipò a un’adunata. Istintivamente, deplorava l’arroganza di chi, entrando a Spalato, imponeva di cantare “giuriam sull’onore dalmata che fra noi non esisterà più un croato!” (p. 287): conseguenza è stato perdere i dalmati italiani, con pochissime, decimali eccezioni (Zara).
La questione del Kosovo era, nel momento della scrittura del libro (1994-1995), eccezionalmente interessante: difficilmente potevamo avere chiara idea di cosa significasse per i serbi, vittime com’eravamo della nostra propaganda e dell’impressione drammatica di quelle stragi. Bettiza spiega per bene come stavano le cose: per i serbi, per la loro identità di popolo e di nazione, era fondante il ricordo della battaglia dei principi slavi e cristiani contro l’invasore turco; la tragedia del 1389 valeva e vale, nel loro immaginario, come la nostra battaglia di Poitiers nel 732. Ecco quindi che il Kosovo era diventato un luogo mitico, dalla straordinaria importanza simbolica; ecco quindi illustrate le origini delle straordinarie rivalità con le etnie islamiche, albanesi o bosniache. I serbi si sentivano e si sentono guardiani della civiltà cristiana. Bettiza scardina le tesi dell’albanese Kadarè, che tende a ridimensionare quella battaglia, facendo il gioco del suo popolo. Chiaramente, lo scrittore di Spalato denuncia gli abomini serbi, dalle fosse comuni alle straordinarie distruzioni delle moschee in avanti; individua una strategia comune e nella lotta anti-islamica, e nell’aggressione alla Dalmazia: è, appunto, la “pulizia culturale” unita a quella etnica, possibilmente.
Bettiza legge il rapporto tra serbi e montenegrini, invece, così: fra loro “s’è formata nei secoli, più che un’intimità profonda, una sorta d’osmosi metastorica. La comune lingua e religione ortodossa, il comune alfabeto cirillico, la comune mitologia guerresca, esaltata dalla lunga fraternità d’armi contro i turchi e gli austriaci e, infine, le comuni speranze messianiche riposte nel grande protettore russo, hanno finito per conferire ai due popoli una singolare identità gemellare (…)” (p. 28). Oggi, come sapete, i due popoli si sono pacificamente separati. Il sogno della “Grande Serbia” s’è sgretolato.
Responsabile dell’ultima guerra è chiaramente il comunismo. “(…) è l’ultimo stadio di un comunismo senile che, raschiato il barile, cerca di procurarsi una seconda, orrenda giovinezza con gli estrogeni mefistofelici del nazionalsocialismo (…). Insomma: la sindrome di Faust che rivive in forma criminale e rozza, subideologica, non più metafisica, nel corpo di un comunismo svuotato da un ininterrotto sperimentalismo e approdato infine alla sterile impotenza della senilità” (p. 145) – già, dopo aver giocato al piccolo ingegnere sociale, trapiantando etnie diverse qua e là, ponendole in contrasto con le altre, imponendo convivenze impossibili, cancellando storie e tradizioni.
Qual è quindi la lezione di Bettiza? La memoria, in prima battuta, e il rispetto per un popolo oggi fantasma, e per il suo complesso e qui decifrato dna. La speranza dell’europeismo come nuova incarnazione dell’antico impero austriaco, e della sua tolleranza. Del resto: “Segnato da iniziali influssi serbi nell’infanzia, poi italiani nella pubertà, quindi croati nell’adolescenza, ai quali dovevano aggiungersi più tardi innesti germanici e russi, ho lasciato concrescere poco per volta in me multiformi radici culturali europee; non ho mai dato molto spazio alla crescita di una specifica radice nazionale” (p. 286).
Un libro da regalare ai giovani dalmati di oggi, croati. E agli eredi degli esuli dalmati; due furono gli esodi dalla Dalmazia, uno post 1918 (nascita regno jugoslavo, con l’eccezione di Zara) e uno post 1945 (fine di Zara, e sostanzialmente della libertà d’essere dalmati italiani). Ci furono prima esodi più verso Zara che verso l’Italia; infine, purtroppo, non rimase alternativa diversa dal Belpaese. Con quello che implicava.
Un libro che dovrebbe accompagnare le lezioni di Storia nei Licei e nelle Università, in generale, e che non dovrebbe mancare in nessuna casa in cui si parli lingua italiana o dialetti italiani. Per non dimenticare.
Omaggio e saluto i dolorosi e insanguinati ricordi d’un uomo onesto.
EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE
Enzo Bettiza (Spalato, 1927 - Roma, 2017), giornalista e scrittore dalmata di lingua italiana, come ama definirsi. Ha fondato e diretto “Il Giornale” assieme a Indro Montanelli, fino al 1983.
Enzo Bettiza, “Esilio”, A. Mondadori, Milano 1996.
Approfondimento in rete: Wikipedia
Gianfranco Franchi, luglio 2007.
Prima pubblicazione: Lankelot.
Fondamentale memoir dell’artista spalatino Enzo Bettiza
