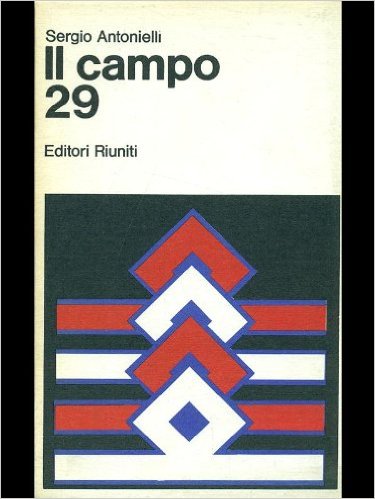 Il campo 29
Il campo 29
ISBN Edizioni
2010
9788876381461

Storia d'un italiano prigioniero di guerra in un campo inglese in India; della disfatta del nostro esercito e del nostro popolo, e della dolorosa battaglia per la difesa dell'identità, della memoria e dell'essenza di ogni individuo; storia della contrapposizione viva tra chi allora riconosceva la patria nel fascismo, e chi invece nel suo rovescio logico, ossia la repubblica parlamentare; storia d'una vicenda oscura dei nostri soldati, altrimenti estranea alla letteratura. Questo è, in buona parte, “Il campo 29”, romanzo di Sergio Antonielli (1920-1982) scritto nel 1947 e originariamente pubblicato nel 1949; oggi nuovamente a disposizione del pubblico nella collana “Novecento italiano” delle ISBN di Milano, collana destinata a venire incontro ai gusti di un pubblico di italianisti e di letterati sempre entusiasta di apprezzare nuovi recuperi di qualità, incomprensibilmente trascurati dai grandi gruppi editoriali.
“Raramente abbiamo avuto di fronte un documento letterario di tanta forza e di tanta dolorosa passione”, ha scritto Giacinto Spagnoletti. Secondo Edoardo Esposito, il romanzo “ci parla non della guerra guerreggiata, ma di quella perduta; ci parla degli italiani a El Alamein, ma solo per dire che era stato un monologo inglese, d'aerei, carri, e carri, e cannonate e che le armi italiane 'dopo le prime ore di combattimento non erano servite più'. E da qui comincia la storia del protagonista Massimo Venturi, il quale 'era partito per un'avventura, se si vuole, quando già i convincimenti giovanili gli si spegnevano, ma pensando che in guerra o si muore o si torna o si resta feriti. Invece...'” (p.314). Invece s'era ritrovato tra le migliaia di ufficiali italiani internati nei campi di Yol, ai piedi della catena dell'Himalaya; e là avrebbe passato anni interi della sua vita. Badando bene a non finire al campo 29.
“I campi erano quattro: 25, 26, 27 e 28. Il 26 aveva due ali in più, pei colonnelli. Poi c'era l'ospedale coi suoi reparti: denti, medicina, chirurgia, tbc e neuro. E infine c'era il campo 29. Il quale era la metafisica. Quando uno moriva, si diceva: 'È andato al 29'. Veramente, quando uno moriva, andava al camposanto. Piccolo piccolo, lì vicino, c'era un camposanto dove andava il morto accompagnato da quattro persone e da un cappellano italiano con una gran barba grigia fino a mezzo petto. Lo calavano nella fossa, dopo che lo avevano frugato per bene all'ospedale, e mentre calava saliva la bandierina delle disgrazie nostre, instancabile” (p. 209).
India. “Con i contadini e i pastori indiani” - racconta Antonielli nella prefazione - “avevamo avuto soltanto fugaci contatti, resi difficili da un preciso divieto, dalla loro fondamentale diffidenza e da tante altre ragioni, non ultima delle quali il traffico degradante, sostanzialmente coloniale, che con gli indigeni più corruttibili avevano instaurato i mercanti e i loro simili” (p. 20). Morale della favola, dell'India Antonielli riporta un'immagine indiretta, la sensazione d'aver assistito a un grande spettacolo allestito coi rottami di una “civiltà scomparsa sullo scenario di una maestosa natura”.
Luminosità del cielo, colori, “curve di fiumi” ricordano l'Italia: sono colori più intensi, “ma della medesima qualità”; il cielo impressiona, “profondo, più profondo, (…) del tutto lontano dallo spietato nitore a fondo bianco che sovrasta l'Egitto, la Grecia” (p. 32). Dalle baracche, al di là del filo spinato, l'occhio “spaziava sulle colline e giù fino all'orizzonte dove brillava al sole il fiume che pareva quattro fiumi (…). E sotto a tutto una discesa di sassi, grandi e piccoli, ovali, rotondi, piatti, d'un grigio biancastro che al sole faceva dolere gli occhi, la cui distesa era ogni tanto interrotta da canaletti di scolo” (p. 96).
La natura non sempre riesce a risollevare il morale del soldato sconfitto, interiormente disfatto: “Sidi Barrani, Derna, Tobruk, Capo Matapan, Punta Stilo, Albania, Grecia, Amba Alagi, tutti nomi di sconfitte”: guarda intorno a sé, tra i soldati, e “quella folla di cappotti verdi e volti di terra sentiva il peso della disfatta” (p. 80).
La posta arriva irregolarmente, una volta a settimana: lettere di qualche mese prima mescolate a lettere vecchie d'almeno un anno (p. 146); ricevere qualsiasi notizia serve a spezzare la terribile routine della prigionia in un campo di concentramento, serve a scuotere la fantasia assopita: a non pensare soltanto alle donne lontane o alle amanti assenti, ma a un futuro diverso da costruire, nel tempo. Per il resto, i soldati hanno un circolo in cui ritrovano l'Italia – e s'illudono di ritrovare la famiglia (p. 37); e questo spezza almeno in parte la ripetitività di tutto, assieme a qualche lavoretto artigianale (la costruzione d'un mappamondo, per dire) e a qualche messinscena. Quando vengono chiamati per le adunate, ogni giorno, in loro invece “c'è un che di fiacco e triste, che dava all'allineamento militaresco una pesantezza funebre, ma più sconsolata ancora, da gente che torni a casa da un funerale e stenti a ritrovare il passo consueto” (p. 39). Quando gli inglesi permettono le passeggiate (mezza giornata, o tutta, restando comunque dalle parti dei campi), ci si impegna a non entrare in nessuna casa, a non parlare con estranei, a non danneggiare i beni dell'impero inglese (p. 151); si esce, e si ritrova un pizzico di pace, e di autonomia. Un pizzico soltanto.
Si torna indietro e non si può non guardare il reticolato. Ci si sente esclusi totalmente dal mondo, esplodono rabbia, frustrazione, senso d'impotenza: una rabbia, scrive Antonielli, “che stava sempre sul punto di scoppiare e non scoppiava mai, come certi fiammiferi inumiditi che, fregati, fremono per qualche secondo e non sbocciano a fiamma e poi tacciono, nerastri e consunti” (p. 46). Quello è il male peggiore, “la febbre del filo spinato”: dopo qualche anno si rischia di impazzire. Non importa che il clima sia buono e l'alimentazione accettabile. Non basta. Serve un'enorme forza interiore, una instancabile dedizione alla speranza.
Nei quattro campi gli italiani, presto, si dividono in due gruppi: fascisti e antifascisti (p. 181). In mezzo, i soliti egoisti o i soliti indecisi – disprezzati da entrambe le parti. “Quando tutto è finito può sembrare assurdo che i prigionieri si fossero divisi in due schiere: che bisogno avevano di odiarsi quei disgraziati segregati dal mondo? Ma se si pensasse sempre con la mentalità del quando tutto è finito, le guerre non si farebbero mai, e tanto meno le guerre civili. Invece gli italiani, in quella ventata di follia, trovarono anche il tempo di fare una guerra civile, e magari un giorno si dirà che proprio loro furono il popolo più serio, che ebbe il coraggio di scompaginarsi persino in seno alle famiglie per la lotta di due principi che stavano insieme nell'animo d'ogni cittadino di questo mondo” (p. 181). Questo commenta il narratore di Antonielli; qua e là, non mancano osservazioni relative al patriottismo dei fascisti e alle loro prove di fedeltà al regime, nonostante tutto, che il narratore non capisce, non gradisce, non condivide e non approva affatto.
**
Antonielli, socialista affascinato dagli annosi dibattiti sul neorealismo, si risolse a scrivere un libro che giudica “non diario, né romanzo, né documento”: ma “sorta di traduzione della realtà”. Ecco che ne deriva una molto poco credibile e spesso fastidiosa terza persona, artificio un po' grossier per non assumersi eccessive responsabilità. Mi sembra un limite non marginale, senza dubbio figlio della pestilenza ideologica dell'epoca. Ma “oggi l'aggettivo documentario mi sembra una lode. Il neorealismo dei vecchiotti romanzi riverniciati a nuovo è scomparso, con tutti gli equivoci che lo accompagnarono: primo tra i quali il populismo di bassa lega. Quello che resta è lo sforzo di penetrazione della realtà” (p. 10); e questo, naturalmente, è un nobile sforzo. Peccato sia accompagnato da un materialismo fastidioso e niente affatto condivisibile (p. 60), che distacca, a volte, il lettore dal desiderio di abbracciare chi tanto ha sofferto per il proprio popolo, e il proprio Paese.
Antonielli è leziosetto nelle descrizioni, non sempre buone; l'espressione del pensiero si fa non articolata, ma mezza rococò, perifrastica, frivoletta, ultraaggettivale, non estranea a qualche ridondanza retorica. Si vede che cercava di rappresentare qualcosa di impossibile – ossia, ciò che è reale, e quel che è vero. Non basta aggettivarla o specificarla – la realtà è un mistero. Meno misteriosa, adesso, è la vicenda della prigionia di tanti nostri ufficiali, negli anni atroci e assurdi della Seconda Guerra Mondiale. Questo rimane, questo conta, questo si deve andare ad approfondire. A partire, magari, proprio da qui.
EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE
Sergio Antonielli (Roma, 1920 – Monza, 1982), scrittore e critico letterario italiano.
Sergio Antonielli, “Il campo 29”, ISBN, Milano 2009. Postfazione e nota biografica di Edoardo Esposito. Con una nota dell'autore. Collana: Novecento Italiano.
Prima edizione: “Il campo 29”, Edizioni Europee, Milano 1949.
Gianfranco Franchi, gennaio 2010.
Prima pubblicazione: Lankelot.
Nuova edizione di un romanzo dal fortissimo valore documentaristico…
